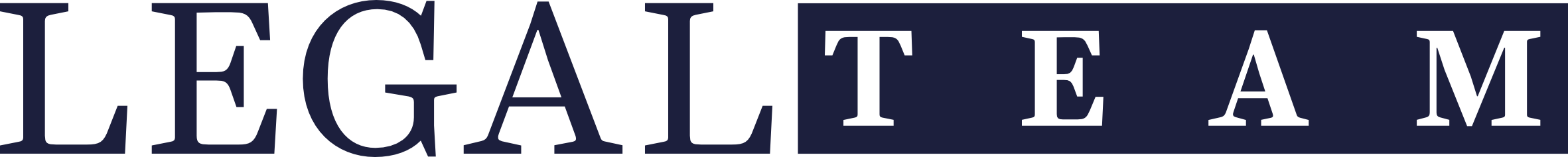Sanatoria giurisprudenziale: anche la Puglia getta la spugna
 Sanatoria giurisprudenziale: anche la Puglia getta la spugna
Sanatoria giurisprudenziale: anche la Puglia getta la spugna
Più volte abbiamo avuto occasione di parlare dei diversi tentativi regionali di “allargare le maglie” dell’accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 37 del Testo Unico dell’Edilizia, attraverso la normazione della cd. sanatoria giurisprudenziale. Tentativi, tutti, naufragati.
Ciononostante, anche la Regione Puglia ha cercato di muoversi in questo senso. Vediamo come.
I. La “legge di stabilità regionale 2024”
Come spesso accade a livello statale, anche nelle diverse regioni d’Italia, il momento dell’approvazione della cd. “legge di bilancio” è quello in cui trovano “sfogo” le più variegate richieste politiche: norme che, nel contemperamento delle ben più importanti esigenze quotidiane, non troverebbero mai alcun appoggio, in quella sede vengono spesso approvate a mo’ di “contentino”.
Il che è proprio quanto accaduto anche in Puglia, allorquando il Consiglio Regionale, in seno alla Legge Regionale n. 37 del 29 dicembre 2023, ha approvato (tra gli altri) l’art. 63, emblematicamente rubricato “accertamento di conformità”. Secondo tale norma, in particolare
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppur in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, dello stesso, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
Il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per la regolarizzazione dell’immobile, entro centottanta giorni dalla presentazione della istanza.
II. La sanatoria giurisprudenziale in salsa pugliese
Il Governo centrale ha immediatamente messo sotto la lente d’ingrandimento la norma, onde vagliarne la legittimità costituzionale, ed ha evidenziato due “punti critici”: da un lato, la possibilità di una “sanatoria condizionata”, subordinata cioè alla realizzazione di “ulteriori opere”; dall’altro, la positivizzazione della cd. “sanatoria giurisprudenziale”.
Tale istituto è stato più volte dichiarato incostituzionale, perché deroga al principio della “doppia conformità”: salvo i casi straordinari del cd. “condono” (ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003), un abuso può essere sanato solo se l’intervento edilizio è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.
Per contro, la giurisprudenza (soprattutto penale) ha talvolta consentito delle sanatorie (ma sarebbe meglio parlare di “tolleranze”) di interventi edilizi conformi alla sola disciplina edilizia vigente; e nel suo solco hanno provato a muoversi diverse regioni, infrangendosi però contro lo scoglio della Corte Costituzionale.
Nello specifico, è stato chiarito che “spetta al legislatore statale la scelta sull’an, sul quando e sul quantum della sanatoria, potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l’articolazione e la specificazione di tali disposizioni” (Corte Costituzionale n. 232 del 8.11.2017), con la conseguenza che il principio della cd. doppia conformità, proprio perché proveniente dal legislatore statale, non può essere in alcun modo derogato dalle regioni.
III. La minaccia di ricorso del Governo ed il “passo indietro” regionale
Proprio perché il citato art. 63 si pone in chiara violazione delle superiori norme nazionali (artt. 36 e 37 DPR 380/2001), il Governo ha immediatamente minacciato la Regione Puglia di impugnare tale norma dinanzi alla Corte Costituzionale (facoltà riconosciuta dall’art. 127 della Costituzione).
Da qui la decisione dell’organo legislativo regionale di fare un passo indietro.
Sfruttando, dunque, la prima occasione utile (ossia un progetto di legge recante modifiche alla LR 26/2020) è stato deciso di abrogare l’intero articolo 63. Nello specifico, all’adunanza del 12 marzo 2024, è stato approvato l’emendamento n. 5 nella cui relazione, brevemente ma in maniera oltremodo esplicita, si legge che “Il presente emendamento è finalizzato ad adempiere all’impegno assunto col Governo nazionale per assicurare l’adeguamento delle disposizioni regionali in oggetto alle vigenti norme di legge nazionale ed evitare un contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale”.
IV. Conclusioni
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Puglia dell’intero corpus normativo, e quindi della definitiva abrogazione dell’art. 63, già è possibile leggere dichiarazioni di alcuni esponenti politici che chiedono a gran voce una re-introduzione della norma: allo stato, però, ogni tentativo in tal senso è destinato a naufragare.
Non resta che sperare in un intervento a monte del legislatore nazionale, che superi definitivamente il concetto di “doppia conformità”; nell’attesa, è meglio “gettare la spugna”.
Piano Regolatore Generale: variante o interpretazione autentica?
 Il “governo del territorio” rappresenta una delle più gravose – e complesse – competenze di cui sono investiti i diversi Enti territoriali, e proprio a causa della molteplicità di interessi coinvolti, è spesso foriera di contenziosi.
Il “governo del territorio” rappresenta una delle più gravose – e complesse – competenze di cui sono investiti i diversi Enti territoriali, e proprio a causa della molteplicità di interessi coinvolti, è spesso foriera di contenziosi.
Un recente esempio è offerto dalla sentenza del TAR Milano n. 3215 del 29.12.2023, con la quale il Tribunale Amministrativo per la Lombardia si è confrontato con i limiti che un Comune incontra nella possibilità di offrire un’interpretazione autentica del proprio Piano Regolatore Generale.
I. Intendiamoci sui termini
Una brevissima, ma doverosa, premessa terminologica.
Sin dalla Legge Urbanistica del 1942 è stato stabilito (art. 4) che “La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti”: lo strumento locale “prediletto” era, insomma il Piano Regolatore Generale (abbreviato, PRG); e ad esso si è sempre genericamente fatto “volgarmente” riferimento anche allorquando, negli anni successivi, la terminologia si è poi evoluta (insieme alla struttura del Piano stesso).
Ad esempio, oggi il PRG è sostanzialmente “superato” dal Piano Urbanistico Comunale (cd. PUC); ma anche nelle diverse regioni italiane, il Piano Generale ha ricevuto diverse nomenclature.
Nel caso della Regione Lombardia, in particolare, lo strumento offerto ai Comuni per il “governo del territorio” è rappresentato Piano di Governo del Territorio (o PGT), definito dagli artt. 6 e ss. LR Lombardia n. 12/2005.
II. La fattispecie concreta
Venendo al caso esaminato dal TAR Milano, oggetto di impugnazione è una delibera comunale con cui l’Ente territoriale – a suo dire – ha reso un’interpretazione autentica di un articolo del Piano delle Regole del vigente PGT.
Nello specifico, i ricorrenti avevano presentato all’ufficio tecnico comunale una richiesta di Permesso di Costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 28-bis DPR 380/2001 e art. 14, comma 1-bis, LR 12/2005, poiché nell’area da edificare non era possibile (proprio alla luce delle norme del PGT) realizzare opere con titolo diretto.
Tuttavia, l’Amministrazione ha segnalato loro che, secondo l’art. 120-bis del Piano delle Regole, l’accordo sotteso al PdC non doveva essere sottoscritto dai soli ricorrenti, bensì anche da tutti i proprietari delle aree confinanti con i loro terreni, perché facenti parte di una più ampia “Area di Trasformazione”, che doveva essere coinvolta nel suo complesso dal PdC convenzionato.
Soprattutto, nelle more di tale procedimento amministrativo, il Comune ha adottato una deliberazione di Consiglio Comunale recante un’interpretazione autentica del citato art. 120-bis, con la quale ha “formalizzato” questa sua interpretazione.
Da qui il ricorso dei richiedenti il PdC convenzionato, che hanno chiesto al TAR di annullare la deliberazione comunale.
III. Le argomentazioni del ricorso
Secondo le difese dei ricorrenti, la deliberazione impugnata sarebbe illegittima perché attraverso di essa sarebbe stata modificata la vigente disciplina pianificatoria, facendo un improprio ricorso all’istituto della rettifica e dell’interpretazione autentica degli atti del PGT, peraltro in contrasto con la disciplina del Permesso di Costruire convenzionato.
I profili di illegittimità sollevati riguardano, quindi, il procedimento utilizzato dal Comune resistente per modificare l’art. 120-bis: nel caso di specie è stato utilizzato il procedimento semplificato di cui all’art. 13, comma 14-bis, LR 12/2005, il quale prevede che “i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi”; per contro, secondo i ricorrenti ci si troverebbe dinanzi ad una vera e propria variante puntuale al PGT, che necessiterebbe di un procedimento “aggravato”, molto più complesso.
Ebbene, il TAR Milano ha dato ragione ai ricorrenti.
IV Variante o interpretazione autentica?
Dall’analisi della disciplina condotta dai Giudici amministrativi è emerso che le prescrizioni urbanistiche vigenti prima della modifica contestata consentivano l’edificazione dell’area mediante un “semplice” Permesso di Costruire convenzionato “esteso ad almeno un mappale”; per contro, in seguito alla deliberazione impugnata, il Comune ha, di fatto, “implementato” la disposizione di cui all’art. 120-bis, aggiungendovi una prescrizione più stringente, e dunque limitativa dello ius aedificandi, quale la compartecipazione all’accordo di un più ampio numero di soggetti.
Per questo motivo, secondo il Tribunale
l’intervento di modifica della disciplina contenuta nell’art. 120-bis del PdR non può essere ricondotto né a una rettifica/correzione di errore materiale, né ad attività di interpretazione autentica, secondo quanto imposto dall’art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005; nella specie, si è proceduto a dar corso a una vera e propria Variante, seppure puntuale, allo strumento urbanistico, senza tuttavia rispettare il procedimento ordinario di cui al citato art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005 (molto più lungo, articolato e complesso).
Richiamando anche Consiglio di Stato, sez. VI, 5.3.2014, n. 1036, è stato chiarito che “una rettifica delle previsioni urbanistiche comunali risulta ammissibile solo in presenza di un errore materiale che emerga in modo manifesto e immediato dalla lettura della documentazione del Piano, senza che si debba ricorrere ad alcuna attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione”.
D’altro canto, sul tema delle leggi interpretative, si è diffusamente soffermata anche la giurisprudenza costituzionale (ex multis, Corte costituzionale, 17.12.2013, n. 314), stabilendo che possono essere definite come “interpretative” solo quelle norme che
hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenza n. 424 del 1993). Ed ha chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 15 del 2012, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010)
V. Conclusioni
Tirando le fila del discorso, il TAR Milano ha affermato che i chiari principi giurisprudenziali richiamati possono essere pacificamente applicati sia alle norme di legge in senso stretto, sia a tutte le ulteriori fonti normative ed agli atti amministrativi generali.
E, dunque, “nella specie non si è scelto uno dei vari significati interpretativi riconducibili alla disciplina oggetto di intervento, ma si è provveduto a modificarla nella sua portata oggettiva, aggiungendo un nuovo onere a carico di coloro che intendono edificare all’interno dell’Area Speciale”.
Pertanto, può definirsi come “interpretazione autentica” solo quell’attività volta semplicemente a “chiarire” la portata di una certa disciplina; ogniqualvolta tale attività determina un aggravio nel procedimento, ed un maggior “restringimento” della capacità edificatoria di un’area, si è in presenza di una variante, tale da necessitare di un procedimento amministrativo ben più gravoso.
Muro di cinta: serve il Permesso di Costruire?
 Sul finire del 2023 il TAR Napoli si è trovato a dirimere una controversia relativa alla possibile sanatoria di un muro di cinta, realizzato senza Permesso di Costruire. La sentenza n. 7234/2023, dunque, ci offre una ghiotta occasione per soffermarci sul tema delle pertinenze urbanistiche e del relativo regime autorizzatorio.
Sul finire del 2023 il TAR Napoli si è trovato a dirimere una controversia relativa alla possibile sanatoria di un muro di cinta, realizzato senza Permesso di Costruire. La sentenza n. 7234/2023, dunque, ci offre una ghiotta occasione per soffermarci sul tema delle pertinenze urbanistiche e del relativo regime autorizzatorio.
I. La fattispecie concreta
Come accennato, un soggetto privato è insorto contro il provvedimento di diniego di accertamento di conformità, disposto a fronte di un’istanza con cui si chiedeva la sanatoria di un muro di cinta: nello specifico, tale recinzione, avente un’altezza di circa 2,50 metri, circonda l’intero lotto di proprietà del ricorrente (di circa 540 mq); ma il dato più rilevante è rappresentato dalla consistenza dell’opera stessa, essendo stata realizzata integralmente in calcestruzzo armato, dunque infissa stabilmente al suolo.
Tali dati hanno assunto valore dirimente per il giudizio, poiché il TAR Napoli ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale che ha denegato la sanatoria perché l’opera, insistente su area agricola inedificabile, non poteva essere considerata pertinenziale.
II. Sulla natura pertinenziale dell’opera
Secondo le difese del ricorrente, tale muro di cinta dovrebbe essere considerato come un’opera pertinenziale a quella principale esistente sulla sua proprietà, ossia un’officina meccanica ed autoricambi: solo attraverso la recinzione sarebbe stato possibile “difendere” la sua proprietà e l’attività economica ivi svolta.
Ma il TAR è di differente avviso.
Infatti, è stato osservato che la nozione di pertinenza sul piano urbanistico – edilizio, diversamente da quanto accade per le pertinenze civilistiche di cui all’art. 817 c.c., non guarda solo ed esclusivamente alla funzione che l’opera è chiamata a svolgere, ma è limitata ai soli interventi, pur accessori, che siano di modesta entità e del tutto privi di una loro autonomia funzionale.
Più chiaramente, il TAR Napoli ha stabilito (ricalcando una granitica giurisprudenza) che:
carattere pertinenziale in senso urbanistico va, quindi, riconosciuto alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127; Tar Napoli, sez. VIII, 2 gennaio 2023, n. 21).
Per contro, sulla base della descrizione del muro operata innanzi, è evidente che essa “è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l'intervento edilizio produca, come in questo caso, un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione”.
III. Quando una recinzione è opera pertinenziale?
Sorge, allora, spontanea una domanda: per recintare terreni di grosse dimensioni è sempre necessario ottenere un Permesso di Costruire, attesa l’impossibilità di qualificare come pertinenza il muro di cinta?
A questa tematica la sentenza in commento fa un piccolo accenno, proprio per stabilire (è proprio il caso di dirlo!) la “linea di confine” con le mere recinzioni: richiamando un precedente Consiglio di Stato n. 4169/2018, il Tribunale afferma che una recinzione “ha caratteristiche tipologiche di minima entità, al fine della mera delimitazione della proprietà”.
Infatti, come affermato di recente nella sentenza n. 1481/2023 dello stesso TAR Campania, ma sezione distaccata di Salerno:
la realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto. In particolare, il permesso di costruire, mentre non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, così rientrando nel novero degli interventi di "nuova costruzione"
IV. Conclusioni
Anche quando si vuole esercitare un’attività tipica dell’ineludibile diritto di proprietà, quale l’interclusione di un terreno, si è soggetti ad una limitazione dello ius aedificandi: solo un’opera avente un minimo impatto sul territorio consente di agire senza alcun titolo abilitativo; viceversa, in tutti quei casi in cui si intende realizzare un’opera più “massiccia”, sarà necessario richiedere un Permesso di Costruire.
Trentatré trentini sanarono a Trento: questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, della Legge Provinciale n. 1/2008
 Ancora una volta la Corte Costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale di una norma regionale – o meglio, provinciale – relativa alla sanatoria edilizia “ordinaria”.
Ancora una volta la Corte Costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale di una norma regionale – o meglio, provinciale – relativa alla sanatoria edilizia “ordinaria”.
Nello specifico, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con l’ordinanza in rassegna ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, della Legge Provinciale n. 1/2008.
I. La fattispecie concreta
Il giudizio nel cui seno è stata resa l’ordinanza in parola è stato promosso da un vicino di casa, che ha deciso di impugnare il Permesso di Costruire in sanatoria rilasciato dal Comune in relazione ad un edificio condominiale.
Nello specifico, l’interesse all’impugnativa si intendeva radicato in virtù del fatto che con il titolo in sanatoria risultava essere sanata una consistenza immobiliare che addirittura invadeva il terreno di proprietà dei ricorrenti, con ciò (chiaramente) violando anche le distanze legali prescritte.
È interessante rilevare come, a ben vedere, nell’articolazione dei motivi di ricorso non è mai neanche lumeggiata una possibile questione di legittimità costituzionale, limitandosi i ricorrenti a censurare la cattiva applicazione dell’art. 135, comma 7, L.P. n. 1/2008, difettandone in radice i presupposti.
Ma il Tribunale è di diverso avviso.
II. La questione di legittimità costituzionale
Leggendo l’ordinanza di rimessione, emerge che il TRGA di Trento già aveva individuato un possibile profilo di incostituzionalità della norma durante il giudizio, ma prima di sollevare d’ufficio la quesitone di legittimità, ha ritenuto necessario disporre una verificazione che, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, dimostrasse che la questione stessa fosse rilevante nel presente giudizio (con ciò, dunque, adempiendo a quanto richiesto dall’art. 23 L. 87/1953).
Una volta accertata la sussistenza di tale requisito, dunque, il Collegio ha ritenuto “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, L.P. n. 1/2008.
III Le considerazioni del Tribunale
A sostegno della propria tesi, il TRGA ha richiamato molteplici arresti giurisprudenziali (propri del Giudice delle Leggi), nonché alcune proprie considerazioni in diritto.
Ma partiamo dal dato normativo: l’articolo in parola stabilisce che
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento
L’istituto di cui si discorre, come riconosciuto dallo stesso TRGA, è quello della cd. “sanatoria giurisprudenziale”, il quale deve sempre e comunque “ritenersi recessivo rispetto alla vigente normativa nazionale e ai principi dalla stessa desumibili in materia di abusiva trasformazione del territorio, essendo il permesso in sanatoria ottenibile soltanto in presenza dei presupposti delineati dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ossia a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda”.
Di conseguenza, tale istituto si pone in contrasto con la Costituzione, così come più volte ribadito proprio dalla Corte Costituzionale: in tal senso, ad esempio, leggasi la sentenza n. 232 del 8 novembre 2017 (avente ad oggetto l’art. 14, commi 1 e 3, della legge della Regione Sicilia n. 16 del 2016), richiamata anche dal TRGA, ove è stato stabilito che
spetta al legislatore statale la scelta sull’an, sul quando e sul quantum della sanatoria, potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l’articolazione e la specificazione di tali disposizioni
Ed ancora, forse con addirittura maggior chiarezza, si richiama la sentenza n. 93 del 12 maggio 2023, secondo cui
La previsione regionale di una sanatoria extra ordinem viola, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri di riparto della potestà legislativa in tema di condono edilizio, e si traduce nella lesione di un principio fondamentale nella materia di governo del territorio, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Spettano, infatti, alla legislazione statale le scelte di principio e, in particolare, quelle relative all’an del condono, con la conseguenza che “esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale
IV. Conclusioni
Più volte abbiamo avuto modo di soffermarci sui principi cardine in materia di governo del territorio, nonché sulla competenza statale riconosciuta in relazione ad essa; quella di oggi sembra solo l’ultima di una lunga serie di rimessioni alla Corte Costituzionale che, proprio come le altre, sembra destinata a veder “demolita” la norma territoriale, proprio perché posta in contrasto con i principi basilari tracciati dal Legislatore nazionale.
Attendiamo, dunque, il pronunciamento della Corte: in ogni caso, il consiglio ai trentatré trentini è, almeno per il momento, di non sanare nulla a Trento.
La rilevanza delle riprese fotografiche per la sanzione degli abusi edilizi

Ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico dell’Edilizia, tra le prerogative che spettano alle Amministrazioni comunali vi è quella di esercitare “la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.
È naturale, soprattutto nei Comuni con ampia estensione territoriale, che tale controllo non possa essere costante, e che anzi ci si accorga di un determinato abuso a distanza di tempo; in questi casi, di fondamentale importanza è l’impianto probatorio che l’Amministrazione utilizza per dimostrare, innanzitutto, il momento in cui l’abuso è stato concretamente realizzato.
La sentenza in esame si concentra, in particolare, sull’utilizzo delle riprese fotografiche.
I. La fattispecie concreta
Il caso sottoposto all’attenzione del TAR di Reggio Calabria (sentenza n. 501 del 12.6.2023) concerne l’impugnativa di un’ordinanza di demolizione adottata in relazione ad una “baracca in lamiera” la cui estensione e volumetria erano tali da necessitare di un apposito titolo edilizio, costituendo una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), DPR 380/2001.
Tra le numerose contestazioni sollevate dai ricorrenti, quella che qui maggiormente rileva riguarda l’esatta collocazione temporale dell’abuso, poiché questi sostengono che esso risalga “almeno al 1990, epoca nella quale la Sig.ra ha intrapreso l’attività agricola”, con la conseguenza che questo manufatto poteva essere sanato ai sensi della L. 326/2003 (cd. “terzo condono”).
Per contro, il Comune aveva dimostrato, allegando apposita documentazione, che l’abuso era stato realizzato sicuramente dopo il 2008.
Ma in cosa consiste tale “apposita documentazione”?
II. La documentazione probatoria utile
Nel caso di specie l’Amministrazione comunale ha allegato all’ordinanza di demolizione due ortofoto, redatte dagli appositi uffici regionali, risalenti al 2008 ed al 2017: prendendo in prestito le parole della stessa Regione Calabria,“Le ortofoto digitali a colori consentono una rappresentazione diretta del territorio, permettendo all’utente un approccio immediato ai particolari del terreno tramite la loro visualizzazione realistica e vicina all’esperienza quotidiana. Per la loro completezza descrittiva della superficie del terreno possono venire utilizzate come basi di riferimento cartografico per il controllo e l’aggiornamento di strati informativi vettoriali quali: reticolo stradale, edificato, boschi, linea di costa etc.”; ciò significa che attraverso particolari strumenti di rilievo, è riconosciuta alle Amministrazioni (solitamente, quelle regionali) la possibilità di campire l’intero territorio e, a distanza di anni, verificarne le modifiche.
Ebbene, mentre nell’ortofoto del 2008 il manufatto non risultava esistente, nel 2017 “improvvisamente” questo appare nelle riprese fotografiche; così facendo, l’Amministrazione comunale ha potuto dimostrare che l’immobile è stato, con elevato margine di certezza, edificato almeno dopo il 2008, e comunque prima del 2017.
III. La giurisprudenza rilevante
A conferma della bontà dell’istruttoria condotta dal Comune resistente, il TAR ha richiamato principi comuni nella giurisprudenza, ricordando che:
In materia di abusivismo edilizio, il margine d’incertezza relativo all’interpretazione delle riprese fotografiche dell’area di riferimento, ostativo alla ricostruzione della situazione originaria dei luoghi, anteriore all’abuso in contestazione, preclude l’adozione di provvedimenti autoritativi, impositivi di un obbligo di ripristino, in assenza di un previo approfondimento istruttorio in sede procedimentale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2021, n. 2300), è anche vero che compete al privato richiedente il provvedimento favorevole portare una sufficiente ed idonea prova contraria (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5787/2017)”(v. C.G.A. 30 gennaio n. 2023 n. 109).
In buona sostanza, pur riconoscendo l’astratta “fallibilità” delle riprese fotografiche di una determinata area, il Giudice Amministrazione ha da sempre riconosciuto come particolarmente affidabili tali documenti, tanto da “ribaltare” sul privato l’onere di prova contraria, ossia riconoscendogli la possibilità di contestare la veridicità di un’ortofoto, purché ciò avvenga con prove tali da elidere ogni margine di incertezza.
In tal senso, peraltro, merita di essere richiamata la nutrita giurisprudenza che va affermandosi nel corso degli ultimi anni la quale, mettendosi “al passo coi tempi”, va riconoscendo sempre una maggior valenza probatoria agli strumenti informatici offerti da Google, ossia Maps e Earth (ne abbiamo parlato anche qui).
Ed infatti, è stata riconosciuta loro l’efficacia di “prova relativa”, che insieme ad altri elementi è idonea a supportare la veridicità di un dato elemento fatturale:
non può attribuirsi efficacia probante, nel caso di specie, alle immagini elaborate dal programma Google Earth, le quali sono astrattamente annoverabili comunque tra le prove documentali (idonee in quanto tali a ricomprendere tutte le rappresentazioni grafiche o fotografiche dei fatti oggetto di prova). (TAR Napoli, sez. II, 28.10.2021, n. 6758)
Le immagini tratte da Google Earth e dal Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente, dunque, non sono state utilizzate come fonti di prova esclusiva ma costituiscono un supporto ad acquisizioni ottenute dall’esame della restante documentazione. (Consiglio di Stato, sez. VI, 10.3.2023, n. 2564)
IV. Conclusioni
Il TAR di Reggio Calabria ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo corretta l’istruttoria condotta dall’Amministrazione comunale, anche alla luce della mancata allegazione, da parte dei ricorrenti, di documentazione idonea a dimostrare la solo lumeggiata contraddittorietà: le aerofotografie in qualsiasi modo acquisite sono elementi idonei a dimostrare la risalenza di un abuso ad un dato periodo storico.
Attenzione, dunque: “the big brother is watching you” (anche dall’alto)!
Annullamento in autotutela e “colpa” dell’Amministrazione
 L’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi è un istituto particolarmente rilevante per l’intero sistema del diritto amministrativo, soprattutto per gli interessi (pubblici e privati) coinvolti nel complessivo procedimento, nonché per gli effetti a prodursi.
L’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi è un istituto particolarmente rilevante per l’intero sistema del diritto amministrativo, soprattutto per gli interessi (pubblici e privati) coinvolti nel complessivo procedimento, nonché per gli effetti a prodursi.
Proprio per questo motivo il Giudice Amministrativo viene spesso e volentieri “sollecitato” a verificare la legittimità dei provvedimenti recanti l’annullamento d’ufficio: tra questi giudizi, oggi segnaliamo una recente sentenza del TAR Ancora, la n. 265 del 22 aprile 2023, in cui è affrontato il tema della “colpa” dell’Amministrazione procedente.
I. La fattispecie concreta
Il caso sottoposto all’attenzione del TAR per le Marche è un classico “caso di scuola”, in cui un Comune ha annullato in autotutela, dopo essere stata a tal uopo sollecitato dai vicini, un Permesso di Costruire e la relativa variante in corso d’opera, cui è conseguita l’adozione dell’ordinanza di demolizione delle opere divenute abusive proprio a causa dell’annullamento d’ufficio.
I privati originari richiedenti il PdC hanno impugnato entrambi i provvedimenti davanti al Giudice Amministrativo, censurandone la legittimità sotto una serie di profili sia “formali”, sia sostanziali: per quel che qui specificamente rileva, di particolare pregnanza risulta la censurata violazione dell’art. 21-nonies L. 241/1990, poiché i ricorrenti ritengono che l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio era stato adottato oltre il termine di 12 mesi stabilito dalla norma, e dunque in violazione di uno dei suoi presupposti fondamentali.
II. La normativa violata
Come anticipato, il Legislatore ha previsto la possibilità per la Pubblica Amministrazione di adottare dei cosiddetti provvedimenti di secondo grado, offrendole il potere di “autotutelarsi” ogniqualvolta si renda conto che (i) sia mutata la situazione di fatto (e l’interesse pubblico sotteso) che aveva determinato l’adozione di un determinato provvedimento, oppure (ii) il provvedimento adottato precedentemente sia affetto da vizi di legittimità: nel primo caso si parla di revoca del provvedimento (art. 21-quinquies L. 241/1990), nel secondo di annullamento d’ufficio (art. 21-nonies).
In quest’ultimo caso, il Legislatore ha voluto porre una serie di paletti al possibile utilizzo “spregiudicato” dell’istituto, fissando una disciplina puntuale secondo cui:
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
Dunque, affinché un provvedimento recante l’annullamento d’ufficio di un precedente atto sia legittimo, devono contemporaneamente sussistere tutti i requisiti fissati dalla norma.
L’unica deroga possibile è quella legata al “termine ragionevole” entro cui agire: ed infatti, il comma 2-bis stabilisce che
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
III. Le violazioni contestate
Premessa questa breve ricostruzione normativa, nel caso di specie i ricorrenti hanno contestato il provvedimento di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire rilasciato in loro favore – oltre che per numerosi aspetti sostanziali, in questa sede non rilevanti - perché il Comune era intervenuto in un momento successivo ai 12 mesi dal rilascio del titolo, e l’Amministrazione non aveva in alcun modo giustificato tale ritardo, neanche richiamando la deroga di cui al comma 2-bis del citato art. 21-nonies L. n. 241/1990.
Orbene il Tribunale, condividendo l’eccezione dei ricorrenti, ha riconosciuto che l’annullamento in autotutela era stato disposto oltre i 12 mesi senza che ricorresse alcuna “falsa rappresentazione dello stato dei luoghi” che avrebbe concesso la possibilità di ovviare al termine, altrimenti perentorio.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale non poteva parlarsi di “falsa rappresentazione dello stato dei luoghi”, poiché il progettista aveva, in buona fede, applicato un proprio metodo ricostruttivo dello stato legittimo dei luoghi “fondato anche sull’applicazione di norme civilistiche (ed in particolare dell’art. 880 c.c.) ed ha inoltre ritenuto che una tettoia a suo tempo realizzata dai precedenti proprietari fosse inclusa nella sanatoria del 1995”.
Pertanto, prosegue il Giudice
In casi del genere, e salvo che non sia provata dal Comune la mala fede del proprietario e/o del progettista, si discute dunque di una diversa interpretazione delle norme urbanistiche ed edilizie (ad esempio, come si calcola l’altezza di un edificio costruito su un terreno in pendenza; come si dimostra la consistenza originaria di un edificio diruto; etc.), e non certo di “falsità” della rappresentazione dello stato dei luoghi.
Da qui si è tratta la seguente conclusione:
per potersi parlare nella specie di falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, sarebbe stato necessario che la falsità non fosse evincibile dal progetto presentato al Comune ai fini del rilascio del titolo. In caso contrario si deve parlare quantomeno, per usare un linguaggio penalistico, di “un concorso di colpa” del Comune, concorso di colpa che però assorbe anche la colpa del privato, visto che il titolo viene rilasciato dall’amministrazione dopo aver verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge.
IV. Conclusioni
Il Tribunale marchigiano, proseguendo nel solco di una nutrita giurisprudenza sviluppatasi nel corso degli anni (per citare solo alcune delle più recenti leggasi TAR Napoli, sez. II, 17.3.2023, n. 1709; TAR Latina, sez. I, 21.10.2022, n. 807; TAR Venezia, sez. I, 8.4.2022, n. 539; Consiglio di Stato, sez. V, 12.4.2021, n. 2971), ha dunque riconosciuto che la semplice “falsa rappresentazione dei fatti” non giustifica sempre e comunque l’annullamento in autotutela di un precedente atto amministrativo, essendo necessario un quid pluris, rappresentato se non dalla assoluta mala fede del privato dichiarante, quanto meno dall’assenza di colpa (“neppure a titolo di colpa concorrente”, per citare la giurisprudenza) dell’Amministrazione.
Infatti, come rilevato nella sentenza in commento, “era agevole per il Comune avvedersi dell’errata interpretazione in cui era incorso il progettista di fiducia dei ricorrenti”: insomma, è stata riconosciuta una “colpa” dell’Amministrazione, o meglio dei tecnici comunali cui le pratiche edilizie sono state sottoposte, per non aver tempestivamente rilevato che i calcoli effettuati dal tecnico fossero errati.
Pertanto, anche a fronte della “falsa rappresentazione dei fatti” stabilita dal comma 2-bis dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990, il TAR ha annullato il provvedimento di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire (e la pedissequa ordinanza di demolizione) per decorso del termine perentorio di 12 mesi proprio perché l’Amministrazione, colpevolmente, non si è avveduta dei vizi che avrebbero dovuto giustificare il tempestivo annullamento del PdC: in questi casi, dunque, il legittimo affidamento ingeneratosi nel privato per il decorso del tempo è ritenuto maggiormente meritevole di tutela rispetto all’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia violata.
Inottemperanza all’ordinanza di demolizione: ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
 Con ordinanza del 19 aprile 2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione di una serie di quesiti relativi alla inottemperanza all’ordinanza di demolizione e, dunque, alla sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale che viene comminata ai sensi dell’art. 31, commi 3 e ss., DPR 380/2001 (qui una precedente news sulla sorte degli immobili abusivi).
Con ordinanza del 19 aprile 2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione di una serie di quesiti relativi alla inottemperanza all’ordinanza di demolizione e, dunque, alla sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale che viene comminata ai sensi dell’art. 31, commi 3 e ss., DPR 380/2001 (qui una precedente news sulla sorte degli immobili abusivi).
I. Il deferimento all’Adunanza Plenaria
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato svolge un ruolo sostanzialmente nomofilattico nell’ambito della giustizia amministrativa: i suoi 13 membri (Presidenti delle diverse sezioni del Consiglio di Stato ed altri magistrati dello stesso dicastero, ex art. 6, co. 3, c.p.a.), in seduta appunto plenaria, sono chiamati a dirimere contrasti giurisprudenziali su questioni di diritto controverse di particolare importanza.
Tale procedimento è scandito dall’art. 99 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), ai sensi del quale
La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. (…)
II. La fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato
Nel caso in commento, oggetto dell’impugnativa (prima al TAR Napoli e poi, in sede di appello, innanzi al Consiglio di Stato) è il provvedimento con cui, in seguito alla mancata demolizione spontanea di alcune opere abusive, un Comune ha disposto l’acquisizione gratuita di queste opere al patrimonio comunale ed irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, co. 4-bis, DPR 380/2001.
La questione sembra un “caso di scuola”, ma in realtà presenta una caratteristica particolare: l’ordinanza di demolizione prodromica al provvedimento impugnato è stata notificata (ed il termine per adempiervi di 90 giorni è completamente decorso) prima dell’entrata in vigore del citato comma 4-bis, il quale è stato introdotto successivamente, con D.L. n. 133/2014, convertito con modifiche dalla Legge 11.11.2014 n. 164 (cd. Legge Sblocca Italia).
Proprio la particolarità della successione delle leggi nel tempo ha fatto sorgere nel Collegio giudicante alcuni dubbi interpretativi.
III. I quesiti sottoposti all’Adunanza Plenaria
Il leitmotiv dell’intera ordinanza di rimessione è rappresentato dalla natura dell’illecito che il legislatore intende perseguire in relazione all’ordinanza di demolizione, ed in particolare dal fatto che il termine di 90 giorni offerto, ex art. 31, co. 3, DPR 380/2001, per adempiere spontaneamente a questa, ripristinando lo stato dei luoghi, sia da intendere come perentorio, ovvero se al privato residui una possibilità di adempiere anche successivamente.
Tale questione è legata a doppio filo con quella della natura dell’illecito che, in caso di inadempimento, il privato commette: secondo una parte della giurisprudenza, l’illecito sarebbe di tipo istantaneo, poiché allo scadere del termine di novanta giorni le opere vengono acquisite gratuitamente ed automaticamente al patrimonio comunale, con conseguente perdita della disponibilità del bene da parte del privato e impossibilità di procedere alla demolizione (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 12.5.2022, n. 3760); secondo altro filone, invece, “Gli abusi edilizi hanno natura di illeciti permanenti in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 14.2.2023, n. 1537).
E la soluzione di tale dubbio interpretativo ha un’efficacia diretta sul giudizio, poiché se dovesse essere riconosciuta la natura di illecito istantaneo l’ordinanza di acquisizione sarebbe illegittima, visto che la condotta omissiva su cui la sanzione si fonda sarebbe stata posta in essere, e completamente esaurita, prima dell’entrata in vigore della L. 164/2014, e dunque in violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative (di cui all’art 1 della L. 689/1981 nonché dell’art 11 disp. prel. cod. civ.).
Pertanto, sono stati sottoposti all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato i seguenti quesiti:
1) se, e in che limiti, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, abbia effetti traslativi automatici che si verificano alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato al privato per la demolizione;
2) se l’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/01 sanzioni l’illecito costituito dall’abuso edilizio o, invece, un illecito autonomo di natura omissiva, id est, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione;
3) se l’inottemperanza all’ordine di demolizione configuri un illecito permanente ovvero un illecito istantaneo ad effetti eventualmente permanenti;
4) Se la sanzione di cui all’art 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01 possa essere irrogata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione prima dell’entrata in vigore della L. n. 164 dell’11.11.2014, quando il termine di novanta giorni, di cui all’art. 31, comma 3, risulti a tale data già scaduto e detti soggetti più non possano demolire un bene non più loro, sempre sul presupposto che a tale data la perdita della proprietà in favore del comune costituisca un effetto del tutto automatico.
IV. Brevi considerazioni finali
Sarebbe a dir poco pretenzioso offrire una completa disamina delle questioni di diritto, e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, sottesi ai quattro quesiti sottoposti all’Adunanza Plenaria.
In questa sede ci limitiamo ad una breve osservazione (in parte) critica.
Se, in generale, le ordinanze di rimessione hanno un contenuto attraverso il quale il Collegio dà atto ed analizza (seppur in maniera critica) i diversi orientamenti giurisprudenziali che hanno dato luogo al contrasto che proprio l’Adunanza Plenaria è chiamata a dirimere, nel caso di specie si assiste ad una ordinanza “orientata”: il Giudice rimettente ammette candidamente di ritenere che
l’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 si configuri come illecito istantaneo ad effetti permanenti: non è infatti la condotta omissiva del privato a protrarsi oltre la scadenza del termine, ma solo i suoi effetti materiali, la cessazione dei quali, peraltro, una volta verificatosi il passaggio (di proprietà) del bene abusivo e dell’area di sedime in favore del patrimonio del comune, non sono più sotto il controllo esclusivo del privato.
(…)
ad avviso del Collegio per coerenza la sanzione di cui all’art 31 comma 4 bis non può essere irrogata in relazione all’inottemperanza ad ordinanze di demolizione notificate e “scadute” prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, poiché, in ragione della natura istantanea dell’illecito, in tali casi non vi sarebbe neppure una frazione della condotta sanzionata commessa dopo l’entrata in vigore di tale norma: diversamente opinando si determinerebbe una frizione con il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative sancito dall’art 1 l. 689/81 – applicabile in virtù della natura afflittiva della sanzione in esame – nonché con il generale principio sancito dall’art 11 disp. prel. cod. civ. secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire.
Sennonché, a sommesso avviso dello scrivente, nell’ordinanza di rimessione è del tutto omesso un filone giurisprudenziale che, a prescindere da ogni valutazione sulla sua natura minoritaria o meno, può orientare la decisione dell’Adunanza Plenaria.
Ci si riferisce, in particolare, alla giurisprudenza secondo cui “il privato raggiunto dall'ordine di demolizione può richiedere la sanatoria delle opere eseguite, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, anche oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza e ciò sulla base dello stesso tenore letterale del comma I del predetto art. 36, che ammette la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria "fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative"; la predetta norma consente la presentazione della domanda di accertamento di conformità in un momento successivo alla scadenza del termine ex art. 31, comma 3, ove a tal momento non siano state ancora in concreto irrogate le sanzioni definitive; il termine di novanta giorni è, infatti, fissato unicamente per la demolizione volontaria del manufatto abusivo mentre, fino a quando l'opera esiste nella sua integrità ed il soggetto ne conserva la titolarità, è sempre possibile richiedere la sanatoria, che ha lo scopo di evitare l’abbattimento di un manufatto conforme urbanisticamente.” (TAR Napoli, sez. VIII, 15.2.2021, n. 962; sez. III, 8.10.2020 n. 4356; TAR Salerno, sez. II, 12.7.2021, n. 1708; 28.6.2021, n. 1576; TAR Roma, sez. II-quater, 3.11.2020, n. 11307; TAR Latina, sez. I, 11.1.2018, n. 16; Consiglio di Stato, sez. VI, 7 novembre 2019, n. 7601; CGARS, sez. I, 24.12.2021, n. 1075).
Secondo tale orientamento, dunque, il termine di 90 giorni non ha natura perentoria, rimanendo l’opera abusiva nella piena disponibilità del privato (il quale può addirittura chiederne la sanatoria, laddove sussistano i presupposti) fintantoché non sia portato ad esatto e pieno compimento il procedimento sanzionatorio, ossia fintantoché non sia trascritta presso i pubblici registri l’avvenuta acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio comunale.
È dunque auspicabile, anzi pressoché certo alla luce della “prassi giurisprudenziale” sviluppatasi negli anni, che tale vuoto del Giudice rimettente venga colmato da una più approfondita disamina da parte dell’Adunanza Plenaria.
“È tardi è tardi!” L’inizio dei lavori oggetto di un Permesso di Costruire
 Chi non ricorda il Bianconiglio di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, in perenne ritardo e sempre di corsa?!
Chi non ricorda il Bianconiglio di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, in perenne ritardo e sempre di corsa?!
Leggendo la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1314 del 7 febbraio scorso, la mente è subito corsa a lui, pensando a tutti coloro che non inizino subito i lavori oggetto di un Permesso di Costruire e che, a ridosso della scadenza, corrono a perdifiato per non incorrere nella decadenza prevista dall’art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001.
Si, perché una volta ottenuto un titolo edilizio, non si è del tutto liberi nella scelta di quando iniziare (e terminare) i relativi lavori.
Vediamo, allora, quanto è profonda la tana del Bianconiglio.
I. L’antefatto della decisione.
La fattispecie portata all’attenzione del Consiglio di Stato riguarda un Permesso di Costruire rilasciato in favore di un soggetto privato per la realizzazione di un parcheggio a raso da destinare ad uso pubblico (cd. parcheggio privato convenzionato).
Una società concorrente, poiché già esercente l’attività di parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze, ha impugnato innanzi al Giudice Amministrativo – a dire il vero prima innanzi al Capo dello Stato, con ricorso straordinario ex D.P.R. 1199/1971 poi trasposto al TAR – il relativo titolo edilizio, poiché a suo dire rilasciato in violazione di una serie di norme urbanistico-edilizie.
In pendenza di giudizio, la società ricorrente ha denunciato al Comune il mancato tempestivo avvio dei lavori ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 380/2001: a seguito degli opportuni approfondimenti, l’Amministrazione ha adottato una nota con cui riteneva sufficienti, ai fini dell’avvio dei lavori, le opere di cantierizzazione e sbancamento realizzate dai privati titolari del P.d.C.
Anche questo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti innanzi al TAR Venezia ma il Tribunale, con sentenza n. 195 del 16.2.2015, ha respinto ogni tesi della società ricorrente.
Da qui l’appello che ha originato la sentenza in commento.
II. La normativa di riferimento.
La strada da seguire nell’analisi della decisione del Consiglio di Stato è tracciata dall’art. 15 del Testo Unico dell’Edilizia, rubricato proprio “Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire”, che si apre stabilendo la regola generale per cui “Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori”.
Già questo elemento fa capire come non sia immaginabile ottenere un P.d.C. e riporlo in un cassetto, in attesa del momento migliore per utilizzarlo.
Per contro, è l’Amministrazione stessa a fissare la data massima entro cui iniziare i lavori, nonché quella successiva entro cui terminarli.
A definire con esattezza tali tempistiche interviene il secondo comma dell’art. 15 D.P.R. 380/2001, che così statuisce:
(…) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. (…)
Di conseguenza, salvo i casi di proroga, una volta rilasciato un Permesso di Costruire, il titolare ha l’obbligo di iniziare i relativi lavori entro il termine massimo di un anno, pena la decadenza del titolo edilizio.
III. Le tesi delle parti in causa.
Così riassunto il quadro normativo di riferimento, è evidente che l’intera partita si è giocata in relazione all’attività edilizia posta in essere, nell’anno dal rilascio del titolo, da parte dei controinteressati titolari del PdC.
Come accertato dall’Amministrazione, e mai sconfessato nel corso del giudizio, i lavori sono consistiti “in uno sbancamento lungo 50 metri, largo 5 e profondo 0,50 metri, per una cubatura di terreno asportato di mc125”: secondo la società ricorrente, tale attività non integrerebbe il concetto di “inizio di lavori”, rappresentando mera preparazione alla successiva attività edilizia in senso stretto; per contro, secondo l’Amministrazione resistente ed i controinteressati, queste opere sarebbero prodromiche alla realizzazione del parcheggio a raso oggetto del Permesso di Costruire, e dunque sarebbero idonee a dimostrare il tempestivo inizio dei lavori.
IV. La decisione del Consiglio di Stato.
Nel decidere sui diversi motivi di appello, il Supremo Consesso Amministrativo, con specifico riferimento al tema dell’inizio dei lavori, ha ritenuto necessario ricordare un pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui
l’effettivo inizio dei lavori deve essere sempre rapportato all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio autorizzato (Cons. Stato, sez. IV, n. 4855 del 2013; sez. V, n. 3823 del 2013; sez. V 5648 del 2003; sez. V, n. 535 del 1996).
La portata di tale assunto è fondamentale ai fini del decidere, perché chiarisce che non è possibile tracciare una regola certa e “matematica” attraverso la quale riconoscere quando i lavori di una certa opera edilizia possano dirsi concretamente iniziati o meno; per contro, il Giudice è chiamato, di volta in volta, a valutare quanto e come l’attività avviata si rapporti all’opera finale a realizzarsi.
“La nozione di inizio lavoro è, infatti, dinamica e proporzionale sicché deve ragguagliarsi all’opera definitiva”.
Applicato tale principio al caso di specie, dunque, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che
tenuto conto che l’opera finale consisteva nella realizzazione di un parcheggio a raso con modeste opere accessorie (e non di un edificio da innalzare), lo stato dei luoghi, per come accertato dall’amministrazione, ragionevolmente ha integrato la nozione di inizio lavori
così respingendo il motivo di appello secondo cui il Permesso di Costruire impugnato avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto.
V. Osservazioni conclusive.
In un periodo in cui il caro materiali e il costo della vita in generale rendono più complessa ogni nostra attività, ed in modo speciale le operazioni edili, è molto forte la tentazione di ottenere un Permesso di Costruire e di attendere periodi più prosperi per portare a compimento la relativa operazione edile.
Sennonché, come abbiamo visto, l’Amministrazione non ci abilita “all’infinito”, ma impone il rispetto di tempistiche certe (e, sotto un certo punto di vista, strette) per l’avvio dei lavori.
Il rischio, insomma, è quello di “iniziare a correre” a ridosso della scadenza annuale prevista dell’art. 15 del Testo Unico dell’Edilizia: chissà che, tra i motivi che spingevano il Bianconiglio a correre, non ci fosse anche l’impellenza di iniziare a costruire la propria tana!
Quale disciplina deve essere applicata nel calcolo degli oneri concessori?

Più volte abbiamo affrontato questioni relative agli oneri concessori; tra le diverse fattispecie sottoposte al Giudice Amministrativo, spesso viene in risalto il tema della disciplina che deve essere applicata, laddove si sia verificata una successione di norme nel corso del tempo.
Tra le prime decisioni adottate nel nuovo anno, di particolare interesse sul tema è la n. 279 del 9 gennaio 2023 del Consiglio di Stato.
I. L’antefatto della decisione.
La vicenda trae origine nel 1995, allorquando la società appellante presentava domanda di concessione in sanatoria straordinaria ai sensi della L. n. 724/1994 (cd. “secondo condono”).
Alcuni anni dopo, il Comune notificava alla predetta società l’invito al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto degli oneri concessori: in particolare, ai sensi dell’art. 39, comma 9, L. n. 724/1994
Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d ), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.
La società, dunque, adiva il TAR Lazio al fine di ottenere l’annullamento dell’invito al pagamento, ritenendolo illegittimo poiché: (i) non specificava sufficientemente quali criteri il Comune avesse adottato nella determinazione del contributo di concessione; (ii) nel caso di specie non avrebbe dovuto essere applicata la tabella C allegata alla L. n. 724/1994.
Il TAR Roma, con sentenza n. 9249/2015, respingeva integralmente il ricorso e, di conseguenza, la società ricorreva in appello davanti al Consiglio di Stato.
II. La tesi dell’appellante.
Secondo la società, poiché le opere oggetto di condono sono state realizzate e concluse nel 1975, e dunque in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 10/1977 (con la quale è stato introdotto il rilascio della concessione a titolo oneroso), il contributo richiesto non poteva essere in misura superiore a quello previsto per le opere di urbanizzazione.
Inoltre, sempre secondo l’appellante, la legge sul secondo condono non prevedeva alcuna disposizione specifica circa i criteri di determinazione del contributo richiesto, con la conseguenza che il relativo calcolo avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, della L. n. 47/1985, concernente il primo condono.
Ma tali argomentazioni, già disattese dal Giudice di prime cure, sono state respinte anche dal Consiglio di Stato.
III. La decisione del Consiglio di Stato
Innanzitutto, con riferimento al vizio di “motivazione” sollevato dalla società appellante, il Supremo Consesso Amministrativo ha richiamato un orientamento ormai consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, 7.1.2021, n. 207; 2.7.2019, n. 4514) in virtù del quale
costituisce ius receptum, dal quale non è ragione di discostarsi, la circostanza che i principi sulla motivazione del procedimento amministrativo sanciti dalla L. n. 241 del 1990 non si applicano ai provvedimenti con cui si richiede il pagamento degli importi dovuti per il rilascio di titoli edilizi, data la natura obbligatoria del rapporto. La richiesta di conguaglio, pertanto, risulta “sufficientemente motivata attraverso il richiamo ai prestabiliti parametri utilizzati” trattandosi di attività vincolata, consistente in operazioni meramente matematiche
Premesso ciò, e passando al vero tema dell’appello, e dunque sull’applicabilità della Tabella C allegata alla L. n. 724/1994, il Consiglio di Stato osserva che
La circostanza che il manufatto abusivo sia stato realizzato nel 1975 non comporta l’applicazione di criteri di calcolo differenti e derogatori rispetto a quelli contemplati dalla l. n. 724/1994, tenuto conto che ai fini del calcolo degli oneri concessori devono essere applicate le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
In questo senso è infatti orientamento consolidato quello secondo cui nella materia del pagamento degli oneri concessori relativi ad un titolo in sanatoria trovi applicazione il canone tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo (Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 2020,n. 2680), con la conseguenza che l’importo degli oneri concessori va determinato secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non in relazione a quello della presentazione della domanda (Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 1485; id. , 27 aprile 2020, n. 2667).
Concludendo, ai fini del calcolo degli oneri concessori non è rilevante il momento in cui l’opera di cui si chiede la sanatoria è stata realizzata, né tantomeno quello in cui è presentata l’istanza di condono: ciò che rileva è il momento “finale”, in cui viene rilasciato il titolo in sanatoria e, dunque, si produce in concreto l’effetto sanante del provvedimento, cui gli oneri stessi sono intrinsecamente legati.
Il “centro abitato” e la rilevanza ai fini dell’ante ’67
 Il concetto di “ante ‘67” ha da sempre rappresentato uno degli snodi fondamentali per l’edilizia, a cavallo tra il diritto amministrativo (ad esempio, sul tema dello stato legittimo) ed il diritto civile (per gli atti di compravendita).
Il concetto di “ante ‘67” ha da sempre rappresentato uno degli snodi fondamentali per l’edilizia, a cavallo tra il diritto amministrativo (ad esempio, sul tema dello stato legittimo) ed il diritto civile (per gli atti di compravendita).
Tanto è stato detto e, ancor di più, tanto è stato scritto in giurisprudenza.
Proprio di recente, il TAR Trieste (sentenza n. 476 del 10.11.2022) ha affrontato il tema della delimitazione del “centro abitato”, concetto chiave nell’ottica dell’ante ’67.
I. L’antefatto della decisione.
Con due separati ricorsi, poi riuniti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, il proprietario di un immobile ed il titolare dell’attività commerciale ivi svolta hanno impugnato i provvedimenti sanzionatori con cui veniva (prima) inibita e (poi) ordinata la demolizione di un’ampia tettoia.
Secondo l’Amministrazione comunale, questa sarebbe illegittima perché realizzata senza alcun titolo abilitativo.
Per contro, i ricorrenti sostengono che la tettoia sia stata realizzata prima del 1967, ossia prima dell’entrata in vigore della cd. “Legge Ponte”; pertanto, all’epoca della sua edificazione non necessitava di alcun titolo edilizio.
II. La normativa di riferimento.
La Legge 6 agosto 1967 n. 765 ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per il diritto urbanistico, perché grazie ad essa è stato generalizzato per la prima volta l’obbligo di richiedere, per ogni nuova costruzione, un titolo edilizio.
Più nello specifico, il suo articolo 10 ha completamente riscritto l’art. 31 della L. 1150/1942 (su cui pure torneremo a breve), prevedendo che:
Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
Da quel momento in poi, non potevano più realizzarsi opere edili senza prima chiedere un’autorizzazione all’autorità competente.
La modifica è fondamentale, perché va ad incidere su un aspetto chiave della disciplina urbanistica, fino a quel momento tutta condensata nella Legge 17 agosto 1942 n. 1150, definita proprio “legge urbanistica”.
Prima della modifica operata nel 1967, in particolare, l’art. 31 stabiliva che
Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune.
Fino al 1967, dunque, la licenza edilizia doveva essere richiesta solo in due casi:
- a) quando l’edificio a costruirsi ovvero da modificare ricadeva “nei centri abitati”;
- b) quando il Comune aveva adottato un proprio PRG.
Fuori da tali fattispecie l’attività edilizia era sostanzialmente libera.
III. Le tesi contrapposte
Così riassunto il quadro normativo in cui si è mosso il TAR, i ricorrenti nel giudizio in esame hanno sostenuto che la tettoia è stata realizzata prima dell’entrata in vigore della “Legge Ponte”, sostanzialmente prima dell’agosto 1967; a dimostrazione di ciò, sono stati prodotti in giudizio documenti fotografici ed aerofotogrammetrie da cui risulta la risalenza nel tempo della tettoia.
Sul versante opposto, l’Amministrazione comunale si è difesa in giudizio evidenziando che, a prescindere dall’esatto momento di realizzazione dell’opera, essa ricadeva nel perimetro del “centro abitato” del Comune: ne deriverebbe, come naturale conseguenza, che per costruire la tettoia il proprietario avrebbe dovuto richiedere la licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 L. 1150/1942, come vigente ratione temporis.
IV. La decisione del TAR
Innanzitutto, il Tribunale ha considerato “rilevanti” i principi di prova addotti dai ricorrenti per dimostrare l’anteriorità dell’opera al 1967, così tracciando un primo punto fermo nella vicenda: l’opera de qua non soggiaceva all’obbligo generalizzato di richiedere la licenza edilizia.
Tanto premessa, restava da vagliare la tesi comunale circa la ricadenza dell’area nel perimetro del cd. “centro abitato”.
Anche in tal caso il TAR ha dato ragione ai ricorrenti, sostenendo che
Non è, però, dimostrato che l’edificio si trovasse, già all’epoca di realizzazione dell’opera, in area qualificabile come “centro abitato”, mancando l’evidenza di una sua perimetrazione ad opera di provvedimenti precedenti al primo piano regolatore. In assenza di una sua formale identificazione ad opera dell’autorità, la nozione di “centro abitato” deve ricollegarsi a dati fattuali ed empirici (Cons. St., sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656), che dovevano essere esaminati e valutati dall’amministrazione alla luce del contesto esistente al momento dell’intervento.
Richiamando, dunque, un precedente del Consiglio di Stato (ma il principio è, comunque, granitico nella giurisprudenza amministrativa), il TAR Trieste ha ricordato come la nozione di “centro abitato” deve essere “riempita” di volta in volta dai Comuni, o attraverso un provvedimento che materialmente perimetri l’area di riferimento, oppure laddove emergano dati “fattuali ed empirici” dai quali si possa desumere l’effettiva esistenza di un “centro abitato”.
Di conseguenza, nel caso di specie il Tribunale ha concluso per la non necessità di ottenere la licenza edilizia e, dunque, per la non abusività della tettoia, perché il complessivo stato dei luoghi ove ricadeva l’opera era tale da far propendere per l’esclusione della ricadenza nel “centro abitato” del Comune.
V. Osservazioni conclusive
Spesso ci si innamora con troppa facilità della tesi dell’ante ’67, incorrendo nell’errore che tutto ciò che è stato costruito prima dell’agosto del 1967 non era soggetto al rilascio di una licenza edilizia.
Ma non è così!
È necessario sempre e comunque verificare se, al momento dell’edificazione, ricorrevano i presupposti di cui alla Legge Urbanistica del 1942 (come vigente prima della “Legge Ponte”), che già prevedeva la necessità di conseguire, in determinate e tipizzate fattispecie, il titolo edilizio.