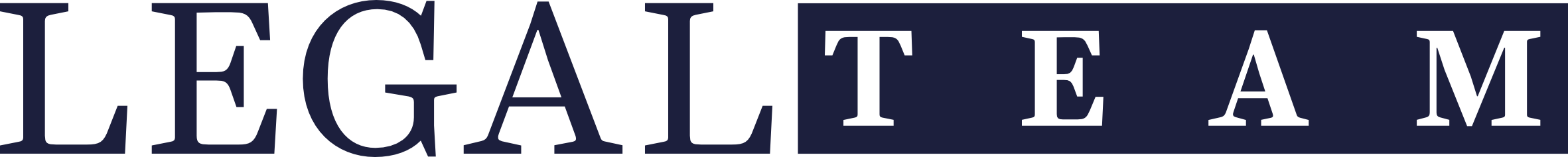Sanatoria sismica: dal Consiglio di Stato il via libera.
 Di sanatoria sismica (o strutturale) avevamo trattato approfonditamente in un precedente contributo, nel quale, da un lato avevamo evidenziato l’esistenza di una chiusura da parte della giurisprudenza (soprattutto, ma non solo, penale) e, dall’altro, avevamo manifestato diversi elementi interpretativi, sistematici e “di ragionevolezza”, i quali conducono, a nostro avviso, a poter teorizzare la sussistenza di tale peculiare autorizzazione postuma (pur in assenza di un quadro normativo univoco).
Di sanatoria sismica (o strutturale) avevamo trattato approfonditamente in un precedente contributo, nel quale, da un lato avevamo evidenziato l’esistenza di una chiusura da parte della giurisprudenza (soprattutto, ma non solo, penale) e, dall’altro, avevamo manifestato diversi elementi interpretativi, sistematici e “di ragionevolezza”, i quali conducono, a nostro avviso, a poter teorizzare la sussistenza di tale peculiare autorizzazione postuma (pur in assenza di un quadro normativo univoco).
Segnaliamo sul tema una recentissima sentenza del Consiglio di Stato che, con un articolato percorso motivazionale, “sposa” in pieno le “nostre” tesi, riconoscendo la legittimità della sanatoria sismica, ponendosi in antitesi con i più recenti e restrittivi arresti della Cassazione penale.
Si tratta della sentenza della Sezione II, 23.4.2024, n. 3645.
La decisione del Consiglio di Stato al riguardo muove dal più che condivisibile rilievo per cui la ammissibilità della c.d. sanatoria sismica o strutturale è “tematica di estrema complessità e delicatezza, che sconta le difficoltà derivanti da innegabili lacune normative, a fronte delle quali l’interprete è chiamato ad individuare una lettura che contemperi l’effettività del regime delle sanatorie con la necessità di non abbassare minimamente la soglia della tutela dell’incolumità pubblica in un Paese il cui territorio si connota notoriamente per l’estensione delle zone vulnerabili da un punto di vista sismico”.
Due, in particolare i profili toccati da questa – storica per gli addetti al settore – decisione del Consiglio di Stato:
I. La sanatoria sismica/strutturale esiste.
II. Il coordinamento tra procedimento penale e procedura amministrativa.
Vediamo, nel dettaglio, il ragionamento e le conclusioni del Consiglio di Stato.
I. La sanatoria sismica esiste.
Il Consiglio di Stato, poi, prosegue ricordando che “il d.P.R. n. 380 del 2001 non contempla espressamente alcuna procedura di sanatoria c.d. strutturale, ovvero riferita alla mancata denuncia preventiva o alla mancata richiesta di autorizzazione sismica di cui agli artt. 65, 93 e 94″ anzi disciplinando tali regimi abilitativi solo nella loro forma ex ante.
Fatta tale premessa, la decisione passa a trattare il cuore della questione, ossia il rapporto tra l’iter di sanatoria edilizia ex art. 36 D.P.R. 380/01, interrogandosi, appunto, sulla possibilità di acquisire l’atto abilitativo sismico/strutturale in via postuma.
La risposta positiva alla questione – in assenza di puntuali norme al riguardo – viene fornita sulla base di diversi argomenti che, come detto, risultano in linea con quanto avevamo avuto modo di osservare nel nostro precedente contributo in chiave critica rispetto alla chiusura proveniente dalla recente giurisprudenza della Cassazione penale.
Un primo argomento viene tratto dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 101/2013 e 2/2021) la quale a più riprese ha avuto modo di sancire l’illegittimità di quelle legislazioni regionali che, ai fini del rilascio del permesso ex art. 36 D.P.R. 380/01, avevano introdotto deroghe al principio della “doppia conformità”, anche dal punto di vista strutturale.
A tal proposito, del tutto logicamente e condivisibilmente, il Consiglio di Stato evidenzia che alla stregua della giurisprudenza costituzionale
“di fatto, dunque, si è a contrario ammessa espressamente la sanatoria sismica, purché essa consegua all’accertamento della conformità delle strutture alle norme tecniche vigenti sia al momento dell’adozione del provvedimento sanante (secondo l’ordinario canone del tempus regit actum), sia al momento della realizzazione dell’opera, in estensione della previsione (in verità eccezionale) della doppia conformità edilizia alla diversa ipotesi di assenza del (o difformità dal) titolo sismico”
Assolutamente apprezzabile è poi il passaggio – pragmatico e “di buon senso” – nel quale la sentenza rileva che
“Negando in toto l’ammissibilità di un’autorizzazione sismica postuma, infine, essendo considerazione nota l’estensione del territorio soggetto alla relativa tutela in Italia, si rischierebbe di addivenire ad una sorta di interpretatio abrogans dell’art. 36 del T.u.e., in fatto difficilmente utilizzabile“
II. Il procedimento: un tentativo di coordinamento razionale tra iter penale e procedura amministrativa di sanatoria.
Degno di nota anche lo sforzo che il Consiglio di Stato compie al fine di coordinare i due procedimenti, penale ed amministrativo, che si intersecano ai fini della “sanatoria sismica”.
Come è noto, la prassi oggi invalsa (in assenza di una compiuta disciplina procedimentale amministrativa) è quella di “sospendere” l’iter di regolarizzazione edilizia fino alla definizione del procedimento penale.
Il Consiglio di Stato, al riguardo, evidenzia in primo luogo che:
“l’art. 98, comma 3, del Testo unico, ammette esplicitamente la regolarizzazione dell’abuso in materia sismica, laddove consente al giudice penale di impartire, in luogo della demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme antisismiche, le prescrizioni necessarie per renderle conformi alle stesse, fissando il relativo termine. Di fatto, dunque, non solo è possibile un’integrazione documentale postuma, ma finanche un adeguamento strutturale, stante che la norma riferisce l’adeguamento alle opere, non alle pratiche, che il giudice disporrà avvalendosi necessariamente delle competenze tecniche di specialisti del settore. Se così è, non si comprende per quale ragione l’Amministrazione preposta al controllo di settore non possa muoversi anticipatamente almeno sotto il profilo del vaglio della rispondenza sostanziale dell’intervento ai previsti requisiti di sicurezza, laddove la parte si attivi in tal senso e se ne assuma la responsabilità producendo tutta la necessaria documentazione a supporto“.
A valle di tale rilievo, la sentenza mette in evidenza che
“il controllo postumo della regolarità sismica/strutturale, ove richiesto dalla parte, attivando il relativo procedimento- risponde essa pure a principi di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., nonché di economicità ed efficacia presidiati dall’art. 1 della l. n. 241/1990. Esso peraltro, in quanto si risolve in un controllo di conformità sostanziale anche alla luce delle sopravvenienze normative alla realizzazione dell’abuso, pare rispondere maggiormente alle esigenze di tutela dell’incolumità pubblica, che presuppongono intrinsecamente celerità di risposta, rispetto ad una valutazione delle stesse differita all’esito, non sempre egualmente veloce, del procedimento penale”.
Circa la competenza a definire l’iter di sanatoria amministrativa da parte del Genio Civile, il Consiglio di Stato osserva che “la stessa Amministrazione titolare del potere di legittimare ex ante un’attività non può non essere titolare anche del potere (implicito) di verificarne ex post i medesimi presupposti di legittimazione, ovvero quelli più stringenti medio tempore sopravvenuti“.
Sempre sul versante procedimentale, poi, la decisione accenna alla questione del coordinamento tra l’iter di sanatoria sismica/strutturale ed il meccanismo del diniego per silentium ex art. 36 D.P.R. 380/01, atteso che “l’ammissibilità di una denuncia sismica ex post, ovvero di un’analoga richiesta tardiva di autorizzazione, per potersi inserire nel procedimento di sanatoria deve in qualche modo produrre l’effetto di interrompere o quanto meno sospendere il termine di formazione del silenzio rifiuto“.