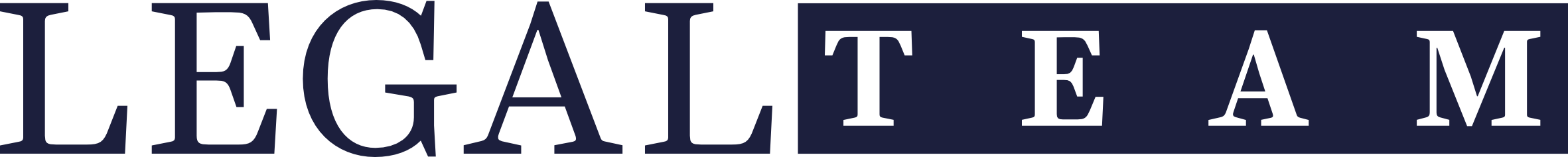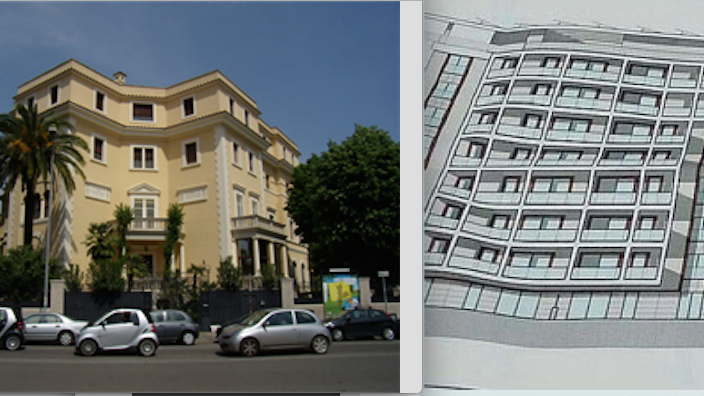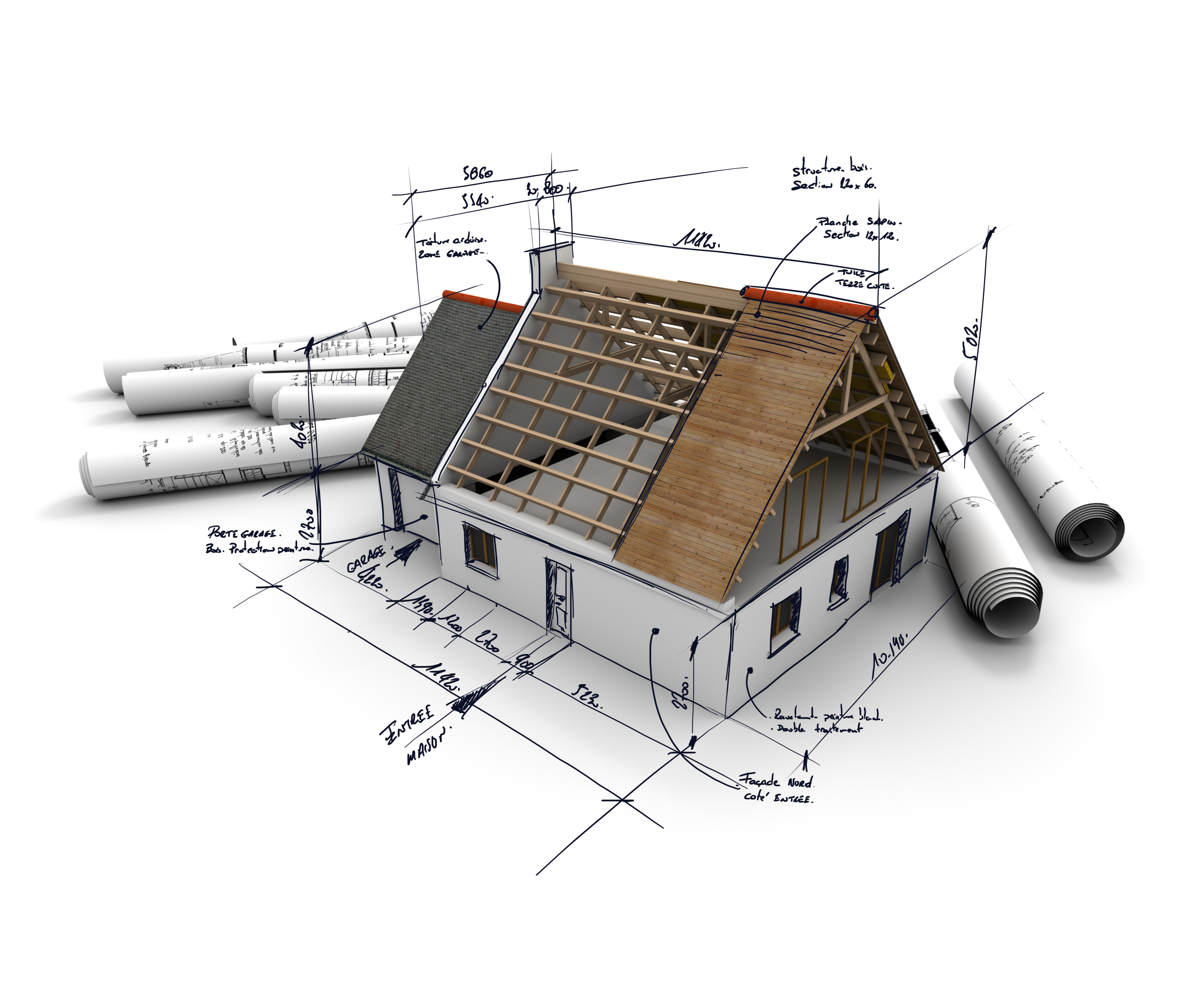Carenza di un requisito (DURC irregolare) in capo all'ausiliaria: che succede?
 L'art. 89, co. 3, del Codice dei Contratti prevede che la Stazione appaltante "impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione".
L'art. 89, co. 3, del Codice dei Contratti prevede che la Stazione appaltante "impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione".
Tale disposizione è oggetto di due contrapposte interpretazioni.
Secondo un primo orientamento "in caso di attestazione mendace del possesso dei requisiti ex articolo 80 da parte dell’ausiliaria, si applica l’articolo 89, comma 1, e la sanzione è l’esclusione del concorrente dalla gara; l’articolo 89, comma 3, trova invece applicazione nel caso di perdita dei requisiti (esistenti alla data della dichiarazione del loro possesso)" (TAR Lazio, Latina, Sez. I, 29.12.2017, n. 652).
Dunque, in tale prospettiva l'originaria carenza del requisito (e la sua falsa attestazione) in capo all'ausiliaria, in fase di gara ricadono sull'operatore economico partecipante alla stessa, mentre la possibilità di sostituzione dell'ausiliaria opererebbe solo in caso di perdita del requisito in un momento successivo alla dichiarazione.
A conclusioni diametralmente opposte è giunta, invece, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 26.4.2018, n. 2527.
In questo caso, in corso di procedura era emerso che l'ausiliaria dell'aggiudicataria non era in regola con il DURC (come invece dichiarato in sede di partecipazione). La SA ha, tuttavia, consentito all'ausiliaria, tramite richiesta rivolta alla concorrente, di regolarizzare tale posizione.
Secondo il TAR Marche, adito dalla seconda graduata, tale scelta della SA sarebbe stata legittima, poiché correttamente quest'ultima ha valutato le circostanze di fatto che avevano condotto l'istituto previdenziale a negare la regolarità contributiva, pervenendo alla conclusione che "un operatore economico non può subire le deleterie conseguenze legate alla perdita dell’aggiudicazione di un appalto pubblico (a cui spesso si aggiungono anche l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC) a causa dell’emissione di un d.u.r.c. negativo fondato su pretese unilaterali dell’istituto previdenziale, non risultanti da atti amministrativo o sentenze inoppugnati".
Sicché,secondo il Giudice di primo grado, legittimamente la SA aveva ammesso la regolarizzazione.
La decisione, poi, aggiunge che "comunque" l'aggiudicataria non sarebbe stata passibile di provvedimento di esclusione ma, tutt'al più, la SA avrebbe dovuto ordinare la sostituzione dell'ausiliaria. Da ciò inferendo una sostanziale indifferenza della "via" tramite la quale l'aggiudicazione non è stata rimossa.
Il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione.
Il Giudice di appello ha, in primo luogo, ribadito il principio per cui "la stazione appaltante che, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, riceve dall’ente previdenziale comunicazione di D.U.R.C. irregolare è tenuta ad escludere l’operatore dalla procedura, revocando l’aggiudicazione eventualmente effettuata, senza procedere al previo invito alla regolarizzazione" (come sancito dall'Ad. Plenaria sentenza n. 6/2016). Da cui la riforma della decisione di primo grado in punto di "regolarizzabilità del DURC".
Il Consiglio di Stato, dichiarata l'illegittimità della regolarizzazione intervenuta, afferma poi che la SA avrebbe dovuto richiedere all'aggiudicataria di sostituire l'ausiliaria, con conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, consolidatosi in assenza di tale obbligatorio passaggio (ossia, senza la sostituzione dell'ausiliaria).
A tale conclusione la decisione perviene tramite un attento esame dell'art. 89, co. 3, del Codice.
Tale norma, rileva la sentenza, "consente (anzi, impone) la sostituzione anche nell’ambito di rapporto tra imprese scaturito dalla stipulazione di un contratto di avvalimento ed anche nella fase precedente l’esecuzione del contratto (...)", notando che "la sostituzione dell’ausiliaria durante la procedura è istituto patentemente derogatorio al principio dell’immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura (nonché di coloro di cui intende avvalersi: e, per questa via, della stessa offerta), ma risponde all’esigenza stimata superiore di evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili e, in questo modo, sia pure indirettamente, stimolare il ricorso all’avvalimento: il concorrente, infatti, può far conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per solo questo fatto, escluso".
Esclusa la possibilità di disporre il subentro nel contratto (visto lo stato di avanzamento delle opere oggetto dell'appalto), il Consiglio di Stato ha riconosciuto all'appellante il risarcimento del danno per equivalente, limitando, tuttavia, la sua quantificazione in proporzione alle effettive probabilità che questa avrebbe avuto di ottenere il contratto laddove la SA avesse correttamente operato.
In particolare, il Giudice di appello ha rilevato che, molto probabilmente, laddove la SA avesse chiesto all'aggiudicataria di sostituire l'ausiliaria, questa avrebbe senz'altro proceduto in tal senso. L'ipotesi contraria (ossia che l'aggiudicataria non procedesse in tal senso) era piuttosto improbabile (stimata, percentualmente, dal Giudice, come pari al 20%).
Questo, in particolare, il ragionamento seguito dal Cons. Stato in sede di quantificazione:
- "considerato che, da un lato, la regolarizzazione è stata richiesta quando l’offerta dell’appellante era già stata considerata valida e inserita al secondo posto della graduatoria, ma, d’altro canto, valutato che, se l’amministrazione avesse richiesto la sostituzione dell’ausiliaria, è oggettivamente ipotizzabile – secondo l’id quod plerumque accidit e a parità dei restanti fattori - che Ambrosetti Group s.r.l. si sarebbe attivata individuando un’impresa ausiliaria idonea, è possibile concludere che l’appellante aveva una concreta chance di aggiudicazione del contratto (quantificabile, a far ricorso alla sintesi percentuale, intorno al 20 %) e dunque, non “mera possibilità di conseguire l’utilità sperata” .
- quindi, "considerato che il ribasso offerto dall’appellante, pari al 23,245% sul valore dell’appalto, era sostanzialmente equivalente al ribasso offerto dall’aggiudicataria (pari a 23,750%) onde, come si evince dal contratto stipulato, la società Gaspari Gabriele s.r.l. avrebbe svolto i lavori ricevendone il corrispettivo di € 1.567.498,65, avendo conto dell’utile che normalmente avrebbe potuto trarre - che non potrà stimarsi superiore al dieci per cento del valore a base d’asta (€ 156.749,86) - ed applicando ad esso la percentuale della chance precedentemente esposta (20%), il Collegio giunge ad individuare nella somma di € 31.349,97 il mancato guadagno a tale titolo (secondo il modello enunciato già da Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2012, n. 5279)".
Pregresse risoluzioni contrattuali ed esclusione dalla gara ex art. 80 co. 5, lett. c): soluzioni e dubbi del Giudice Amministrativo.
 Come noto, l'art. 80, co. 5, lett. c), del Codice prevede - quale possibile causa di esclusione dalle gare - l'ipotesi di "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio" .
Come noto, l'art. 80, co. 5, lett. c), del Codice prevede - quale possibile causa di esclusione dalle gare - l'ipotesi di "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio" .
- Prima tesi: se la risoluzione è sub iudice alla SA è inibito escludere l'OE.
Nella prima interpretazione della norma era stato ritenuto che la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la risoluzione contrattuale impedisse tout court alla Stazione Appaltante di escludere il concorrente.
In tal senso, ad esempio, si era espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2017, n. 1955 secondo cui "sulla base dell’interpretazione letterale della norma (ex art. 12 delle preleggi) si richiede quindi che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale. E questa conferma non può che essere data da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) «all’esito di un giudizio».
E' appena il caso di segnalare che le Linee Guida n. 6 dell'ANAC (cfr. paragrafo 2.2.1.1) sembrano seguire tale linea interpretativa, considerando solo "la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio".
2. Seconda tesi: in presenza di contestazione giudiziale della risoluzione, l'esclusione è comunque possibile, con motivazione specifica.
L'orientamento, tuttavia, è tutt'altro che pacifico e, di recente, si registrano sia posizioni opposte a quella ora menzionata sia dubbi di conformità dell'art. 80, co. 5, lett. c) alla Direttiva appalti UE del 2014.
Così, secondo il C.G.A.R.S. 30.4.2018, n. 252 "la norma in questione, (...), consente l’esclusione, invero, al di là delle tipizzazioni che pur ne costituiscono il nucleo (...), anche in tutti i casi in cui “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.”, sicché "a un’impresa non basta aver contestato in giudizio la risoluzione contrattuale subìta per porsi completamente al riparo, per tutta la durata –per giunta, prevedibilmente cospicua- del processo, dal rischio di esclusioni da gare d’appalto indotte dalla relativa vicenda risolutoria".
In tal caso, quindi, "alla Stazione appaltante non è precluso applicare ugualmente la causa di esclusione in discussione", a condizione, però, "che essa sia appunto in grado di far constare con i necessari supporti probatori, e con motivazione adeguata, la effettività, gravità e inescusabilità degli inadempimenti dell’impresa, e perciò, correlativamente, la mera pretestuosità delle contestazioni da questa sollevate in giudizio avverso la misura risolutoria, oltre che, naturalmente, la dubbia “integrità o affidabilità” del medesimo operatore".
Dunque, in tale prospettiva, in presenza di una risoluzione contrattuale sub-iudice, l'art. 80, co. 5, lett. c), sarebbe da interpretare nel senso che la SA potrebbe comunque escludere il concorrente, previa, però una più stringente motivazione sulla rilevanza delle vicende che hanno condotto alla risoluzione stessa.
3. Terza tesi: il dubbio di conformità dell'art. 80, co. 5, lett. c) rispetto alla Direttiva appalti.
Infine, con una ancor più recente decisione, il Consiglio di Stato, Sez. V, ord., 3.5.2018, n. 2639 (così come, in precedenza, il TAR Campania, Napoli, Sez. IV, ord., 13.12.2017, n. 5893) ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE.
Il "dubbio" sottoposto alla CGUE è "se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio".
Al riguardo, il Consiglio di Stato, nell'ordinanza in parola, evidenzia come l'interpretazione più garantista per il concorrente (ossia: l'automatica irrilevanza delle pregresse risoluzioni finché sub iudice) sembrerebbe porsi in contrasto con il Considerando n. 101 della Direttiva, secondo il quale "le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l'operatore economico ha violato i suoi obblighi".
Da segnalare, peraltro, come, nel valorizzare tale passaggio del Considerando, il Consiglio di Stato interpreti lo stesso in senso diametralmente opposto a quanto ritenuto, invece, nella sentenza n. 1955/2017 ("prima tesi"), dove, invece, era stato affermato - senza esitazioni o dubbi - che non giova "richiamare il considerando 101, laddove si fa riferimento alla possibilità di escludere dalla gara l’operatore economico in caso di «grave violazione dei doveri professionali», dimostrata dall’amministrazione «con qualsiasi mezzo idoneo», «prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori». Quest’ultima previsione è infatti espressamente riferita ai motivi di esclusione «obbligatori», ovvero a quelli previsti dall’art. 57 della direttiva, ai paragrafi 1 e 2, mentre nel caso di specie si verte nelle ipotesi contemplate dal paragrafo 4 della medesima disposizione. Per essa vale dunque il rinvio a «qualsiasi mezzo idoneo», che il legislatore nazionale nell’esercizio della sua discrezionalità rispetto ad un ambito del diritto dei contratti pubblici non vincolato a livello europeo può ritenere integrato solo in presenza di una decisione giurisdizionale definitiva, come avvenuto nel caso di specie con l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016".
"Conclusioni"
Il quadro appena tracciato, che vede "costanti e imprevedibili oscillamenti" del massimo organo della Giustizia Amministrativa, rende evidente come solo la decisione della Corte di Giustizia potrà indirizzare - si spera definitivamente - l'interpretazione della disposizione in esame, a beneficio di SA ed OE.
L’art. 6 della L.R. Lazio n. 7/2017 sulla rigenerazione urbana e la demolizione e ricostruzione dei villini a Roma. Alcune considerazioni strettamente giuridiche sul “governo della rigenerazione” da parte di Roma Capitale.
 L’affaire “Villa Paolina” ha aperto il dibattito, politico, tecnico e urbanistico, su quali limiti incontrino gli interventi di demolizione e ricostruzione, con premialità di cubatura sino al 20%, oggi ammessi dall’art. 6 della legge laziale sulla rigenerazione urbana nel territorio di Roma.
L’affaire “Villa Paolina” ha aperto il dibattito, politico, tecnico e urbanistico, su quali limiti incontrino gli interventi di demolizione e ricostruzione, con premialità di cubatura sino al 20%, oggi ammessi dall’art. 6 della legge laziale sulla rigenerazione urbana nel territorio di Roma.
In primo luogo, occorre ricordare che lo specifico intervento di cui si tratta, risulta (dalle notizie “di stampa”) essere stato richiesto ed assentito in base al Piano Casa di cui alla L.R. 21/2009 e s.m.i., il cui art. 4 ammetteva interventi di “sostituzione edilizia”, da attuare con demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico.
- Centro storico, Carta della Qualità e Piano Casa
La L.R. 21/2009 ammetteva interventi in deroga al PRG ma, al contempo, consentiva ai Comuni di individuare “ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo” (art. 2, co. 4).
Dunque, oltre alle diverse esclusioni previste dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. 21/2009, gli interventi previsti dal Piano Casa, erano suscettibili di essere limitati o esclusi, tramite precise e motivate scelte di governo del territorio da parte del Comune.
Sicché, quanto ai centri storici, era – espressamente – possibile che si cumulassero, ai fini della non applicabilità del Piano Casa, sia le aree escluse ex lege, in quanto ricadenti “nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR)” (art. 2, co. 2, lett. a) L.R. 21/2009), sia ulteriori ambiti (o immobili) individuati dai Comuni.
Roma Capitale, esercitando tale potere espressamente rimessole dalla legge regionale, era intervenuta con la delibera n. 9/2012 (“Disposizioni in ordine all'attuazione del Piano Casa della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 21/2009, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 10 e 12 del 2011) in particolare individuando sia ulteriori aree nelle quali non era possibile intervenire con il Piano Casa, sia alcune limitazioni “procedurali”.
Tra queste, ai fini che qui rilevano, erano stati prescritti divieti o, comunque, necessità di pareri per interventi relativi a immobili ricompresi nella “Carta della Qualità”
Secondo la giurisprudenza del TAR Lazio, “la “Carta per la Qualità” è un elaborato non prescrittivo del PRG, qualificato come gestionale per contenuto e finalità: (…)” dovendosi altresì evidenziar che “gli elaborati gestionali (…) - tra i quali rientra anche la “Carta per la Qualità” Elaborato G1, hanno una funzione complementare agli elaborati prescrittivi (NTA, Sistemi e Regole, Rete Ecologica), posto che attengono alla struttura organizzativa e individuano gli elementi (a….) che ricadono nelle componenti di PRG, elementi che rendono concretamente realizzabili le previsioni del Piano, di cui costituiscono parte integrante” (Sez. II-bis, 10.3.2014, n. 2744).
Si tratta, quindi, di una componente del PRG, con la quale il Comune ha esercitato, “alla luce dei parametri espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. n.378 del 2000)” il potere generale “di individuazione di ambiti di tutela al di là della sottoposizione a vincolo degli immobili (…) in relazione ad esigenze particolari e locali”, imponendo “limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali”, tutelando così il tessuto urbanistico al rispetto dei valori culturali-storico e architettonici,che assumono rilievo come “qualità” dei Tessuti ed edifici oggetto di tutela specifica” (così sempre TAR Lazio 2744/2014, cit.).
Ecco perché, con facoltà espressamente riconosciuta dalla L.R. 21/2009 (il citato art. 2, co. 4), Roma Capitale aveva circoscritto – con la Delibera 9/2012 – e limitato l’applicazione del Piano Casa regionale facendo riferimento, tra l’altro, ad aree ed immobili tutelati dalla Carta Qualità, così evitando l’operatività in deroga al PRG della speciale disciplina regionale.
In concreto si era previsto, tra l’altro, che, per le istanze di Piano Casa relative ad immobili tutelati dalla Carta Qualità, occorresse il previo parere di una apposita Commissione, secondo il procedimento delineato dalla D.D. prot. 25840 del 13.12.2012 (“Procedura per la valutazione delle proposte di intervento di cui al Capo II della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii. dei beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del P.R.G. Vigente”).
- Centro storico, art. 6 L.R. 7/2017 e Carta per la Qualità.
La L.R. 7/2017, pur ammettendo operazioni di trasformazione edilizia in parte similari, presenta un impianto differente rispetto alla L.R. 21/2009 sul Piano Casa.
L’art. 6 della L.R. 7/2017 costituisce la norma che, per così dire, “raccoglie l’eredità” del Piano Casa, ammettendo – in deroga agli strumenti urbanistici comunali – interventi di demolizione e ricostruzione, con ampliamento di cubatura sino al 20% e possibili mutamenti di destinazione d’uso (per un esame complessivo della disciplina in questione si rinvia al video già pubblicato).
In base a tale norma, senza che sia previsto espressamente dalla legge alcun previo atto deliberativo comunale (come nel caso, invece,degli articoli 4 e 5, anch’essi aventi ad oggetti interventi “diretti”), “sono sempre consentiti (…) interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente” (co. 1). Quanto ai centri storici il comma 6 prevede l’esclusione degli insediamenti urbani storici del PTPR (ambito che, si ricorda, era escluso anche dalla L.R. 21/2009).
Come rilevato, la L.R. 7/2017 non riconosce, in capo al Comune, alcuna facoltà di intervenire, con specifico riferimento all'art. 6 in parola, per limitare o escludere ulteriormente la possibilità di operare tramite gli interventi ivi disciplinati e ciò in evidente discontinuità rispetto alla previsione generale della L.R. 21/2009 che consentiva agli enti locali di individuare “ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, (…), limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo” (così il già citato art. 2, co. 4).
Ad oggi, dunque, a fronte di una istanza di demolizione e ricostruzione di un fabbricato non ricadente negli insediamenti urbani storici del PTPR ma oggetto di tutela da parte della Carta della Qualità, di quali poteri dispone Roma Capitale?
Si è prima rammentato che la Carta per la Qualità costituisce un elaborato integrante il PRG.
Tanto lascia intendere che, se gli interventi ex art. 6 L.R. 7/2017 sono assentibili in deroga allo strumento urbanistico comunale, allora la deroga in parola non può che incidere anche sulle previsioni risultanti dalla Carta per la Qualità.
D’altra parte, la L.R. 7/2017 laddove ha ritenuto “opportuno” affidare ai Comuni strumenti di tutela specifici, atti a governare e limitare l’applicazione degli istituti di rigenerazione, lo ha fatto in maniera espressa: l’esempio più chiaro è l’art. 4, sui cambi di destinazione d’uso.
La norma consente interventi di ristrutturazione edilizia (anche con demolizione e ricostruzione) finalizzati al cambio di destinazione d’uso (in questo caso senza alcun premio di cubatura).
Il “ruolo” degli atti comunali, in questo istituto, è ben delineato: “i comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale (…) possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, (…), l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici (…) con mutamento della destinazione d’uso (…)”.
Viene, poi, dettato un regime transitorio: fino al 18.7.2018 – anche in assenza della deliberazione di consiglio comunale – è possibile porre in essere gli interventi in questione (con alcune specifiche limitazioni).
Analogamente, l’art. 5 “(Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici”) subordina la possibilità di porre in essere gli interventi ivi contemplati (ampliamento) all’adozione di una specifica delibera di consiglio comunale.
Le due norme, quindi, offrono un indice per poter affermare che, al contrario, non prevedendo la legge alcuno strumento che garantisca al Comune di “regolare” gli interventi di cui all’art. 6, sia più che dubbia la possibilità di porre in essere atti regolamentari in tal senso.
- Osservazioni sulla c.d. Direttiva Montuori
In questo quadro, un cenno merita la Direttiva n. 10 del 19.2.2018 dell’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale.
Tale atto prende in considerazione (oltre agli artt. 2 e 3) l’art. 4 (cambi di destinazione d’uso) affermando (disponendo?) che, nelle more dell’adozione di provvedimenti previsti dalla norma in parola, “è consentito il cambio di destinazione d’uso esclusivamente nei tessuti della città della trasformazione con esclusione degli edifici e degli ambiti individuati nella Carta della Qualità; sono temporaneamente sospesi gli interventi in tutti i tessuti della città storica e nella città consolidata”.
La direttiva è di difficile coordinamento con l’art. 4 della L.R. 7/2017, per diverse ragioni.
La prima è che la disciplina transitoria relativa all’ammissibilità degli interventi contemplati dalla disposizione in questione è dettata direttamente dalla L.R. 7/2017 e appare di più che dubbia legittimità ed efficacia cogente un intervento, sotto forma di “direttiva”, che limiti gli interventi direttamente ammessi dalla legge. L’art. 4, infatti, contempla (ed ammette) come fonte regolamentare atta a regolare l’assentibilità degli interventi in questione la delibera di consiglio comunale.
La seconda ragione è di “merito”: la direttiva (non una delibera consiliare, come detto) esclude, sin da subito, la possibilità di intervenire su edifici ed immobili ricompresi nella Carta della Qualità (nonché in alcuni particolari ambiti) così “derogando” a quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale.
Infine, la temporanea sospensione degli interventi “in tutti i tessuti della città storica e nella città consolidata”, oltre a porsi in contrasto con la disciplina transitoria contenuta dall’art. 4 della L.R. 7/2017, pare introdurre un’atipica (e, quindi, illegittima) misura di salvaguardia, disposta, peraltro, con un atto (la direttiva) inidoneo allo scopo.
- Conclusioni: le proposte dell’INU
Nel dibattito di questi giorni, si registra la presa di posizione dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, con alcune proposte , atte a consentire la salvaguardia dei “villini” di inizio novecento siti a Roma e non ricadenti nelle aree in cui, in base alla legge regionale n. 7 del 2017, è esclusa la possibilità di intervenire ex art. 6 della stessa.
La prima proposta, rivolta alla Regione, concerne la modifica dell’art. 6 della L.R. 7/2017, con estensione dell’esclusione anche alle zone omogenee A individuate dai PRG.
Evidentemente, tale modifica risolverebbe la questione a monte.
La seconda proposta, indirizzata all'Amministrazione capitolina, è quella di deliberare, tra l’altro, la esclusione dalla applicazione della L.R. 7/2017 dei tessuti a villini di Roma.
La soluzione proposta, ricalca, a ben guardare, quanto avvenuto nella vigenza del Piano Casa, con la differenza, tuttavia, che la L.R. n. 21/2009 “autorizzava” espressamente i Comuni ad intervenire in tal senso (con il già menzionato art. 2, co. 4).
Pertanto, pare, a chi scrive, che tale soluzione sarebbe di dubbia legittimità, mancando, nella L.R. 7/2017 un'analoga previsione.
Inoltre, la L.R. 7/2017 prevede chiaramente che “gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale” e ha individuato un preciso spazio riservato ai Comuni (con le “delibere” di cui agli artt. 4 e 5, ad esempio).
Una deliberazione che incidesse in maniera diretta – limitandola o escludendola – sull'applicazione dell’art. 6 della L.R. 7/2017 porrebbe, allora, un serio problema di compatibilità rispetto alla legge regionale stessa.
La strada da percorrere, in coerenza peraltro con quanto previsto per gli interventi contemplati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 7/2017, sembra essere, allora, quella di attribuire – espressamente – ai Comuni la possibilità di individuare aree, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla legge, nelle quali vietare o limitare le ristrutturazioni tramite demolizione e ricostruzione.
A quali condizioni la trasformazione societaria di un componente del RTI non determina il mutamento della composizione soggettiva del raggruppamento?
 Con la sentenza del 17/04/2018 n. 328, il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato sugli effetti delle trasformazioni societarie che coinvolgano un componente di un RTI tra il momento della presentazione dell'offerta e la fase di aggiudicazione.
Con la sentenza del 17/04/2018 n. 328, il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato sugli effetti delle trasformazioni societarie che coinvolgano un componente di un RTI tra il momento della presentazione dell'offerta e la fase di aggiudicazione.
La fattispecie, contestata dal secondo graduato, è la seguente: una impresa, costituita in forma di s.a.s., partecipa ad una gara quale mandante.
Nel corso della procedura l'operatore economico in questione subisce la trasformazione in s.r.l.
La seconda graduata, rilevando la discrasia "formale" tra i componenti del RTI in sede di offerta e quelli, invece, risultanti nel provvedimento di aggiudicazione, impugna quest'ultimo eccependo la violazione del principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti di imprese.
La censura è stata, tuttavia, rigettata dal TAR.
Secondo la sentenza, infatti, risulta dirimente il rilievo che "non vi è stata alcuna modificazione della compagine della Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, risultando intervenuta, invece, la mera trasformazione sociale della mandante da s.a.s. a s.r.l., essendo rimasti peraltro immutati gli altri parametri, quali la compagine sociale, la sede, l’oggetto sociale e la durata, con mantenimento in capo alla s.r.l. di tutti i beni sociali della s.a.s. come stimati da una perizia asseverata, nonché lo stesso codice fiscale/partita I.V.A".
A ciò si aggiunge, nel ragionamento del TAR, la circostanza che "la concorrente abbia comunicato alla stazione appaltante detta trasformazione (v. doc. n. 4 del Comune) e che l’amministrazione comunale abbia effettuato i dovuti controlli, in ordine, appunto, all’effettivo mantenimento dei suddetti parametri in capo alla società di capitali, come in effetti risulta riportato nella visura storica effettuata presso la C.C.I.A.A.".
In presenza di simili condizioni oggettive (l'essersi trattato di una mera trasformazione sociale, con mantenimento di tutti gli altri parametri rilevanti) non può parlarsi di una modifica soggettiva dell'operatore economico e del RTI; inoltre, la condotta trasparente del concorrente (che ha dato notizia alla SA di quanto avvenuto) esclude pure che la fattispecie possa rilevare, come dedotto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice (in ipotesi l'aver fornito "anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione").
Avvalimento "a cascata": l'interpretazione restrittiva del Consiglio di Stato.
 Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione V, 2.3.218, n. 1295 , è intervenuto sull'istituto - di incerta definizione normativa - dell'avvalimento a cascata.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione V, 2.3.218, n. 1295 , è intervenuto sull'istituto - di incerta definizione normativa - dell'avvalimento a cascata.
La peculiare fattispecie dalla quale è scaturita la decisione in parola (che ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado) è la seguente:
- partecipa ad una gara un RTI con mandanti A e B e mandataria C;
- la mandante A presta, quale ausiliaria, una quota di fatturato specifico, alla mandante B, ausiliata;
- a sua volta, A, a quel punto carente - in parte - del fatturato specifico - sottoscrive con l'impresa D (esterna al RTI e non partecipante alla gara) un contratto di avvalimento, in base al quale quest'ultima, come ausiliaria, presta ad A la porzione di requisito venuta meno.
In primo grado, il TAR Lazio (sentenza n. 10345/2017) aveva ritenuto che l'operazione sopra descritta violasse il divieto di avvalimento a cascata di cui all'art. 89, co. 6, del Codice, a mente del quale "l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto”.
Al contrario, il Consiglio di Stato ha ritenuto che per aversi avvalimento "a cascata" e, quindi, incorrere nel divieto in questione, occorre che " la "interruzione del rapporto immediato e diretto tra ausiliaria e ausiliata" con conseguente "’allungamento della catena dei subausiliari che costituisce il proprium dell’avvalimento “a cascata” e che ne giustifica il divieto”. Occorre, sotto altro punto di vista, che venga meno "il dovuto rapporto diretto e immediato tra ausiliaria e ausiliata”, con pregiudizio, dunque, alla responsabilità solidale che l'art. 89 del Codice vuole garantito in favore della Stazione Appaltante.
Seguendo questa logica, il Consiglio di Stato ha così ritenuto l'operazione posta in essere - sopra schematizzata - non determini una ipotesi di avvalimento a cascata.
Per un approfondimento si rinvia al commento pubblicato su Italiappalti.
Gerarchia tra gli atti della lex specialis e chiarimenti interpretativi della SA
 Il TAR Lazio, con la sentenza 31.1.2018 n. 1139, ha ribadito alcuni interessanti principi operativi in tema di gerarchia tra gli atti della lex specialis e, conseguentemente, sulla possibilità per i chiarimenti di intervenire ad integrare le regole di gara.
Il TAR Lazio, con la sentenza 31.1.2018 n. 1139, ha ribadito alcuni interessanti principi operativi in tema di gerarchia tra gli atti della lex specialis e, conseguentemente, sulla possibilità per i chiarimenti di intervenire ad integrare le regole di gara.
In particolare, era accaduto che, a fronte di un contrasto tra il disciplinare e il capitolato (sul numero di beni da offrire in comodato in sede di offerta), la stazione appaltante aveva adottato un chiarimento, con il quale aveva "statuito" la validità dell'indicazione recata dal capitolato.
La gara, tuttavia, era stata aggiudicata ad un operatore la cui offerta era in linea con il disciplinare e non, quindi, con il capitolato, in violazione altresì di quanto manifestato dalla SA con il chiarimento.
A fronte del ricorso del secondo graduato, il TAR ha statuito che:
a) nella gerarchia tra gli atti della lex specialis, prevale comunque il disciplinare, di talché laddove il capitolato rechi previsioni contrastanti, queste non potranno trovare applicazione;
b) conseguentemente, i chiarimenti - che possono intervenire in caso di previsioni equivoche, ma non di contrasti in seno alla lex specialis - non potevano legittimamente essere utilizzati per dirimere l'antinomia tra disciplinare e capitolato, da risolvere, invece, sulla base del semplice criterio gerarchico di cui si è detto.
Cosicché, il ricorso è stato rigettato, dovendo ritenersi corretto l'operato della SA che (si noti: non attenendosi ad un proprio chiarimento) ha applicato la (prevalente) disposizione del disciplinare, disapplicando quella recata dal capitolato.
Sulla domanda di "sanatoria ex art. 37 TUED" (c.d. SCIA in sanatoria) occorre il provvedimento espresso del Comune?
 Continua ad essere discusso, nella prassi e nella giurisprudenza, il meccanismo sanante previsto dall'art. 37, co. 4, del Testo Unico dell'Edilizia, in base al quale "ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro (...)".
Continua ad essere discusso, nella prassi e nella giurisprudenza, il meccanismo sanante previsto dall'art. 37, co. 4, del Testo Unico dell'Edilizia, in base al quale "ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro (...)".
Sul punto si registrano ben tre interpretazioni giurisprudenziali:
a) esattamente come nel caso dell'art. 36 del TUEd,, dal silenzio dell'Amministrazione conseguirebbe il rigetto della domanda di sanatoria (con la recentissima sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 7.3.2018, n. 1457);
b) in assenza di una espressa previsione all'interno dell'art. 37, il silenzio dell'Amministrazione costituirebbe un inadempimento (con possibilità di agire dinnanzi alla giustizia amministrativa per ottenere la condanna della PA a provvedere), come ritenuto, ad esempio, da TAR Lazio, n, 709/2010;
c) trattandosi di SCIA, l'effetto abilitante (in sanatoria) si produrrebbe dal momento del deposito della segnalazione certificata (tesi sostenuta dal TAR Lazio nella sentenza n. 156/2018 e dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1534/2014).
Una possibile "via di uscita", tuttavia, sembra essere suggerita dal "Decreto SCIA 2" e, in particolare, dalla Tabella A, che, nella Sezione "edilizia", al p.to 41, oltre a contemplare espressamente la "SCIA in sanatoria" (espressione che, fino ad oggi, non aveva mai trovato ingresso nel lessico "ufficiale" del Testo Unico dell'Edilizia), prevede espressamente che il relativo "regime amministrativo" è quello - appunto - della SCIA. Il che dovrebbe lasciar intendere che l'effetto abilitante (sanante) si produce con il semplice deposito della segnalazione certificata, senza necessità di provvedimenti espressi del Comune.
L'indice normativo derivante dal Decreto SCIA 2, quindi, pare avvalorare la conclusione secondo cui "la SCIA in sanatoria presentata ex art. 37 del medesimo D.P.R. si presta a rendere operanti le correlate prescrizioni di cui agli artt. 19 e ss. della legge n. 241 del 1990 in materia di “silenzio assenso”, dovendo essere ragionevolmente riconosciuto a tale segnalazione “carattere e natura confessoria, diretta a provare la verità dei fatti attestati e a produrre, con l’inutile decorso del tempo per l’emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una diversa volontà delle parti”, ossia l’ “avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria” (TAR Lazio n. 156/2018), smentendo, invece, la recentissima decisione del TAR Campania, n. 1457/2018, ad avviso della quale "non può ravvisarsi nella fattispecie di sanatoria di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 un’ipotesi di silenzio significativo in termini di accoglimento, dal momento che il suddetto art. 37 non solo non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell’art. 36 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento".
La ristrutturazione tramite ricostruzione di edifici crollati: ancora limiti dalla giurisprudenza.
 I Giudici amministrativi proseguono nell'opera di "delimitazione" dei casi di "inammissibilità" degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva previsti dall'art. 3, co. 1, lett. d) DPR n. 380/2001.
I Giudici amministrativi proseguono nell'opera di "delimitazione" dei casi di "inammissibilità" degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva previsti dall'art. 3, co. 1, lett. d) DPR n. 380/2001.
Ci riferiamo, in particolare, alla fattispecie del "ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza".
Sul tema, oltre a posizioni più elastiche (come quella del Consiglio di Stato Sez. IV, 27.9.2017, n. 4516 secondo il quale “non risulta coerente con la tutela delle facultates agendi del proprietario e con le disposizioni in tema di ristrutturazione edilizia (…), il diniego di una istanza volta ad ottenere il permesso di costruire per ristrutturazione edilizia attesa la “impossibilità” di definire la preesistente consistenza del manufatto” laddove si sia in presenza di “riscontro dell’esistenza del fabbricato in catasto, di atti di compravendita del medesimo e di una pluralità di rilievi fotografici, che possono condurre, anche in via deduttiva, a stabilire la più volte citata consistenza (anche in misura inferiore, ma comprovabile, rispetto a quanto assunto dagli interessati, ovvero optando, in presenza di più risultati possibili, motivatamente per quello più restrittivo)”), continuano a registrarsi "resistenze" di vario genere.
E ciò - almeno - da due punti di vista:
a) il problema della "prova della precedente consistenza" (si veda ad esempio TAR Toscana, Sez. III, 21.3.2014, n. 567, dove si sottolinea che l’apparato probatorio allegato deve essere tale da offrire “certezza in punto di murature perimetrali e di strutture orizzontali di copertura, ai fini del calcolo del volume preesistente occupato dal fabbricato crollato”) ;
b) la questione del coordinamento con la disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della ristrutturazione-ricostruzione (su cui la posizione più "radicale" è stata espressa dal Consiglio Superiore dei LL.PP. secondo il quale "la ricostruzione di un edificio crollato o demolito non può che avvenire nel rispetto dei vincoli pianificatori vigenti”, sicché dovrà tenersi conto, tra l’altro, di “destinazioni d’uso incompatibili con la costruzione" (così il parere del 18.2.2016).
Ma non è su tali aspetti (sicuramente critici) che - in questa sede - ci soffermeremo, quanto, invece, su un profilo ulteriore e, a quanto ci consta, "inedito".
Cosa accade laddove il sedime sul quale "sorgeva" l'edificio da ripristinare (tramite ristrutturazione, per l'appunto) è, nelle more, stato oggetto di trasformazioni urbanistico-edilizie?
Una (discutibile) risposta proviene dalla sentenza TAR Campania, Napoli, 7.11.2017, n. 5234.
Secondo il TAR, in particolare, poiché il soggetto interessato alla ricostruzione, "nell’arco temporale intercorso tra la demolizione del fabbricato e la presentazione della domanda diretta ad ottenere il titolo edilizio [per la sua ricostruzione], ha ritenuto di sfruttare diversamente l’area, attuando un intervento di pavimentazione e recinzione, ed imprimendo alla stessa una destinazione a parcheggio (..)" ne conseguirebbe una "recisione" del " rapporto di continuità con la preesistenza", con conseguente impossibilità di configurare "un intervento di “ristrutturazione” in quanto, sia la presenza di una qualche traccia materiale della preesistenza sia la continuità (valutati congiuntamente o anche solo disgiuntamente) costituiscono il nucleo imprescindibile degli interventi di ricostruzione".
Insomma, secondo il TAR Campania, affinché il privato possa vantare un diritto a ri-edificare (tramite ristrutturazione edilizia) occorrerebbe un elemento ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge (la dimostrazione della "preesistente consistenza"); in particolare sarebbe necessario che le consistenze e le cubature fisicamente non più esistenti non siano, tuttavia, state "abbandonate".
Francamente, la tesi del TAR Campania ci sembra che provi troppo, finendo per introdurre un limite al diritto edificatorio che l'art. 3, co. 1, lett. d) del DPR 380/2001 non sembra affatto postulare né presupporre.
Tuttavia, non può negarsi che la norma in esame, a distanza di diversi anni dalla sua introduzione, necessiterebbe di numerosi "correttivi" e "approfondimenti" da parte del Legislatore.
Come accennato, vari sono, infatti, i profili problematici (urbanistici e non solo edilizi) che l'istituto in questione pone e la cui soluzione deve passare, ad avviso di chi scrive, da risposte "certe", quindi legislative.
Sul tema sia consentito rinviare sia ad un precedente contributo sia all'approfondimento pubblicato sul blog dell'Ing. Carlo Pagliai
Esiste il subappalto nei contratti di fornitura?
 Con la sentenza 20.2.2018, n. 1956, il TAR Lazio ha affrontato il tema del subappalto nell'ambito degli appalti di forniture.
Con la sentenza 20.2.2018, n. 1956, il TAR Lazio ha affrontato il tema del subappalto nell'ambito degli appalti di forniture.
La seconda graduata ha contestato all'aggiudicataria la circostanza che nel DGUE non era stata dichiarata l'intenzione di sub-affidare parte della fornitura (intenzione che, invece, emergeva dall'offerta tecnica dell'aggiudicataria).
Ciò, nella prospettiva della ditta ricorrente, avrebbe costituito una violazione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.
La censura, tuttavia, è stata respinta dal TAR, partendo da una attenta disamina delle differenze che intercorrono tra il contratto di subappalto e quello di subfornitura.
Al riguardo il TAR Lazio ha evidenziato che mentre il subappalto (sia in base all'art. 105 del Codice dei contratti, sia alla luce degli artt. 1676 ss. codice civile) costituisce un vero e proprio appalto sia pur derivato da quello stipulato tra aggiudicatario e Stazione Appaltante, per contro il contratto di sub-fornitura è l'accordo in base al quale il sub-contraente si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell’appaltatore un prodotto (e, quindi, rileva esclusivamente dal punto di vista privatistico dei rapporti commerciali fra le aziende).
Dunque, secondo la sentenza, risulta chiara "la differenza fra il contratto di subappalto -ontologicamente caratterizzato dal coinvolgimento dell'assetto imprenditoriale dell'impresa subappaltatrice nell'attività dell'impresa aggiudicataria dell'appalto- ed il contratto di subfornitura, il quale prevede l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo, sotto le direttive del fornitore che determinano la dipendenza tecnica del subfornitore quanto a progetto, specifiche e know how di realizzazione della subfornitura"
Da tali premesse, appare perfettamente logica la conclusione del TAR secondo cui "la dichiarazione di non voler ricorrere al subappalto, (...), non può ritenersi preclusiva anche della facoltà di avvalersi di aziende esterne per l’acquisizione di prodotti parte della fornitura, da consegnare poi alla P.A. per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto".
La condivisibile conclusione del TAR (ri) apre, tuttavia, un interrogativo: la categoria del subappalto è del tutto da escludere nell'ambito degli appalti di fornitura?
D'altra parte, muovendo dalla "nozione" di subappalto recata dall'art. 105 - secondo cui "l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto" - la risposta sembra essere affermativa, quantomeno ogni qual volta la prestazione (la "consegna" dei beni oggetto della fornitura) sia posta in essere dall'appaltatore , atteso che in tal caso il terzo non esegue alcuna prestazione in favore della Stazione Appaltante.
Ordine di demolizione e diniego accertamento di conformità: il decorso del termine per adempiere
 In materia di sanatoria edilizia (ex art. 36 Testo Unico Edilizia -. "TUED") uno degli aspetti da maneggiare con più attenzione è quello dell "pericoloso incrocio" tra decorso del termine per l'adempimento dell'ordine di demolizione (ex art. 31 TUED) e il decorso del termine (di 60 giorni ex art. 36 TUED) per il riscontro all'istanza di accertamento di conformità.
In materia di sanatoria edilizia (ex art. 36 Testo Unico Edilizia -. "TUED") uno degli aspetti da maneggiare con più attenzione è quello dell "pericoloso incrocio" tra decorso del termine per l'adempimento dell'ordine di demolizione (ex art. 31 TUED) e il decorso del termine (di 60 giorni ex art. 36 TUED) per il riscontro all'istanza di accertamento di conformità.
Il primo termine, come noto, è di 90 giorni, decorsi i quali si produce, tra l'altro, l'acquisizione di diritto del bene al patrimonio comunale; il secondo è, invece, di 60 giorni, scaduto il quale, se non intervenga un provvedimento espresso, l'istanza di sanatoria si intende "rifiutata".
Non sempre il privato destinatario dell'ordine di demolizione presenta l'istanza ex art. 36 TUED immediatamente dopo la notifica dell'ordine di demolizione.
Si pongono così i seguenti problemi "pratici":
- il termine di 90 giorni, scaduto il quale si verifica, ex lege, l'acquisizione dell'opera abusiva (non spontaneamente rimossa) al patrimonio comunale continua a decorrere o no successivamente alla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità?
- conseguentemente, una volta ricevuto il diniego (espresso o tacito) sulla domanda ex art. 36 TUED, "quanto tempo" ha il privato per adempiere all'ordine di demolizione, prima che si produca l'effetto acquisitivo?
Una interessante - e ragionevole - soluzione perviene dalla recente sentenza 16.1.2018, n. 362 del TAR Campania, Napoli, secondo cui "il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione dovrà decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato; costui, infatti, non può essere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere la verifica postuma di conformità urbanistica e, pertanto, ha diritto di fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso".
Dunque, secondo questa decisione il "timer" dell'acquisizione ex lege, dal momento della presentazione dell'istanza ex art. 36 TUED, si "azzera" completamente, ricominciando a decorrere l'intero termine per l'ottemperanza dal momento del provvedimento (espresso o tacito) di diniego di sanatoria.
Si tratta di una soluzione, peraltro, complementare e in linea con l'attuale arresto della giurisprudenza secondo la quale "l'efficacia dell’ordine di demolizione risulta sospesa nelle more della pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda ex art. 36 DPR n. 380/2001” (Cons. St. Sez. VI, 4.04.2017 n. 1565 e TAR Lazio, ord. 5.10.2017, n. 5162). Posizione, quella citata, che in vero poteva lasciare il dubbio che la presentazione della domanda di accertamento di conformità determinasse semplicemente una "sospensione" del decorso del termine in attesa della definizione della domanda di titolo postumo.
Ovviamente - è bene sottolinearlo - anche in ragione del fatto che si tratta di una sola pronuncia, prudenza vorrebbe che le domande di accertamento di conformità vengano presentate con "largo anticipo" rispetto alla consumazione dei 90 giorni previsti.