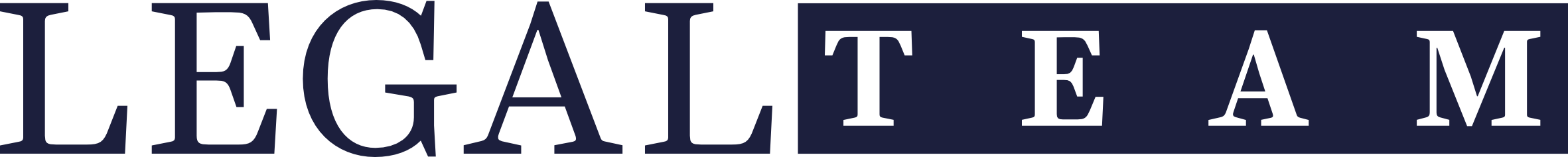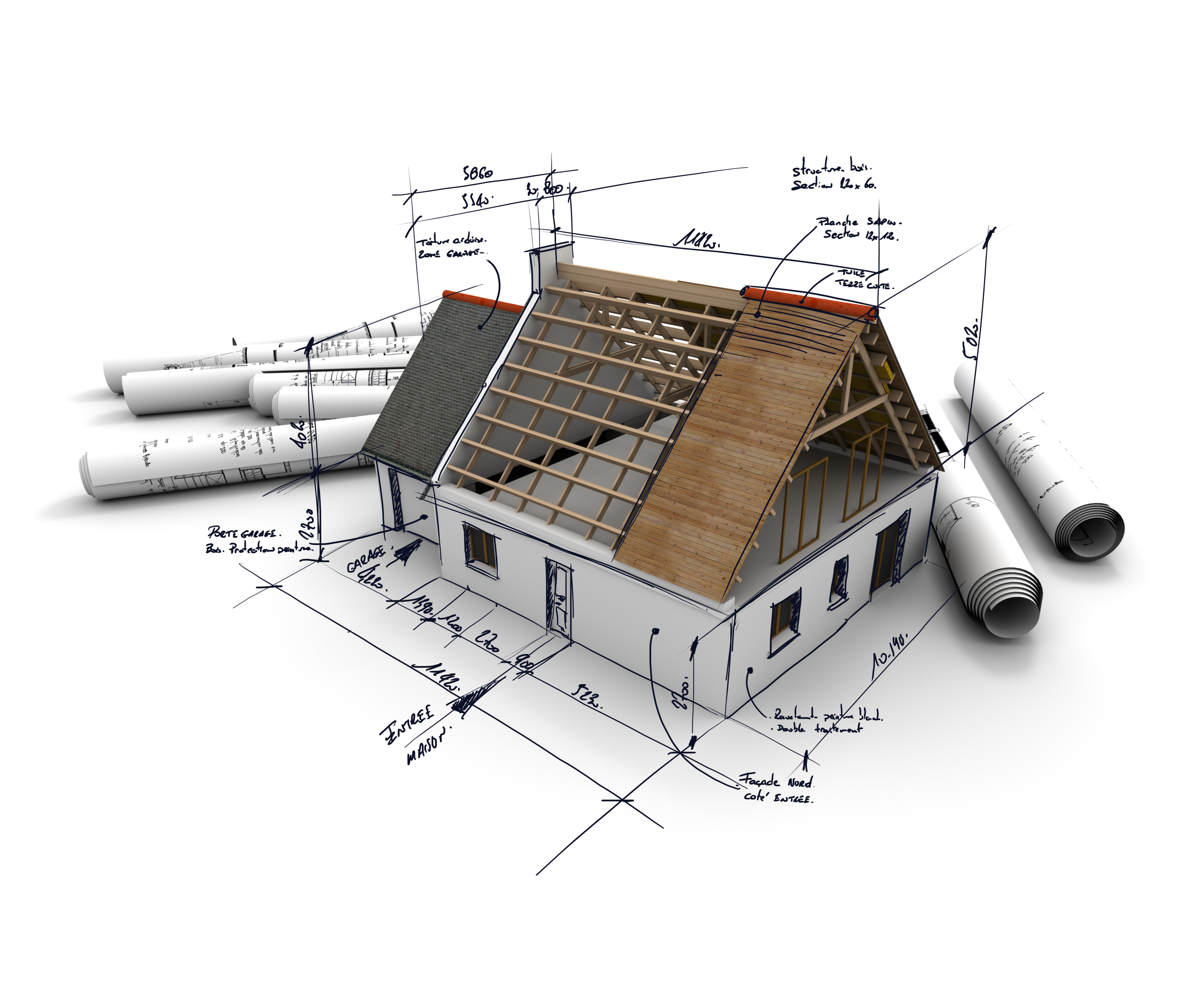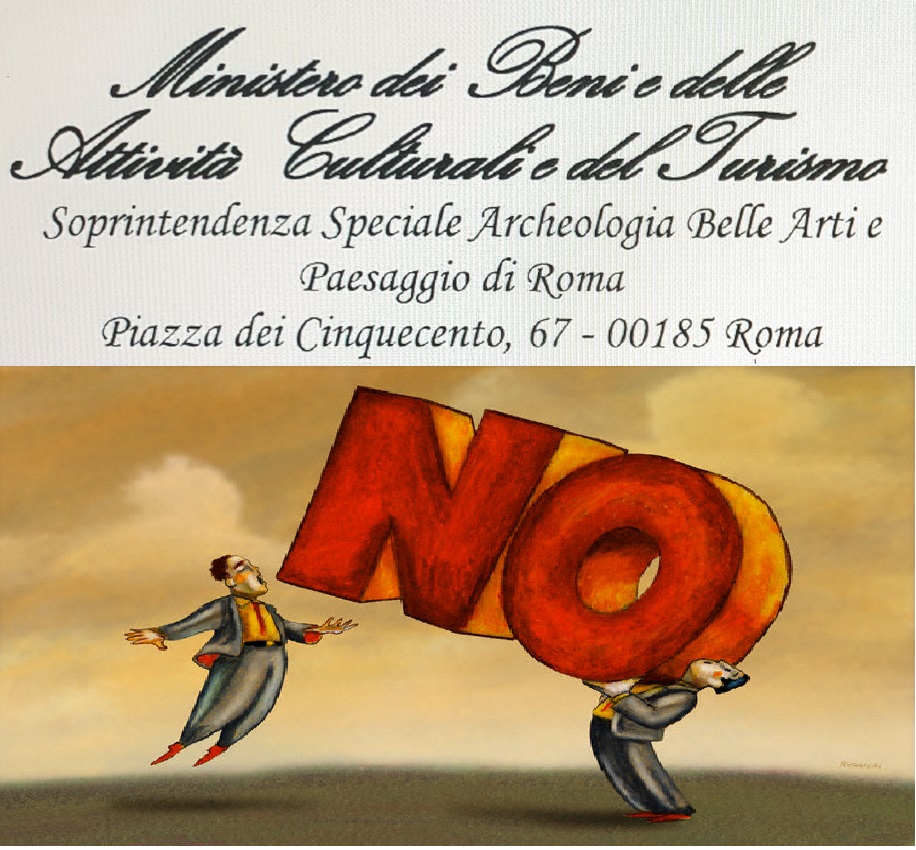Inibizione della SCIA: il termine ex art. 19 L. 241/90 è perentorio (e con il D.L. semplificazioni "di più"?)
 L'art. 19, co. 3 L. 241/90 prevede che, ricevuta una SCIA, la P.A. possa provvedere alla sua "inibizione" entro il termine di 60 giorni (o 30 in caso di SCIA edilizia in base al co. 6-bis).
L'art. 19, co. 3 L. 241/90 prevede che, ricevuta una SCIA, la P.A. possa provvedere alla sua "inibizione" entro il termine di 60 giorni (o 30 in caso di SCIA edilizia in base al co. 6-bis).
Sempre più la giurisprudenza si è orientata nel ritenere che tale termine sia perentorio e che, quindi, superato lo stesso residui solo la possibilità di intervenire in presenza dei requisiti per l'autotutela di cui all'art. 21-nonies L. 241/90.
Così, ad esempio, con la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. II-bis, 18.8.2020. n. 9248, il giudice amministrativo ha ritenuto violativo dell'art. 19, co. 6-bis il provvedimento con cui Roma Capitale, ricevuta una SCIA per un intervento di rigenerazione urbana ex L.R. 7/2017, ha inibito la stessa oltre il termine di 30 giorni.
In particolare, il TAR ha rilevato l'illegittimità del provvedimento di inibizione della SCIA adottato "dopo aver fatto scadere invano il termine di 30 giorni stabilito dalla legge per rilevare la carenza dei requisiti e dei presupposti per l’integrazione della fattispecie di cui alla SCIA presentata per il cambio di destinazione, abbia solo tardivamente ingiunto ai ricorrenti di non effettuare i lavori (peraltro già terminati), pretendendo di comunicare loro anche la mancanza di efficacia del titolo comunque formatosi e l’archiviazione dell’intera pratica, senza aver in alcun modo dato inizio ad un procedimento di “autotutela”, e senza alcun avviso, necessario, invece, nel caso de quo".
La regola, ormai pacifica in giurisprudenza, è peraltro stata anche "rinforzata" dal D.L. semplificazioni (in corso di conversione in questi giorni), laddove, è stato introdotto il nuovo co. 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, in base al quale:
(....) i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.";
A prima lettura - ed al netto di quanto potrà accadere in sede di conversione in legge del D.L. semplificazioni - la norma suscita l'interrogativo circa la automaticità, o meno, della sanzione di inefficacia: in particolare, si pone, in astratto, l'interrogativo se, ricevuta un provvedimento "tardivo" della PA, di inibizione di una SCIA, il privato possa considerare lo stesso come non produttivo di effetti e, ad esempio, contestare l'atto inibitorio tardivo anche oltre i 60 giorni (termine per ricorrere al TAR) in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento ripristinatorio adottato sulla base dell'atto "inefficace" stesso.
Ovviamente, nell'incertezza della norma e dei suoi effetti, l'approccio migliore è sempre quello prudenziale, che suggerisce una "normale" impugnativa del provvedimento inibitorio adottato oltre i termini ex art. 19, co. 3 e 6-bis L. 241/90, ciò con la consapevolezza (ed il vantaggio, per il privato) di una ancor più rafforzata tutela (costituita dalla espressa sanzione di "inefficacia") a fronte di atti inibitori tardivi.
D.L. semplificazioni e “stato legittimo dell'immobile": il nuovo art. 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. 380/01
 Chiunque operi nell’edilizia ha spesso a che fare con la verifica dello “stato legittimo dell'immobile” dell’immobile o dell’unità immobiliare. Tale verifica, infatti, si impone tanto in sede di presentazione di una pratica edilizia (dalla più semplice alla più complessa) tanto in fase di compravendita immobiliare (la legittimità dello stato attuale è, infatti, il quesito principale di ogni due diligence immobiliare).
Chiunque operi nell’edilizia ha spesso a che fare con la verifica dello “stato legittimo dell'immobile” dell’immobile o dell’unità immobiliare. Tale verifica, infatti, si impone tanto in sede di presentazione di una pratica edilizia (dalla più semplice alla più complessa) tanto in fase di compravendita immobiliare (la legittimità dello stato attuale è, infatti, il quesito principale di ogni due diligence immobiliare).
Fino ad oggi, tuttavia, tale nozione non era mai stata definita dal legislatore statale nel D.P.R. 380/01; solo con il D.L. semplificazioni è stato introdotto, all’art. 9-bis del D.P.R. 380/01 un comma 1-bis (articolato in tre periodi) in base al quale:
[1] Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. [2] Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. [3]Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
1. La regola generale dettata dal primo periodo
Come premesso, al livello statale è questa la prima definizione della nozione di stato legittimo (nozione, come ricordato, presupposta a qualunque intervento edilizio).
Il primo periodo introduce la “regola generale”, tale per cui lo stato legittimo va individuato avendo riguardo a:
- titolo che ha abilitato la costruzione o l’ultimo intervento (sull’immobile o sull’unità immobiliare)
- integrati da eventuali titoli successivi relativi ad interventi parziali
La Relazione illustrativa al D.L. evidenzia che:
La lettera d) reca modifiche all’articolo 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introducendo per la prima volta la definizione di stato legittimo, utilizzata tradizionalmente per la verifica della legittimità dell’immobile, oggetto di intervento edilizio o di alienazione. Essa dunque risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi.
2. Il secondo ed il terzo periodo: regole per le situazioni “dubbie”e "risalenti"
Il secondo periodo individua le “regole” atte ad individuare lo stato legittimo per “gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio”.
La norma sfiora, ma non affronta, un tema assai delicato, che non ha una soluzione a priori e valevole “ovunque”. Non è infatti possibile accontentarsi, come una certa sommaria vulgata vorrebbe, del c.d. ante 67.
Nel nostro Paese, infatti, la pianificazione del territorio intesa come regolamentazione atta a disciplinare l’edificazione preesiste senz’altro non solo alla L. 765/1967 ma anche alla stessa Legge 17/08/1942, n. 1150 (c.d. “legge urbanistica fondamentale).
La giurisprudenza amministrativa aveva inizialmente ritenuto che, per quanto riguarda gli interventi edilizi compiuti tra il 1942 (entrata in vigore della L. 1150/1942), ed il 1967 (entrata in vigore della L. 765/1967), fosse da escludere radicalmente la stessa possibilità di contestare l’assenza di titolo edilizio per opere realizzate all’in fuori del “centro abitato”, pur laddove questo fosse prescritto dalla disciplina urbanistica comunale vigente al tempo dell’intervento.
Così, TAR Toscana 899/2014 e TAR Catania 48/2019 ritengono ad esempio che per l'accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati fuori dei centri abitati ante 67, rileva esclusivamente la norma primaria sopravvenuta di cui all'art. 31 L. 1150/ 1942 (con obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati) con prevalenza rispetto alla disciplina regolamentare preesistente.
Invece, secondo un diverso prevalente orientamento (ad es. TAR Lazio, 1877/2018 e TAR Campania, Napoli 3669/2017), non può riconoscersi una automatica ed implicita portata abrogante o disapplicativa della norma secondaria (i regolamenti e gli strumenti urbanistici ante 1942) all’art. 31 della L. 1150/1942, giacché tale norma si è limitata a disciplinare in via generale tale obbligo senza, tuttavia, che ciò abbia determinato l’abrogazione tacita di una disposizione speciale più rigorosa per le costruzioni al di fuori dei centri abitati negli esistenti atti di governo del territorio.
Ad ogni modo, date tali coordinate, il tema centrale resta (anche nell’applicazione della nuova norma) quello della prova.
Al riguardo, è possibile evidenziare che per la giurisprudenza, chi intende avvalersi della esenzione dall’obbligo del titolo (perché ante ’67 o anteriorità ad altra deadline) occorre fornire prova sufficiente della realizzazione del fabbricato/intervento: è onere del privato fornire la prova della datazione dell’opera, ove intenda affermarne la natura di ante ’67; tuttavia, una volta che tale onere sia stato assolto in maniera diligente, incombe sull’amministrazione che voglia disconoscere tale “datazione” uno sforzo contro-probatorio concreto
Svolte queste premesse generali, riprendiamo l’esame della nuova disposizione la quale individua lo stato legittimo come
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza
L’espressione adoperata “desumibile” lascia intendere – sembrerebbe - che in tali casi la individuazione dello stato legittimo, pur nel rigore necessario, potrebbe non richiedere lo stesso livello di “oggettività” e certezza che si ha in presenza di un incontrovertibile titolo edilizio.
[In tal senso, al livello lessicale, si osserva che il significato letterale di desumere è (Treccani) “1. Trarre, ricavare: d. esempî dai migliori scrittori; notizie desunte dai giornali. 2. Arguire, congetturare: da che cosa desumi che sia colpevole?; dai suoi discorsi si desume che non è del nostro parere; dal suo sguardo desumo di non essergli simpatico”]
Proseguendo nella disamina dei “mezzi per desumere lo stato legittimo”, si può osservare che la documentazione indicata dalla norma non è tassativa, benché vi sia una “gerarchia”.
Infatti, il primo dato da considerare (e “cercare”) sono le “informazioni catastali di primo impianto”.
Solo in alternativa (o “a completamento”, in una prospettiva più elastica) è possibile ricorrere agli “altri documenti probanti” che vengono indicati dalla disposizione in maniera esemplificativa, non tassativa e senza preferenze a priori. Ci si riferisce, così, a “riprese fotografiche”, “estratti cartografici”, “documenti d’archivio” , o “altro atto, pubblico o privato”. È appena il caso di osservare che, data la clausola particolarmente aperta, fra tali documenti non possiamo escludere la rilevanza di informazioni catastali “non di primo impianto” nonché la stessa documentazione attenente all’agibilità (nonostante che, come noto, la giurisprudenza sia stata sino ad oggi assai negativa nel dare valore a tale documento).
Essenziale, ad ogni modo, è che della documentazione invocata sia “dimostrata la provenienza”.
L’ultimo periodo della norma, infine, introduce la possibilità di ricorrere ai mezzi di prova “alternativi” laddove vi sia prova dell’esistenza del titolo ma non vi sia copia dello stesso (o, possiamo immaginare, difetti di taluni elementi atti a indicare esattamente lo stato legittimo, ad esempio elaborati, prospetti, sezioni, etc.).
3. Alcuni rilievi generali.
La norma ovviamente (una volta convertita in legge) dovrà essere precisamente recepita dalla modulistica, al fine di consentire al tecnico di precisare a quale delle tre ipotesi richiamarsi in sede di asseverazione dello stato legittimo.
La disposizione, inoltre, potrebbe porre un problema di coordinamento, in materia di repressione degli abusi edilizi, con i principi rigidi di Cons. Stato Ad. Plen. 9/2017 (dove, come è noto, sono stati affermati i principi di a) irrilevanza della risalenza nel tempo abuso; b) insussistenza del legittimo affidamento in presenza di irregolarità edilizio-urbanistiche c) sussistenza di interesse pubblico in re ipsa alla repressione dell’abuso edilizio).
Va segnalato come alcune decisioni successive ad Ad. Plen. abbiano iniziato ad aprire un varco, di cui il co. 1-bis rappresenta un possibile “punto di appoggio”.
Ci si riferisce, ad esempio, a Cons. Stato 3372/2018, TAR Sardegna 366/2018;TAR Reggio Calabria 513/2019; TAR Lazio 5690/2019, laddove si afferma la possibile tutelabilità del legittimo affidamento in presenza di precedenti pratiche edilizie che, pur “ricomprensive” della situazione “irregolare”, siano tuttavia state “validate” dalla P.A. [ne parliamo nel dettaglio in questo video].
Significativo in tale contesto segnalare una scelta “in negativo” del Governo.
Nella “prima Bozza” del D.L. semplificazioni era presente una norma che da tempo circola nella legislazione regionale, a partire da L.R. Emilia Romagna 23/2004 (come introdotto dalle L.R. 37 e 73 del 2017; presente anche in L.R Marche 25/2017) che c pone al suo centro proprio il legittimo affidamento nonché la mancata contestazione, nel tempo, di una data consistenza come non legittima.
Si era infatti ipotizzata una disposizione così formulata:
nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie le parziali difformità realizzate durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l’agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato senza contestarle come abusive ed assumendo il provvedimento conclusivo del procedimento favorevole all’interessato. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e alle condizioni ivi previste
Come detto, nel D.L. semplificazioni approvato e pubblicato tale forma di “tolleranza”, ispirata al legittimo affidamento non è stata accolta dal Governo. Non possiamo, però, escludere che l’interpretazione dell’art. 9-bis, co. 1-bis possa, sia pur parzialmente e in maniera più “eccezionale”, condurre ad approdi analoghi.
Rigenerazione urbana a Roma: articolo 6 L.R. Lazio 7/2017 e Carta per la qualità.
 Un recente parere della Regione Lazio affronta il tema dei rapporti tra articolo 6 L.R. Lazio 7/2017 (sulla rigenerazione urbana) e Carta per la qualità, in particolare avuto riguardo alla necessità, ex art. 16, co. 10, NTA PRG, di acquisire il parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina.
Un recente parere della Regione Lazio affronta il tema dei rapporti tra articolo 6 L.R. Lazio 7/2017 (sulla rigenerazione urbana) e Carta per la qualità, in particolare avuto riguardo alla necessità, ex art. 16, co. 10, NTA PRG, di acquisire il parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina.
In particolare, la norma di Piano in questione prevede che:
"Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati".
Il Dipartimento PAU di Roma Capitale, nel dettaglio, ha chiesto alla Regione se, ai fini dei cambi d'uso ammessi dal co. 2 dell'art. 6 della L.R. 7/2017, sia possibile prescindere (ai fini della formazione del silenzio assenso sulla domanda di PdC) dal parere della Sovrintendenza ex art. 16, co. 10, NTA PRG. La soluzione al quesito, peraltro, ha importanti ricadute, indirette, anche su un altro potenziale e più radicale dubbio: occorre o no il parere sovrintendentizio in questione per i cambi d'uso ex art. 6, co. 2, L.R. 7/2017?
La Regione, a partire dal rilievo che la disposizione in esame consente il cambio d'uso "indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste" dal PRG individua come questione preliminare da dirimere la possibilità di qualificare il parere della Sovrintendenza come "modalità di attuazione" ovvero come "prescrizione".
Condivisibilmente, il parere esclude che il parere integri una modalità di attuazione (riferendosi la norma, infatti, alla necessità, o meno, di uno strumento attuativo).
La Regione, quindi, passa a valutare se la previsione ex art. 16, co. 10, NTA possa essere considerata come una delle altre "prescrizioni previste" dal PRG.
Il parere, sul punto, rileva innanzi tutto che per "prescrizione" si dovrebbe intendere un "limite e/o contingente concreto alla realizzazione di un intervento, ossia una previsione che incide, in senso limitativo, sull'attuazione dell'intervento".
Ebbene, secondo la Regione "la necessità di un parere endoprocedimentale (...) non può considerarsi alla stregua di una prescrizione in quanto tale", potendo lo stesso essere considerato come "un requisito, un adempimento" e non già un "limite diretto e immediato alla realizzabilità di un certo intervento".
Da ciò la conclusione cui perviene la Regione: il parere ex art. 16 NTA oltre a non costituire una modalità attuativa non rappresenta nemmeno una prescrizione ex art. 6 co. 2 L.R. 7/2017.
Sicché il parere stesso deve essere "comunque richiesto anche per gli interventi realizzati in forza della normativa sulla rigenerazione urbana" ex art. 6, co. 2, L.R. citata.
Tale conclusione della Regione non convince.
Infatti, la circostanza che il parere della Sovrintendenza ex art. 16, co. 10, NTA sia da considerare come una vera e propria prescrizione sembra discendere dalla stessa norma di PRG laddove ivi si dispone che l'intervento è "subordinato al parere favorevole".
Ora, in disparte gli effetti della mancata espressione del parere nel termine previsto dal PRG (secondo TAR Lazio n. 710/2018 al decorso dei 60 gg. consegue che lo stesso è da intendersi favorevolmente reso ex artt. 19 e ss. L. n. 241/90), il passaggio che appare non condivisibile rispetto all'atto di indirizzo regionale è il non considerare il meccanismo endoprocedimentale in questione come una "prescrizione" (con obbligo, quindi, di acquisire il parere in parola).
Ed infatti, considerato che per poter realizzare l'intervento occorre il parere favorevole della Sovrintendenza (espresso o silente, poco cambia nella sostanza), nel caso in cui questo sia negativo, si determina inevitabilmente una limitazione all'attuazione dell'intervento.
Inoltre, a monte, l'acquisizione del parere in questione è sicuramente "prescritta" dal PRG e. non a caso, infatti, sempre TAR Lazio n. 710/2018, nell'esaminare l'art. 16, co. 10, NTA PRG parla espressamente di "prescrizione".
D'altra parte, posto che la giurisprudenza amministrativa riconosce alla Carta per la qualità la natura di vero e proprio vincolo urbanistico (TAR Lazio n. 2744/2014), appare a maggior ragione discutibile disconoscere che il "meccanismo procedimentale" collegato a detto vincolo non abbia carattere di "prescrizione".
La conclusione della Regione, inoltre, appare non condivisibile anche in un'ottica di interpretazione complessiva dell'art. 6 co. 2 L.R. 7/2017, la cui ratio sembra essere quella di consentire, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e demoricostruzione, tutti i cambi d'uso ammessi "in astratto" dal PRG (oltre che i cambi d'uso urbanisticamente non rilevanti ex art. 23-ter D.P.R. 380/2001), a prescindere dalle regole in via ordinaria previste per i mutamenti d'uso stessi.
D'altra parte, allargando il campo al comma 1 dell'art. 6 L.R. 7/2017, dove si abilitano (sempre e, quindi, in deroga al PRG) le ristrutturazioni edilizie e le demoricostruzioni con ampliamento fino al 20%, risulterebbe singolare, invece, la necessità del parere ex art. 16, co. 10, NTA PRG (da intendersi derogato in base al comma 1) limitatamente al mero cambio d'uso (e magari relativamente ad un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia "pesante" se non addirittura di demoricostruzione).
DL semplificazioni, modifiche agli artt. 2-bis e 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001: ri-partenza per Piano Casa e Rigenerazione urbana?
 Il DL semplificazioni torna sull'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, a distanza di poco più di un anno dallo "sblocca-cantieri" 2019. E lo fa con una norma che, almeno in apparenza, pare offrire una "ri-partenza" per Piano Casa e Rigenerazione Urbana.
Il DL semplificazioni torna sull'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, a distanza di poco più di un anno dallo "sblocca-cantieri" 2019. E lo fa con una norma che, almeno in apparenza, pare offrire una "ri-partenza" per Piano Casa e Rigenerazione Urbana.
Sembra, dunque, superarsi l'empasse potenzialmente derivante dalla lettura (restrittiva) offerta da Corte Costituzionale 70/2020 (di cui abbiamo parlato qui).
Vediamo, in particolare, la "sovrapposizione" (in grassetto il nuovo testo, barrato il testo "abrogato") tra le due versioni del co. 1-ter dell'art. 2-bis D.P.R. 380/2001:
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, quest’ultima la ricostruzione, è comunque consentita nel rispetto nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. (...)
Siamo al cospetto di diverse novità.
In primo luogo, nel consentire la demo-ricostruzione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, il legislatore precisa ora che tale opzione non è legata al mantenimento dell'area di sedime e del volume preesistente né, tantomeno, all'altezza massima del fabbricato demolito
In secondo luogo e conseguentemente, si precisa anche che tale norma di favore è applicabile anche per "ampliamenti fuori sagoma" finalizzati a sfruttare eventuali "incentivi volumetrici".
Incentivi che potranno essere realizzati anche in soprelevazione con il solo limite delle "distanze legittimamente preesistenti". Peraltro, pare significativa la circostanza che il legislatore parli di "incentivi" volumetrici e non già di semplici "aumenti di cubatura": si deve trattare, a stretto rigore, di premialità vere e proprie (e non, ad esempio, di eventuali residui di cubatura ammessi dal PRG).
La sostituzione edilizia - in alcune leggi regionali e dalla giurisprudenza amministrativa - ricondotta sostanzialmente alla nuova edificazione (così come, ai fini delle distanze, la mera soprelevazione) viene quindi incardinata, parrebbe, nella ristrutturazione edilizia.
Di ciò, peraltro, si trova coerente traccia anche nel nuovo art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001:
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (...)
Qui, infatti, il DL semplificazioni non solo ammette espressamente la modificabilità, in sede di ristrutturazione, delle caratteristiche planivolumetriche (il che costituisce un quid pluris rispetto alla sagoma, evidentemente), ma si apre anche - nei casi ammessi da legge o pianificazione - agli incrementi volumetrici (senza un limite fissato ex ante).
Siamo al cospetto di innovazioni sicuramente significative che segnano una nuova evoluzione del concetto di ristrutturazione edilizia (come detto, ricomprensiva anche della categoria, ancora innominata dal legislatore statale, della sostituzione edilizia).
Specularmente a quanto notato con riferimento all'art. 2-bis, co. 1-ter, si osserva come qui la novella legislativa parli di "incrementi di volumetria", riconosciuti da legge o pianificazione, "anche [quindi: non solo] per promuovere interventi di rigenerazione urbana". Dunque, in tal caso non occorre che si sia al cospetto di "incentivi" in senso stretto.
A far da contraltare a tali significative estensioni, troviamo, tuttavia, taluni "paletti maggiori" (sia nell'art. 2-bis co. 1-ter, sia nell'art. 3, co. 1, lett. d) per gli interventi da eseguirsi nelle zone A nonché in presenza di vincoli.
Ci si riferisce, in particolare, al nuovo ultimo periodo del co. 1-ter art. 2-bis:
Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
e al nuovo ultimo periodo dell'art. 3, co. 1, lett. d)
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A , gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria
Una prima notazione, che deriva dal raffronto tra le due disposizioni, appare necessaria: l'art. 2-bis, co. 1-ter ult. periodo, autonomamente letto, sembra voler prescrivere un divieto generale (relativo: "fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti") di demoricostruzioni nelle zone A, se non disciplinato da strumenti attuativi. La norma sembra essere un refuso o una non lineare costruzione della frase (non concordano "gli interventi di demolizione e ricostruzione" con "sono consentite", la presenza della virgola rende più che dubbio cosa sia consentito).
Inoltre, che la previsione sia da intendere come un "divieto generalizzato" di DR appare in contrasto con altri due indici interpretativi.
Il primo è che l'oggetto della norma (art. 2-bis) e della disposizione specifica (co. 1-ter) non è l'ammissibilità, o meno, degli interventi demoricostruzione, quanto, invece, il regime delle distanze in tali interventi.
Il secondo è che l'ultimo periodo del nuovo art. 3, co. 1, lett. d), non vieta le ristrutturazioni tramite demoricostruzione nelle zone A, semplicemente prevedendo che le stesse sono vincolate al mantenimento di "sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente" nonché all'assenza di "incrementi di volumetria".
Dunque, potrebbe ritenersi che nelle zone A, in caso di demolizione e ricostruzione il mantenimento delle preesistenti distanze legittimamente esistenti sia possibile solo ove detti interventi siano contemplati dalla pianificazione urbanistica (attuativa o generale).
Resta comunque problematico il coordinamento con il nuovo ultimo periodo dell'art. 3, co. 1, lett. d), il quale, laddove ammette come ristrutturazione edilizia la demoricostruzione "fedelissima" (identità di sagoma, prospetti, sedime, planivolumetria, caratteristiche tipologiche) in zona A (nonché in presenzadi vincoli), dovrebbe comunque esser letto nel senso di abilitare il mantenimento delle preesistenti distanze legittime (proprio perché, appunto, di ristrutturazione si tratta).
Forse, un coordinamento potrebbe immaginarsi nel senso di ritenere che, in zona A, un intervento di demoricostruzione "non fedelissimo", quindi non costituente ristrutturazione in base alla norma generale dell'art. 3, co. 1, lett. d), possa mantenere le distanze legittimamente preesistenti solo se a ciò abilitato dalla strumentazione urbanistica. Tale interpretazione, infatti, pare "tenere insieme" i due disposti esaminati.
Pare quindi verosimile (ed auspicabile) che in sede di conversione in legge vengano meglio chiariti i rapporti tra le due disposizioni.
Inibizione della SCIA oltre il termine di 18 mesi: serve un "falso" e non basta un "errore"
 Come sappiamo, l'inibizione della SCIA oltre il termine di 18 mesi (così come l'annullamento del PdC) richiede un presupposto preciso: serve, infatti, un "falso" (o, più precisamente, la "falsa rappresentazione dei fatti").
Come sappiamo, l'inibizione della SCIA oltre il termine di 18 mesi (così come l'annullamento del PdC) richiede un presupposto preciso: serve, infatti, un "falso" (o, più precisamente, la "falsa rappresentazione dei fatti").
Così, infatti, dispone l'art. 21 nonies L. n. 241/90:
"i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445."
In passato ci siamo occupati di verificare in quali casi, secondo la giurisprudenza, occorra, per superare il termine di 18 mesi, una sentenza passata in giudicato.
Oggi, invece, viene all'attenzione - grazie allo spunto offerto da TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 1.6.2020, n. 980 - un aspetto ancora più "fondamentale".
In particolare, la domanda (solo apparentemente "banale") è: cosa intende la norma laddove si riferisce a "false rappresentazioni dei fatti"?
Come ben noto ai tecnici e agli operatori del settore edilizio, infatti, una SCIA (così, come peraltro, un PdC, per il quale valgono i medesimi principi ai fini della legittimità dell'annullamento) è accompagnata da varie dichiarazioni ed asseverazioni.
Alcune di queste sicuramente hanno ad oggetto fatti "materiali", per i quali è sempre applicabile un criterio "vero/falso" (ad es. "il fabbricato non è soggetto a vincoli ex d.lgs. n. 42/2004" o "la distanza dalla parete finestrata antistante è di XX metri"). Si tratta, in altri termini, di aspetti "oggettivamente" verificabili e riscontrabili, la cui non veritiera attestazione nella SCIA (o nella richiesta di PdC).
In questi casi, infatti, sarà sufficiente, al fine di poter giustificare l'intervento "oltre i 18 mesi", accertare la presenza di un dato (oggetivo) non rispondente al vero (ossia, falso).
Laddove, invece, si ricada in ipotesi di "errori" ricadenti su aspetti "non oggettivi" è più problematico parlare di "falsità". In presenza, ad esempio, di valutazioni circa la conformità a talune (spesso non chiarissime, come noto ...) norme pianificatorie o regolamentari, talvolta, se è possibile che le stesse risultino "errate", non è detto che si possa - automaticamente - qualificarle come "false". Falsità che, peraltro, secondo parte della giurisprudenza andrebbe in qualche misura agganciata anche ad un elemento psicologico, quale il dolo o la colpa grave.
In questa logica è assai interessante la sentenza del TAR Lombardia n. 980/2020.
In questo caso, a fronte dell' "annullamento" di una SCIA oltre i 18 mesi, il TAR ha escluso l'invocabilità del co. 2-bis art. 21-nonies L. n. 241/90 in una fattispecie in cui la "non conformità" dell'intervento alla disciplina edilizia di riferimento discendeva non da un profilo oggettivo ma da una interpretazione (in ipotesi: inesatta) delle norme applicabili.
Ecco che, a tal proposito, il TAR osserva che:
"non vi è stata alcuna falsa rappresentazione in senso proprio, correlata al dolo o alla colpa grave della parte istante (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 849; V, 27 giugno 2018, n. 3940; T.A.R. Campania, Salerno, II, 13 maggio 2020, n. 494; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 25 marzo 2020, n. 398; T.A.R. Campania, Napoli, II, 11 febbraio 2020, n. 672). D’altra parte, seppure si fosse in presenza di un errore interpretativo compiuto dalla parte in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile alla fattispecie, lo stesso non darebbe luogo ad alcuna falsa rappresentazione tale da giustificare l’attivazione da parte del Comune dei poteri di autotutela oltre il termine di cui all’art. 21 nonies (cfr. Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2016, n. 3762)."
Peraltro, è anche il caso di osservare, al fine di delimitare la portata del principio enucleato dalla sentenza del TAR Lombardia, come occorra, al fine di valutare la sua applicabilità, svolgere una valutazione caso per caso, giacché non tutte le norme urbanistico-edilizie sono suscettibili (in buona fede e con la diligenza professionale richiesta ai tecnici che asseverano le istanze) di interpretazioni "opinabili" (si pensi, ad esempio, ad una norma che chiaramente, per una data area del territorio, vieti talune destinazioni ovvero prescriva determinati limiti di altezza/distanza).
Interventi su edifici vincolati: un occhio al DPR 380/01 e uno al D.lgs. 42/2004.
 Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3150 del 18.5.2020) ricorda in maniera molto chiara un dato fondamentale che, a causa della stratificazione delle discipline giuridiche applicabili agli interventi edilizi, rischia di passare in secondo piano.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3150 del 18.5.2020) ricorda in maniera molto chiara un dato fondamentale che, a causa della stratificazione delle discipline giuridiche applicabili agli interventi edilizi, rischia di passare in secondo piano.
Laddove si intervenga su edifici vincolati quali beni culturali (parte II del d.lgs. n. 42/2004) non è possibile leggere il relativo regime abilitativo solo dal punto di vista edilizio-urbanistico e, quindi, secondo le categorie di intervento di cui al DPR 380/01.
Occorre, invece, che "ciascun costrutto normativo deve essere osservato con la “lente” del suo specifico contesto disciplinare, con la conseguenza che le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo culturale e paesaggistico".
Ed è sulla base di tale principio - saldo nella giurisprudenza (e ben noto in materia paesaggistica, ad esempio) - che il Consiglio di Stato nella particolare vicenda decisa con la sentenza 3150/2020 ha quindi rigettato la tesi della parte ricorrente secondo la quale "se la Soprintendenza si fosse correttamente attenuta alla qualificazione edilizia dell’intervento operata dal Comune, allora anche il giudizio di compatibilità con il vincolo sarebbe stato necessariamente diverso" .
Tale circostanza, in particolare, appare particolarmente significativa laddove si consideri che mentre la disciplina edilizia (D.P.R 380/01) reca una free zone, dal punto di vista abilitativo (gli interventi minori di edilizia libera, di cui al relativo Glossario ministeriale), al contrario il d.lgs. 42/2004, quanto ai beni culturali prescrive la necessità di autorizzazione soprintendentizia (ossia un titolo espresso) per l'esecuzione di "opere e lavori di qualunque genere" (art. 21, co. 4).
Ciò implica, in sostanza, che un dato intervento che al livello edilizio può risultare irrilevante e liberalizzato, debba nondimeno passare per un procedimento abilitativo espresso da parte della Soprintendenza MiBAC senza che nessun rilievo possa assumere il profilo strettamente "edilizio" (o che, come nel caso deciso dal Consiglio di Stato, la qualificazione urbanistico-edilizia, possa vincolare le valutazioni soprintendentizie).
Tale "autonomia" e prevalenza dei profili vincolistici (anche quelli paesaggistici, ovviamente) trova un riflesso anche nel D.P.R. 380/2001 il quale, anche quando si riferisce all'edilizia "libera" (art. 6 D.P.R. 380/2001) chiarisce espressamente che gli interventi ricadenti in tale categoria possono essere realizzati senza titolo fermo restando, comunque, il "rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, (...) delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
PTPR del Lazio, area "UNESCO" di Roma ed art. 146 del Codice dei beni culturali
 La recente sentenza TAR Lazio, Sez. II-quater, 29.5.2020, n. 5757 affronta un tema assai dibattuto del Piano territoriale paesaggistico regionale del Lazio, ossia la disciplina di tutela ed autorizzazione dell'area "UNESCO" di Roma.
La recente sentenza TAR Lazio, Sez. II-quater, 29.5.2020, n. 5757 affronta un tema assai dibattuto del Piano territoriale paesaggistico regionale del Lazio, ossia la disciplina di tutela ed autorizzazione dell'area "UNESCO" di Roma.
1. L'area UNESCO di Roma nell'art. 45, co. 13, NTA PTPR adottato e nell'art. 44, co. 19 del PTPR approvato.
All'interno del centro storico di Roma (ciò che il PRG denomina, più precisamente, "Città Storica") vi è un perimetro protetto quale "area UNESCO".
Tale area urbana, invece, risulta non coperta da specifico vincolo paesaggistico d'insieme (ossia che ricomprenda la "zona UNESCO", ossia la porzione della Città Storica ricompresa nelle "mura aureliane"), salvo, ovviamente, taluni beni/vincoli paesaggistici individuati ex art. 134 d.lgs. n. 42/2004.
Il PTPR adottato all'art. 45, co. 13 (disciplinante gli “insediamenti urbani storici e territori contermini”) prevedeva che:
“le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lett. a)del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella liste del Patrimonio UNESCO (Roma – centro storico …) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione (….)”.
La Regione Lazio, muovendo da tale disposizione, interpellata in merito alla necessità di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, aveva chiarito che nel centro di Roma, zona UNESCO (in assenza di altri beni/vincoli paesaggistici individuati ex art. 134 d.lgs. n. 42/2004) “non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica” (così il parere di cui alla nota prot. 94875 del 19.6.2009, Dipartimento Territorio).
Dunque, nella versione adottata (in parte differente da quella approvata, come vedremo a breve) la disciplina dell'area UNESCO era rimessa all'adottando "Piano di gestione".
Tale strumento, a norma dell'art. 3 legge 77/2006 ("Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO"), definisce "le priorita' di intervento e le relative modalita' attuative, nonche' le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalita' complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette". Si tratta, a ben vedere, di un contenuto non del tutto in linea con i contenuti pianificatori e di tutela tipici dei piani paesaggistici.
In sede di approvazione, avvenuta con la DGR n. 5 del 2.8.2019, pubblicata nel BURL del 13.2.2020, la disposizione è recata nell'art. 44 ("Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto") e, in particolare, al co. 19:
"Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco - centro storico di Roma. All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009)"
E', cioè, avvvenuto che in sede di approvazione del PTPR la Regione ha recepito (o "elevato"?) la disciplina (urbanistica) del PRG nonché il Protocollo d'intesa MiBAC - Roma Capitale a disciplina "paesaggistica" per l'area UNESCO , superando così il rinvio al "piano di gestione".
Infatti, ai sensi dell'art. 24, co. 19, NTA PRG:
"Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane- dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le competenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25,comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per ibeni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma,organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi daabilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21"
Si tratta, tuttavia, di una diversa (anche se all'atto pratico, non meno pervasiva, al netto della problematica questione del silenzio-assenso prevista in caso di manc) forma di controllo rispetto a quella ordinariamente prevista in presenza di vincoli paesaggistici, ipotesi nelle quali, a mente dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 occorre l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica "vera e propria".
2. La sentenza del TAR Lazio Sez. II-quater, 29.5.2020, n. 5757
E' in tale contesto - in particolare nella vigenza del PTPR nella versione solo adottata - che è intervenuta la sentenza del TAR.
Nella peculiare fattispecie decisa dal TAR, limitatamente alla questione qui in esame, era accaduto (in estrema sintesi) che un operatore economico aveva sottoposto un progetto relativo ad una trasformazione edilizia in area UNESCO e, in ossequio alla disciplina di PTPR e all'art. 24 NTA PRG, la Soprintendenza aveva rilasciato il proprio parere favorevole.
Successivamente, tuttavia, la Direzione generale del MiBAC è intervenuta in autotutela rilevando, tra l'altro, che l'intervento avrebbe necessitato dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004.
A fronte di ciò, il privato, nell'impugnare il provvedimento ministeriale, ha evidenziato come, in base all'art. 45, co. 13, NTA PTPR la necessità dell'autorizzazione paesaggistica era espressamente esclusa, come anche evidenziato dal parere della Regione Lazio del 2009, essendo per contro sufficiente lo speciale iter autorizzatorio previsto dal PRG.
Il TAR, pur non negando la portata del disposto dell'art. 45 NTA PTPR, ha tuttavia ritenuto:
"inammissibile che la Regione, che dovrebbe con il proprio PTPR prevedere un elevato grado di tutela di tali beni, ritenuti di interesse “assolutamente eccezionale” dal Ministero che ne ha promosso l’inserimento nella lista UNESCO (e riconosciuti come tali dal Comitato Intergovernativo con la dichiarazione di “patrimonio dell’Umanità”), possa con una previsione come quella dell’art. 43 co. 15 lasciarli del tutto privi di protezione – in contrasto con gli impegni assunti dallo Stato Italiano in base alla Convenzione Unesco - procrastinandone e condizionandone la tutela al momento dell’adozione di un “piano di gestione” che ha oggetto e finalità diverse rispetto al piano paesistico nell’ordinamento interno"
Insomma, secondo il TAR, il PTPR (si badi: nella versione adottata):
“rinuncia” a prescrivere modalità d’uso a tutela dei siti Unesco, “delegando” la disciplina paesaggistica di questi all’adottando Piano di “gestione e valorizzazione” del sito UNESCO – a cui rinvia - disciplinato dalla legge n. 77/2006, che ha oggetto diverso e che è indirizzato a tutt’altra finalità rispetto a quella perseguita dal PTPR. Pertanto, il rinvio al Piano di Gestione sopraindicato, (...), determina un pericoloso “vuoto di tutela” proprio per aree di maggior valore, addirittura di livello “universale” - dichiarate “Patrimonio Comune dell’Umanità” proprio in base al riconoscimento della loro assolutamente “eccezionale” importanza (quindi di un’importanza di grado superiore rispetto all’importanza di grado solo “notevole” richiesto nell’ordinamento interno per la sottoposizione a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004) - con evidenti risultati paradossali, inammissibili sul piano logico, ancor prima che giuridico"
La decisione del TAR, quindi, sostanzialmente disapplicando l'art. 45, co. 13 NTA PTPR adottato (e ritenendo inesatte, pertanto, anche le indicazioni regionali di cui al parere del 2009), dichiara legittimo l'intervento in autotutela del MiBAC, affermando la necessità, per gli interventi da eseguire in zona UNESCO, dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004.
3. Considerazioni finali e (incerte) prospettive future.
Al netto di quanto eventualmente potrà essere deciso dal Consiglio di Stato in sede di eventuale appello, occorre svolgere alcune riflessioni generali (ossia che prescindono dal caso oggetto della sentenza 5757/2020).
La sentenza, infatti, rischia di porre nell'incertezza la disciplina autorizzatoria degli interventi da realizzarsi all'interno dell'estesissimo perimetro dell'ara UNESCO di Roma (ricompresa all'interno delle Mura Aureliane).
Tale iter che oggi - salvo in caso di immobili interessati da specifici vincoli paesaggistici ex art. 136 d.lgs. 42/2004 - è regolato, come visto, dall'art. 24, co. 19 NTA PRG, con conseguente acquisizione del "parere consultivo" della Soprintendenza MiBAC, secondo le regole procedurali di cui al già citato Protocollo d'intesa Roma Capitale - MiBAC.
Oltre a determinarsi una non marginale incertezza per operatori, tecnici e Amministrazione, il rischio è anche quello di una sovrapposizione tra quest'ultimo procedimento "consultivo" (ma sostanzialmente autorizzatorio) e quello ex art. 146 del d.lgs. 42/2004.
Un secondo profilo da evidenziare è che, a ben vedere, il profilo che più ha "allarmato" il TAR nella decisione 5757/2020 (la rimessione della tutela dell'area UNESCO ad uno strumento futuro e comunque improprio, ossia il "Piano di gestione") potrebbe (condizionale d'obbligo) ritenersi in una certa misura "superato" dalla versione approvata delle NTA del PTPR.
Come segnalato prima, infatti, il vigente art. 44, co. 19, NTA PTPR ha sostituito il "rinvio" al "Piano di gestione", optando per "elevare" il protocollo d'intesa Roma Capitale - MiBAC a disciplina paesaggistica dell'area UNESCO ( la norma, infatti, si riferisce alle "valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi").
Da tale circostanza, dunque, può discendere un dubbio circa la - quantomeno automatica - applicabilità dei principi sanciti da TAR Lazio 5757/2020 alle procedure abilitative edilizio-paesaggistiche alle quali è applicabile, ratione temporis, il PTPR approvato il 13.2.2020.
Sullo "sfondo", peraltro, resta anche il giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dinanzi alla Corte costituzionale dal MiBAC contro la Regione Lazio per la denunciata violazione del necessario (nella tesi statale) coinvolgimento del Ministero nel procedimento di approvazione del PTPR.
Qui, in particolare, il MiBAC denuncia che:
"per il centro storico di Roma, al quale non si applica l'art. 44, la regione - al comma 19 - modifica il corrispondente testo del 2015, secondo il quale, in relazione alla particolarita' del sito, era prevista l'applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi congiuntamente tra regione e Ministero. Nel testo approvato, tali previe prescrizioni non sono piu' contemplate e si rimette ogni valutazione dei singoli interventi alla Soprintendenza, facendo riferimento a un protocollo d'intesa con il Comune di Roma risalente al 2009 e non pertinente. Il PTPR rinuncia cosi', in sostanza, a esercitare il ruolo doveroso di disciplinare complessivamente e sulla base di una visione d'insieme gli interventi nel sito UNESCO del centro storico di Roma"
In buona sostanza, il Ministero ritiene che il rinvio al protocollo d'intesa Roma Capitale - MiBAC non sia sufficiente ad integrare una idonea disciplina di tutela paesaggistica, occorrendo invece, l'individuazione di "specifiche prescrizioni di tutela da definirsi congiuntamente tra regione e Ministero".
In conclusione, tra "disapplicazione" da parte del TAR Lazio e futura decisione della Corte costituzionale (che potrebbe annullare la delibera di approvazione del PTPR), la questione della disciplina "paesaggistica" dell'area UNESCO di Roma pare allo stato quantomai "precaria".
E ciò con tutte le ovvie conseguenze sulla certezza del diritto e sull'affidamento dei privati e dei tecnici nelle regole note e scritte.
SCIA "in sanatoria" ex art. 37 TUEd e silenzio: che confusione!
 "SCIA in sanatoria: che confusione! Sarà perchè saniamo?"
"SCIA in sanatoria: che confusione! Sarà perchè saniamo?"
Torniamo ancora una volta su un tema apparentemente innocuo ma foriero di non pochi equivoci operativi, ossia il meccanismo abilitante della c.d. SCIA in sanatoria (ossia in accertamento di conformità).
Lo spunto è offerto dalla recente sentenza TAR Lazio, Sez. II-quater, 9.4.2020, n. 3851 segnalata e commentata da Carlo Pagliai sul suo blog e il problema è ben noto: data un'opera abusiva rientrante nel regime della SCIA semplice (ossia ex art. 22 TUEd e, quindi, non ex art. 23 TUEd), una volta presentata la SCIA in sanatoria come si perviene alla regolarizzazione dell'intervento?
E' qui che regna - come abbiamo segnalato in altro contributo - la più totale confusione con il fronteggiarsi di ben tre soluzioni:
a) silenzio diniego, secondo il modello dell'art. 36;
b) silenzio-inadempimento (ossia un silenzio privo di valenza provvedimentale);
c) formazione del "titolo" al decorso del termine, come nella SCIA ordinaria ex art. 19 L. n. 241/90.
1. L'art. 37 D.P.R. 380/01: non si parla di "SCIA in sanatoria"
Alle radici della questione vi è l'art. 37 del TUEd il cui comma 4 così dispone:
Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
La disposizione statale, quindi, non precisa espressamente se per ottenere la sanatoria occorra un provvedimento espresso o meno, diversamente dall'art. 36 che invece espressamente prevede la necessità del provvedimento espresso, fatta salva la possibilità del silenzio-diniego.
2. La "SCIA in sanatoria" nella legislazione regionale e, soprattutto, nel Decreto "SCIA 2".
Si è così affermata, inizialmente nella prassi, poi in talune norme regionali (ad es. L.R. Toscana 65/2014, art. 209; L.R. Emilia-Romagna 23/2004, art. 17)) e, infine, nel D.lgs. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2), la "SCIA in sanatoria": ivi, in particolare, nella Tabella A, sezione edilizia, p.to 41, si menziona espressamente la “SCIA in sanatoria” con riferimento all’art. 37, co. 4, del TUEd.
E, sempre al p.to 41 si prevede espressamente che il relativo “regime amministrativo” è quello – appunto – della SCIA. Il che dovrebbe lasciar intendere che l’effetto abilitante (sanante) si produca con il semplice deposito della segnalazione certificata, senza necessità di provvedimenti espressi del Comune.
3. Il perdurante oscillamento della giurisprudenza e la questione della quantificazione della "somma ... stabilita dal responsabile del procedimento".
Tuttavia, nonostante tale intervento normativo perdura il contrasto giurisprudenziale.
Nel primo orientamento, secondo il quale occorre un provvedimento espresso, pena il determinarsi di un inadempimento da parte della P.A. - si segnala ad esempio, oltre TAR Lazio 3851/2020, anche TAR Puglia, Lecce, 9.3.2020, n. 317 , secondo cui l’art. 37 del D.P.R. 380/2001 non solo non contempla una fattispecie di silenzio significativo (come il rigetto ex art. 36 del medesimo D.P.R.) ma, anzi, presuppone una conclusione espressa del procedimento, atteso che la norma prevede la necessaria quantificazione della sanzione pecuniaria da parte del responsabile del procedimento. Tale orientamento giurisprudenziale, peraltro, pare non "fare i conti" con le indicazioni provenienti dal p.to 41 della Tabella A- Sez. edilizia del decreto SCIA 2.
Negli stessi termini – come vedremo esaminando la normativa regionale di riferimento – si è espressa anche la Regione Lazio sia nel parere prot. 4748 del 7.3.2011 sia nel più recente parere prot. 0705439 del 9.11.2018, dove, in buona sostanza, si afferma che il meccanismo sanante non sarebbe quello della SCIA ma una vera e propria istanza che presuppone una risposta espressa della P.A. Tanto, nell’ottica del parere regionale in parola, deriverebbe anche dal fatto che gli artt. 22 (SCIA “semplice”) e 23 (SCIA alternativa al permesso di costruire) del D.P.R. 380/2001 non contemplerebbero in alcun modo la fattispecie della sanatoria. Ad avviso della Regione Lazio, peraltro, sarebbe non dirimente quanto espressamente previsto dal p.to 41 della Tabella A - Sezione edilizia del d.gls. n. 222/2016.
La tesi secondo la quale la SCIA in sanatoria non richiederebbe un provvedimento espresso - essendo, appunto, un SCIA - trova concorde altra parte della giurisprudenza, come TAR Lazio, Sez. II-bis 9.1.2018, n. 156, TAR Puglia, Lecce, 8.2.2018, n. 180 e TAR Campania, Napoli 9.12.2019, n. 5789, oltre che la più risalente decisione Cons. Stato n. 1534/2014. Si segnala, sul punto, inoltre anche la posizione della Regione Emilia-Romagna nel parere prot. PG/2017/02565333 del 3.4.2017 che, sia pur con riferimento alla relativa normativa regionale, evidenzia come la SCIA in sanatoria segue la disciplina generale della SCIA, con consolidamento della regolarizzazione tramite il decorso del termine di legge
Resta il tema che, ai fini della concreta applicabilità della soluzione in questione – a nostro avviso teoricamente preferibile ed oggi “ratificata” dal D.lgs. n. 222/2016 – occorre considerare il tema del versamento della sanzione al quale l’effetto sanante è subordinato.
La norma afferma infatti che è possibile “ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma (…) stabilita dal responsabile del procedimento (…)”: non a caso, l’opposto orientamento valorizza, per negare l’effetto abilitativo della SCIA in assenza di provvedimento espresso, proprio la necessità che la P.A. determini la somma.
Tale questione, peraltro, nella prassi è di frequente superata giacché, come si dirà, mentre la norma nazionale fa riferimento ad una determinazione dell’importo rimesso alla valutazione dell’Agenzia del territorio, in relazione all’aumento del valore dell’immobile, le norme regionali e gli atti regolamentari comunali prevedono il più delle volte dei sistemi parametrici per la esatta determinazione dell’importo che, quindi, può essere tendenzialmente “autoliquidato” dal soggetto che presenta la SCIA.
Evidentemente, laddove ciò non sia possibile sembra potersi dubitare dell’efficacia sanante della mera presentazione della SCIA in sanatoria.
4. Le legislazioni regionali e dubbi di legittimità costituzionale
Come accennato, alcune Regioni espressamente parlano di SCIA in sanatoria, ricollegando alla presentazione della stessa il meccanismo abilitante "tipico" della SCIA. In tal caso non si pone un problema di coordinamento con le indicazioni derivanti dal d.lgs. 222/2016 e, in particolare, dal p.to 41 della Tabella A - Sez. edilizia (che, in quanto "ricognitiva", ha quantomeno un valore di interpretazione autentica del D.P.R 380/2001).
Altre Regioni, invece, pur parlando di SCIA in sanatoria, adottano formule normative atte a lasciare insuperato il dubbio circa il "meccanismo sanante".
E' questo il caso della Regione Lazio, dove l'art. 22 della L.R. 15/2008, pur riferendosi testualmente al co. 1 alla SCIA in sanatoria, dispone poi al co. 4 che "sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata".
Si è già detto di come tale norma sia interpretata dalla Regione Lazio stessa (secondo la quale occorre un provvedimento espresso, in assenza del quale si versa in ipotesi di silenzio-inadempimento) nonché del contrasto giurisprudenziale in seno al TAR Lazio.
In tale contesto, oltre ad auspicarsi, ancora una volta, un intervento legislativo atto a dirimere questa (ed altre) ambiguità del D.P.R. 380/2001, si sottopone anche una riflessione ulteriore, con il dubbio di legittimità costituzionale o "efficacia" perdurante di norme regionali che neghino il valore di SCIA a tutti gli effetti alla SCIA in sanatoria (citando Carlo Pagliai: "una SCIA che non SCIA").
Infatti, potrebbe ritenersi che l’assimilazione della SCIA in sanatoria al permesso di costruire in sanatoria a quanto al “regime amministrativo” (ossia prescrivendo la necessità di un provvedimento espresso su una SCIA), sia violativa dei principi generali dettati dalla normativa statale e, in particolare, dall’art. 19 della L. 241/90 e dagli artt. 22 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, anche in riferimento quindi all’art. 117, co. 2, della Costituzione.
Al riguardo, occorre evidenziare come l’art. 5 del D.Leg.vo 222/2016 imponga alle Regioni il rispetto dei “livelli di semplificazione e le garanzie assicurate dal presente decreto”, con l'ulteriore previsione, di cui all'art. 6, co. 2, che "le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017".
Insomma, l'irrigidimento del regime della SCIA in sanatoria, impedendo l’abilitazione “tacita”, potrebbe essere considerato come una violazione, di tali disposizioni.
Ancora su Corte Costituzionale 70/2020: dichiarazione di illegittimità costituzionale e potere di autotutela
![]() La già commentata sentenza n. 70/2020 della Corte costituzionale - relativa ad una norma del Piano Casa Puglia - apre un ulteriore delicato interrogativo, concernente i rapporti tra dichiarazione di llegittimità costituzionale e potere di autotutela della P.A.
La già commentata sentenza n. 70/2020 della Corte costituzionale - relativa ad una norma del Piano Casa Puglia - apre un ulteriore delicato interrogativo, concernente i rapporti tra dichiarazione di llegittimità costituzionale e potere di autotutela della P.A.
La questione, essenzialmente, guardando al caso concreto della L.R. Puglia 14/2009 (ma considerazioni anche più generali sull'argomento), è la seguente: cosa ne è delle SCIA "consolidatesi" per effetto del decorso del tempo? E cosa delle opere realizzate/ultimate in base a tali titoli?
La questione è assai delicata e, come vedremo, non si presta ad una risposta valida per tutte le fattispecie.
Ad ogni modo, di seguito, cercheremo di offrire un quadro generale (necessariamente sommario, anche in ragione del fatto che il tema degli effetti "retroattivi" delle sentenze della Corte costituzionale è assai discusso da dottrina e giurisprudenza).
1. La dichiarazione di illegittimità costituzionale e i suoi effetti retroattivi.
Un primo aspetto da mettere in chiaro - al fine di evitare eccessi di semplificazione - è che le decisioni della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma non sono del tutto prive di effetti - sia pur limitati - retroattivi.
Ossia, detto in altri termini, le sentenze della Corte, nel "rimuovere" una norma dichiarata incostituzionale producono effetti non solo per il futuro (con l'inapplicabilità della norma dichiarata illegittima dal momento dell'adozione della sentenza in poi) ma anche sui rapporti sorti in base alla disposizione oggetto della pronuncia.
Tuttavia, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non produce effetti per i cosiddetti rapporti esauriti, ossia per quelle posizioni giuridiche non più suscettibili, per dirla in maniera poco tecnica, di "riesame" di alcun tipo.
Così, ad esempio, in materia tributaria, la Cassazione (Sez. Trib. 20.1.2016, n. 969) ritiene che la dichiarazione di illegittimità di un tributo non escluda il diritto del contribuente di esigere la restituzione di quanto versato in base ad una norma successivamente "annullata" dalla Corte Costituzionale e ciò fintanto che non sia decorso il termine di prescrizione per avviare l'azione di recupero. In tal caso, quindi, è il termine di prescrizione che consente di qualificare il rappporto come "esaurito" o meno.
Peraltro, la Corte costituzionale, proprio in materia tributaria, con la sentenza 10/2015 ha ritenuto di poter - per ragioni connesse agli equilibri del bilancio dell Stato - di limitare in maniera espressa gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, espressamente statuendo, in sede di di pronuncia di "annullamento" di alcuine norme tributaria, che l'effetto della decisione si produceva "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
2. Potere di autotutela ed "esaurimento del rapporto"
Veniamo, quindi, al tema di nostro interesse: la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una norma della L.R. Puglia 14/2009, in base alla quale molti Comuni avevano assentito - tramite il meccanismo abilitativo della SCIA - numerosi interventi edilizi di demo-ricostruzione con amplianento e modifiche planovolumetriche.
Come sappiamo, a fronte di una SCIA, la P.A. ha il potere di intervenire, una volta decorso il termine di 30 gg., entro 18 mesi, in presenza di un profilo di illegittimità (contrasto con una norma di legge) e con un attento bilanciamento tra interesse pubblico, decorso del termine e affidamento ingeneratosi nel soggetto che ha presentato la SCIA stessa (secondo i parametri dell'art. 21-nonies L. n. 241/90, a cui rinvia, a sua volta, l'art. 19 della medesima legge).
Dunque, in tale prospettiva può affermarsi che - fintanto che non sia decorso il termine di 18 mesi dall'ottenimento del titolo (o, meglio, della presentazione della SCIA nel nostro caso) - il rapporto non possa dirsi "esaurito".
Sicché, ben si comprende come non è affatto escluso a priori che la P.A. possa "tornare sui propri passi".
Ciò vale anche in caso di provvedimenti o SCIA originariamente conformi ad una norma di legge che, successivamente (ed entro il termine di 18 mesi suddetto), sia stata dichiarata incostituzionale?
Secondo la giurisprudenza amministrativa, si.
Infatti, "quando la Pubblica amministrazione assiste alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto amministrativo, vi potrebbe essere una valutazione da parte dell'amministrazione procedente dell'impatto della pronuncia costituzionale sull'atto amministrativo ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela” (Cons. Stato n. 1862/2015).
E, proprio sulla base di tale principio, di recente il TAR Molise ha avuto modo di ritenere legittimo un provvedimento di autotutela con il quale un Comune - a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionaledi una norma del Piano Casa molisano relativa alla deroga alle distanze ex D.M. 1444/1968 - aveva annullato in autotutela un titolo edilizio formatosi tacitamente.
Infatti, "la ricorrenza di una ipotesi di illegittimità sopravvenuta del provvedimento tacitamente formatosi, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva previsto la deroga alla disciplina di principio sulle distanze contenute nell’art. 9 del DM 1444/1968, non preclude l’esercizio del potere di annullamento officioso da parte del Comune" (sent. n. 4/2018).
3. Autotutela possibile, quando?
Appurato che a fronte della dichiarazione di illegittimità costituzionale non è precluso alla P.A. intervenire in autotutela (così come, si noti, non è nemmeno imposto di intervenire con l'annullamento), tentiamo di individuare - per sommi capi e senza pretesa in questa sede di individuare soluzioni o regole "rigide" - i confini di questo potere di annullamento d'ufficio.
Il punto di partenza sono i criteri offerti dall'art. 21-nonies, co. 1, L. n. 241/90:
a) sussistenza di "ragioni di interesse pubblico";
b) ragionevolezza del termine, "comunque non superiore a diciotto mesi"
c) necessità di tenere conto "degli interessi dei destinatari e dei controinteressati".
Come ben chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, i presupposti ex art. 21-nonies L. n. 241/90, che riguardano un potere ampiamente discrezionale (l'autotutela, in linea di principio e salvo ipotesi speciali, non è un atto "doveroso") , devono essere valutati dalla P.A. con attenta valutazione di ciascuno specifico caso, dovendo, ad esempio, valutare l'effettivo interesse pubblico connesso alla violazione di legge prodottasi, il lasso temporale decorso (nel limite massimo di 18 mesi) e, infine, il bilanciamento di interessi di destinatari (il soggetto che si avvantaggia della SCIA, nel nostro caso) e dei controinteressati (chi, ad esempio, sia stato leso dall'intervento).
Occorre - in estrema sintesi - bilanciare l'interesse pubblico (alla legalità da ripristinare) con il legittimo affidamento del privato.
In altre parole, "si impone una valutazione via via più accorta fra l’interesse pubblico al ritiro dell’atto illegittimo ed il complesso degli altri interessi rilevanti ,quali, in primis, quello del destinatario del provvedimento invalido" (TAR Toscana n. 1467/2017).
E' così chiaro - in linea di principio - che un conto sarà, ad esempio, intervenire su una SCIA "recente", relativa ad un intervento in fase embrionale di cantiere, altro annullare una SCIA da tempo consolidatasi e con un intervento ultimato.
Piano Casa, rigenerazione urbana e Corte Costituzionale n. 70/2020: “il corto circuito” dello sblocca-Cantieri 2019.
 Ha fatto davvero molto “rumore”, destando significative preoccupazioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 2020 della Costituzionale, che rischia di produrre un "corto circuito" tra Piani Casa, rigenerazioni urbane e sblocca cantieri 2019.
Ha fatto davvero molto “rumore”, destando significative preoccupazioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 2020 della Costituzionale, che rischia di produrre un "corto circuito" tra Piani Casa, rigenerazioni urbane e sblocca cantieri 2019.
La pronuncia, in disparte alcune questioni aventi rilievo perlopiù “locale”, ossia la disciplina del Piano Casa della Regione Puglia (L.R. 14/2009, così come modificata dalle L.R. 59/2018 e 5/2019), interviene per la prima volta a chiarire la portata dell’art. 2-bis, co. 1-ter, del D.P.R. 380/2001.
Tale disposizione prevede, in particolare, che
“in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.
Il comma in questione è stato introdotto dal c.d. sblocca-cantieri, ossia dalla legge n. 55/2019 (di conversione, con modifiche, del D.L. 32/2019).
Con la sentenza 70/2020 la Consulta è stata chiamata a valutare, tra l’altro, la legittimità dell’art. 7 della L.R. Puglia 5/2019.
Tale disposizione aveva introdotto il co. 5-ter all’art. 4 della L.R. 14/2009, norma, quest’ultima che disciplina gli “interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente”.
In particolare, il co. 5-ter introdotto dall L.R. 5/2019 sottoposta al vaglio della Consulta disponeva che
“Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal comma 1, da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e qualora insistano in zona dotate delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.”
La Corte ha ritenuto tale disposizione illegittima in quanto contrastante con il citato art. 2-bis, co. 1-ter del D.P.R. 380/2001.
Di seguito, i passaggi principali del ragionamento della Corte.
L’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 costituisce un principio fondamentale della materia edilizia (e ciò, sottolinea la Consulta, è già stato chiarito “per ciò che concerne la vincolatività delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968”).
Sicché, posto che la disposizione di cui al co. 1-ter prevede che “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”, si sarebbe al cospetto di una “regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo”.
Tanto premesso, la Corte perviene alla conclusione che vi è una (sopravvenuta) antinomia tra il co. 1-ter della norma del D.P.R. e l’art. 7 della L.R. Puglia 5/20109. Quest'ultimna norma, quindi, non può (o, meglio, “non può più”) prevedere in caso di demo-ricostruzione un aumento di volume, né, tantomeno alcuna diversa dislocazione di volumi, posto il richiamo che l’art. 2-bis, co. 1-ter del D.P.R. 380/2001 opera al necessario rispetto dell’area di sedime (e del volume) in sede di ricostruzione.
A “salvare” la disposizione regionale non è valso opporre – da parte della Regione Puglia – che ci si trova davanti ad una normativa, quella appunto di Piano Casa, eccezionale che, nell’ammettere ampliamenti in sede di demolizione e ricostruzione, si fonda sulla nota intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 1.4.2009, che aveva consentito ai legislatori regionali aumenti volumetrici (tra il 20% ed il 35%) nonché delocalizzazioni.
Insomma, ad avviso della Consulta l’art. 2-bis, co. 1-ter, D.P.R. 380/2001 avrebbe determinato la sopravvenuta illegittimità di tutte le previsioni, ancorché speciali e legittimate da una norma nazionale ed un successivo accordo Stato – Regioni, che ammettono aumenti di cubatura e modifiche della dislocazione plano volumetrica in sede di demo-ricostruzione.
Seguendo la pronuncia della Corte, si potrebbe pervenire alla conseguenza che si sarebbe prodotto nell’ordinamento il superamento – la sopravvenuta illegittimità – di molte delle norme adottate dalle Regioni sotto la “copertura” non solo dell’accordo Stato-Regioni del 1.4.2009, ma anche dell’art. 5, co. 9, D.L. 70/2011 (conv. in legge 106/2001, c.d. decreto sviluppo, il quale, pure, espressamente riconosceva la possibilità di ammettere, per finalità di “incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate”, interventi di demolizione e ricostruzione con premialità di cubatura e diverse localizzazioni). D’altra parte, le disposizioni dei Piani casa fino ad oggi erano state dichiarate incostituzionali – proprio con riferimento al parametro dell’art. 2-bis D.P.R. 380/2001 – con esclusivo riferimento al tema, strettamente inteso, della inderogabilità delle distanze di cui al D.M. 1444/1968.
Con il doveroso ossequio per la Corte Costituzionale, ci sembra che tale lettura – che rischia di creare problemi sistematici, operativi ed economici non indifferenti (paradossale, se consideriamo che la questione sorge da una norma battezzata “sblocca-cantieri”) – innanzi tutto non si faccia sufficiente carico di considerare la specialità dei Piani Casa (ma anche delle leggi sulla c.d. rigenerazione urbana, “applicativi” del D.L. 70/2011).
In altri termini, è ragionevole ritenere che laddove veramente il legislatore statale avesse voluto, con l’introduzione del co. 1-ter dell’art. 2-bis D.P.R. 380/2001, superare tanto i Piani Casa quanto le possibilità parimenti speciali affidate alle Regioni con il D.L. 70/2011, ciò sarebbe dovuto avvenire in modo assai più chiaro ed espresso. E ciò senza considerare come un simile effetto sembrerebbe da escludersi già solo per le finalità dichiarate in generale dalla L. 55/2019 (“sblocca-cantieri”) e, in particolare, dall’art. 5 della stessa, introdotto al dichiarato fine di incentivare la c.d. rigenerazione urbana.
In secondo luogo, ci sembra che la lettura offerta dalla Consulta vada ben oltre alla effettiva portata dell’art. 2-bis, co. 1-ter del D.P.R. 380/2001.
Ci si riferisce, con riferimento a quest’ultimo aspetto, alla circostanza che la norma – in cui il decreto sblocca-cantieri ha inserito il co. 1-ter – non ha ad oggetto la disciplina generale della ristrutturazione edilizia e/o della demolizione e ricostruzione e dei relativi limiti “assoluti” a tali tipologie di intervento, bensì un tema più “limitato”.
L’art. 2-bis, infatti, è rubricato “deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”.
Il co. 1, poi, in parte estendendo il raggio di azione della norma, disciplina il potere delle Regioni di dettare “disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali” (ossia di derogare gli standard edilizi ed urbanistici). Precisa poi il co. 1-bis, introdotto anch’esso dallo sblocca-cantieri del 2019, che le predette disposizioni regionali sono “finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio”.
È in tale norma che si inserisce il co. 1-ter che – a nostro avviso – si limita, con espresso e circoscritto riferimento alla disciplina delle distanze, a prevedere che, per poter mantenere eventuali distanze preesistenti derogatorie del D.M. 1444/1968, l’intervento di demolizione e ricostruzione deve essere realizzato “assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.
Dunque, la norma non sembrerebbe avere avuto una portata tanto innovativa come ipotizzato dalla Corte Costituzionale, quanto, piuttosto, quella di positivizzare l’orientamento giurisprudenziale affermatosi dinanzi al Consiglio di Stato a partire dalla nota sentenza 4337/2017 secondo cui se la ricostruzione avviene nel rispetto della precedente sagoma e area di sedime, potranno essere mantenute le “preesistenti” distanze (anche inferiori a quelle ex art. 9 del DM 1444) mentre se la ricostruzione prevede il mutamento di tali parametri, questa dovrà osservare – come una nuova edificazione vera e propria – la disciplina delle distanze.
D’altra parte, la disciplina “ordinaria” della ristrutturazione edilizia continua ad essere dettata dal combinato disposto degli artt. 3, co. 1, lett. d) (che non impone, ad esempio, il mantenimento della medesima sagoma, salvo il caso di immobili vincolati ed area di sedime in caso di ristrutturazione con demo-ricostruzione), e 10, co. 1, lett. c) (che qualifica espressamente come ristrutturazione edilizia anche interventi che modifichino sagoma e volume del fabbricato) del D.P.R. 380/2001, a loro volta oggetto di ricognizione da parte della Tabella A del d.lgs. 222/2016 (cfr. punti 7 ed 8).
Quanto precede, peraltro, al netto del fatto che gli interventi di demolizione e ricostruzione, se eseguiti con ampliamento volumetrico, come da insegnamento della giurisprudenza amministrativa, non sono propriamente nemmeno da ricondurre alla categoria della ristrutturazione edilizia, quanto, piuttosto della “sostituzione edilizia”, assimilabile alla nuova costruzione.
Ma si tratta di tema che, in realtà, nell’ambito di norme, si ribadisce, speciali (i c.d. Piani Casa ovvero le leggi sulla rigenerazione urbana, “applicative” del D.L. 70/2011), appare comunque assorbito dalla natura eccezionale e derogatoria di dette fonti che, peraltro, espressamente ammettono la forma di intervento demolizione e ricostruzione con ampliamento.
Come uscirne? Possibili argomentazioni atte a "circoscrivere" la portata della sentenza [upgrade del 7.5.2020]
Ovviamente, per quanto discutibile o poco convincente (a nostro avviso, s’intende), la sentenza della Corte rischia di determinare un effetto “incertezza” su operatori economici, investitori e P.A.. Inoltre, vi è il pericolo di un “effetto domino”, tale da potersi estendere (in modo imprevedibile) anche a norme di altre regioni (le quali, laddove prevedano, come in moltissimi casi, interventi di demo-ricostruzione con bonus volumetrico e modifiche plano-volumetriche, ben potrebbero essere considerate illegittime a far data dall’entrata in vigore del co. 1-ter dell’art. 2-bis D.P.R. 380/2001, ossia dal 19.6.2019).
Non resta che auspicare un pronto intervento del legislatore statale.
A meno che della sentenza della Corte non voglia - e possa - darsi una lettura particolarmente restrittiva (per non dire riduttiva e “correttiva”) nel senso che la stessa semplicemente intenderebbe ribadire che, in caso di modifiche di volume e/o area di sedime, sarebbe doveroso il rispetto delle distanze prescritte dal D.M. (ma, se così fosse, la decisione probabilmente non avrebbe dichiarato in modo così tranchant l’incostituzionalità della norma).
Ecco, quindi, alcune ipotesi interpretative, anche tra loro connesse, di interpretazione "restrittiva" della sentenza della Corte.
In tal senso, un possibile argomento atto a supportare questa interpretazione “restrittiva” della decisione della Corte è costituito dal rilievo che la norma di cui al co. 1 dell’art. 4 della L.R. Puglia 14/2009 non viene – almeno espressamente – qualificato come illegittima, ancorché tale comma espressamente preveda, a monte, la possibilità di realizzare interventi di demo-ricostruzione con aumenti di cubatura.
Per tale via, dunque, potrebbe trovarsi un – parziale – supporto alla tesi che la Corte abbia voluto solamente dichiarare l’incostituzionalità del nuovo art. 4, co. 5-ter, solo se inteso quale deroga delle regole sulle distanze prescritte dall’art. 2-bis, co. 1-ter del D.P.R. 380/2001.
Insomma, come da riflessioni condivise con l'arch. Luca Baldini , il senso della decisione potrebbe essere quello di voler "ribadire" che la derogabilità della disciplina sulle distanze ex D.M. 1444/1968 è ammessa solo in interventi contemplati "nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali" (come prescritto dall'art. 2-bis, co. 1, D.P.R. 380/2001) e non, quindi, in caso di interventi "diretti" puri.
Anche in questo caso - ferma la correttezza del principio e la sua certa applicabilità anche alle norme dei Piani Casa e delle normative sulla rigenerazione urbana - la sentenza della Corte si rivelerebbe meno "innovativa" di quel che appare e, inoltre, difficilmente ancorabile agli effetti "diretti" del co. 1-ter dell'art. 2-bis D.P.R. 380/2001.
Infatti, il principio della non derogabilità del D.M. 1444/68 se non nell'ambito di strumenti di pianificazione "a larga scala" è fermo e pacifico da ben prima della legge sblocca-cantieri del 2019, essendo stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, anche prima della sua codificazione nell'art. 2-bis citato (ad es. Corte Cost. 232/2005; Cons. Stato 5108/2013; Corte Cost. 41/2017, relativa al tema della deroga delle distanze nel Piano Casa Veneto).
Altra ipotesi interpretativa "restrittiva" è quella che è nata da un confronto ed una riflessione con l'arch. Marco Campagna (qui, un suo commento alla sentenza, con riflessioni operative in ordine alla L.R. Lazio n. 7/2017 sulla rigenerazione urbana).
In particolare, è anche possibile porre l'accento sulla circostanza che la Consulta nella sentenza n. 70/2020 afferma che il co. 1-ter dell'art. 2-bis esprime una " una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli".
L'espresso riferimento alle disposizioni in materia di SCIA potrebbe essere valorizzato - pur nella cripticità del dispositivo della sentenza della Consulta - nel senso di ritenere che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è limitata ad impedire che gli interventi di demo-ricostruzione con ampliamento (ossia, come abbiamo già rammentato, "sostituzione edilizia") possano essere realizzati con SCIA (semplice, ex art. 22 o alternativa, ex art. 23 D.P.R. 380/2001) anziché permesso di costruire.
Tale prospettiva - seppure di sicuro interesse - potrebbe essere posta in discussione, in vero, dal fatto che a strettissimo rigore non è stato tanto il co. 1-ter dell'art. 2-bis a "chiarire" che gli interventi di demo-ricostruzione con aumento di volume non rientrano nel regime della SCIA (semplice o alternativa), quanto, piuttosto, il d.lgs. 222/2016 (c.d. decreto SCIA 2) e, in particolare, i già citati p.ti 7 ed 8 della Tabella A, Sezione edilizia.
Qui, in particolare, si precisa, laddove vengono esaminati gli “elementi costitutivi della fattispecie” , al p.to 7 (RE “leggera”) la necessità che l’intervento non determini maggiore volumetria mentre, al p.to 8 (RE “pesante”) è espressamente richiesto che gli interventi “non prevedano la completa demolizione dell’edificio esistente“.
Sicché, a ben vedere, la non riconducibilità degli interventi di sostituzione edilizia (DR+aumento cubatura ed eventuale delocalizzazione) al regime della SCIA (e, quindi, la loro sussumibilità nel regime del PdC) non sembra essere un effetto "diretto" dello sblocca cantieri.