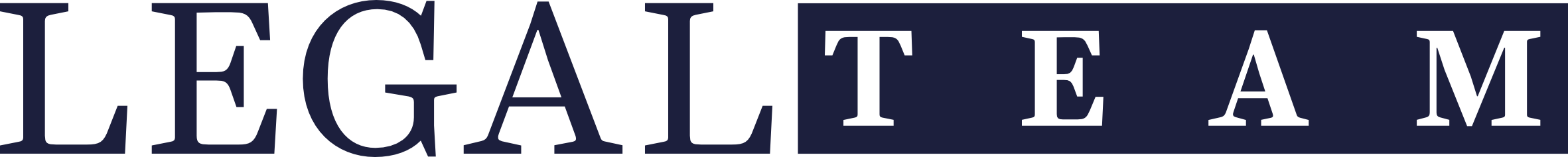Sviluppo della mobilità sostenibile: le modifiche al codice della strada introdotte dal d.l. 68/2022
 Qualche giorno fa è entrato in vigore il d.l. 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Qualche giorno fa è entrato in vigore il d.l. 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Il decreto contiene numerose novità in materia di mobilità sostenibile. L’art. 7 del decreto, infatti, modifica una serie di norme del codice della strada al fine ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale.
Vediamo in dettaglio le novità di maggior rilievo.
Innanzitutto, il decreto attribuisce alle infrastrutture di ricarica dei veicoli la qualifica di pertinenze di servizio di cui all’art. 24 del codice della strada.
Di conseguenza, la norma specifica che le aree di ricarica dei veicoli possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario della strada e possono essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione autostradale, la realizzazione delle pertinenze di servizio dovrà tenere conto sia delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività, ma anche di quelle relative all’istallazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.
Una delle novità di maggiore impatto è quella che attiene alla modifica delle classificazioni dei veicoli disciplinate dall’art. 47 del codice della strada e, in particolare, delle categorie L1e, L2e, L3e e L4e nella cui nozione viene introdotta anche la potenza del motore elettrico.
Di particolare rilevanza sono anche le modifiche apportate all’art. 50 del Codice della Strada che contiene la definizione di velocipedi. Come noto, a tale categoria di veicoli sono assimilati anche i monopattini.
Nella precedente formulazione della norma, infatti, nella definizione di velocipedi rientravano solo:
- veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
- le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare
Il d.l. 68/2020 precisa che nella nozione di velocipedi rientrano anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,5 kW se adibiti al trasporto di merci. L’intento della norma è chiaramente quello di favorire l’utilizzo di tali mezzi anche nel trasporto di merci nei piccoli tratti o nel tessuto cittadino.
A tal proposito viene modificato il comma 2 dell’art. 50 che disciplina i requisiti strutturali dei velocipedi adibiti al trasporto merci. Tali veicoli devono avere un piano di carico:
- approssimativamente piano e orizzontale;
- aperto o chiuso;
- corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico ≥ 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.
A corredo della norma vengono altresì aggiunti i commi 2-bis e 2-ter secondo cui:
- i velocipedi a pedalata assistita che manchino di una o più delle caratteristiche previste dall’art. 50 devono essere considerati ciclomotori;
- chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita capaci di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dalla legge o chi manomette i velocipedi a pedalata assistita al fine, alternativamente, di aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti posti dalla legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Sempre con riferimento al tema della mobilità sostenibile e della micromobilità elettrica, l’art. 7, comma 3 del decreto 68/2022 interviene sul d.l. 162/2019, portando da 12 a 24 mesi la proroga della sperimentazione sui mezzi di micromobilità elettrica.
In materia di comportamento dei pedoni e di autorizzazioni alla circolazione su strada pedonale delle macchine per uso di bambini o di persone invalide, il decreto consente la circolazione di macchine elettriche per la mobilità dei soggetti affetti da disabilità anche su piste ciclabili e sulle aree ciclopedonali e sulle strade urbane ciclabili.
L’art. 7 del d.l. 68/2022 permette altresì ai titolari di patenti B di guidare anche i veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto delle merci che:
- siano alimentati con i combustibili alternativi elencati all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE (elettrici, a idrogeno, ecc.);
- abbiano una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non a 4250 kg, con l’ulteriore condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione.
Vengono altresì imposte delle limitazioni alla guida dei veicoli plug-in, il cui limite di potenza specifica è pari a 65 kW/t compreso il peso della batteria.
Ulteriori modifiche riguardano infine l’interdizione della conduzione dei veicoli e i rinnovi di patente ultraquinquennali.
Il comma 4 sospende infine l’incremento dell’onere concessorio delle autostrade A24 e A25 dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti al 31 dicembre 2017.
Per completezza, si segnala che anche l’art. 8 del decreto in commento, guardando al sistema della mobilità, introduce alcune previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile. Vengono altresì precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali e introdotto l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio dei dati dell’attività manutentiva programmata. Infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l’ammodernamento delle ferrovie regionali.
Esecuzione del servizio di mensa scolastica. Le disposizioni Covid-19 sopravvenute si applicano anche alle gare già indette?
 Le disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19 sopravvenute sull’esecuzione del servizio di mensa scolastica si applicano anche alle gare indette prima della loro adozione? Che tipo di effetto comportano sull’offerta presentata, sulla gara e sull’esecuzione del servizio? A darci una risposta è di recente intervenuto il TAR Lecce.
Le disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19 sopravvenute sull’esecuzione del servizio di mensa scolastica si applicano anche alle gare indette prima della loro adozione? Che tipo di effetto comportano sull’offerta presentata, sulla gara e sull’esecuzione del servizio? A darci una risposta è di recente intervenuto il TAR Lecce.
Il caso origina da una gara indetta da un comune nel giugno del 2020 per l’affidamento del servizio mensa scolastica, della durata di tre anni.
Nell’agosto del 2020, uno degli operatori economici partecipanti aveva chiesto la revoca del bando di gara, in quanto le disposizioni in esso contenute non risultavano in linea con le disposizioni impartite dal CTS e recepite dal Ministero della Pubblica Istruzione. In particolare, dall’analisi delle determinazioni assunte a livello ministeriale per prevenire il contagio da Covid-19, emergeva la necessità che la gara venisse adattata ai nuovi standard qualitativi di sicurezza e di benessere, con necessità di rivedere e modificare l’oggetto del contratto e le modalità di esecuzione della prestazione. A seguito del rifiuto espresso dalla PA di revoca del bando nel settembre 2020, l’operatore aveva proceduto a impugnare la determinazione in questione e, con successivi motivi aggiunti, ad impugnare l’aggiudicazione definitiva e tutti i relativi atti di gara.
Secondo il ricorrente, infatti, la P.A. avrebbe violato, tra l’altro, il principio di immodificabilità dell’oggetto dell’appalto e avrebbe agito in violazione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” del 26 giugno 2020, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del conseguente Protocollo di Sicurezza sottoscritto dal Ministero e dalle organizzazioni sindacali. Il Documento, infatti, ha previsto che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, la somministrazione dei pasti debba avvenire in modalità “Lunch box” o “Pasto monoporzione”, oppure con la consegna del pasto in classe al banco di ogni singolo studente. Secondo il ricorrente, poi, la disciplina dettata dall’emergenza da Covid-19 avrebbe previsto l’adozione di misure volte a garantire il distanziamento sociale anche nel servizio di mensa scolastica, con l’effettuazione di turni, una sanificazione accurata e costante delle aule prima e dopo il pasto, nonché un centro cottura con caratteristiche strutturali in grado di consentire di lavorare in sicurezza.
Che le disposizioni in questione abbiano comportato una modifica della prestazione era evidente, secondo il ricorrente, anche alla luce della Delibera ANAC n. 598 dell’8.7.2020, che ha evidenziato che le misure anti-contagio incidono in maniera significante nei contratti, incidendo sui costi della sicurezza, sulle tempistiche e sulle modalità di esecuzione delle prestazioni, e sono suscettibili di modificare in maniera sostanziale l’oggetto del contratto.
In ordine alle modalità di esecuzione del servizio, infatti, il Capitolato di gara aveva previsto un servizio di multi porzione, per cui il gestore avrebbe dovuto provvedere all’allestimento dei tavoli nella sala mensa, alla distribuzione e ripartizione delle porzioni agli studenti mediante l’utilizzo di carelli termici, a sbucciare loro la frutta, alla pulizia della sala mensa, al ritiro dei contenitori, e alle forniture di tovaglie e tovaglioli a perdere.
L’offerta tecnica della ricorrente risultava pertanto in linea con le richieste del Capitolato ma non più in linea rispetto alle disposizioni anti-contagio sopravvenute.
Il TAR Lecce ha tuttavia rigettato il ricorso.
Secondo i Giudici, le disposizioni sopravvenute del CTS e del Ministero che implicano, in particolare, la somministrazione dei pasti in modalità “Lunch box” o “Pasto Monoporzione” non sarebbero applicabili alla procedura in questione perché bandita prima della loro adozione. Accanto a ciò, il Collegio ha precisato che le suddette disposizioni non troverebbero applicazione in quanto nel caso di specie sarebbero applicabili unicamente le disposizioni regionali pugliesi che prevedono la somministrazione dei pasti nel locale refettorio o in altri spazi con le modalità e le precauzioni indicate. Peraltro, lo stesso Documento per la pianificazione delle attività scolastiche del Ministero prevedeva che “anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe”: la fornitura del pasto in lunch box per il consumo in classe sarebbe pertanto solo una misura eventuale e non un obbligo. Nell’ambito della gara in questione, inoltre, la stessa ASL aveva chiarito che, dal punto di vista igienico-sanitario, il servizio di monoporzione comporta una maggiore manipolazione dei pasti e un aumento del contatto con superfici contaminate, per cui - se non espressamente previsto - la modalità di somministrazione dei pasti può ben essere condotta in maniera tradizionale.
Infine, precisa il Collegio, la Stazione appaltante aveva integrato e riapprovato il Capitolato speciale d’appalto prevedendo che l’impresa aggiudicataria dovesse attenersi a tutte le norme e le disposizioni di sicurezza emanate e adottate dalle amministrazioni competenti. Tale integrazione, pertanto, era sufficiente “a superare, nella sostanza, la lamentata sopravvenuta inattualità del disciplina di gara”.
TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 5.5.2020, n. 714
Subappalto necessario nel settore dei beni culturali: per la Corte Costituzionale è ammissibile.
 Le differenze operative tra subappalto necessario e avvalimento nel settore dei beni culturali sussistono, ed è legittimo il solo divieto di avvalimento sancito dall’art. 146, comma 3, del Codice. Così si è espressa di recente la Corte Costituzionale.
Le differenze operative tra subappalto necessario e avvalimento nel settore dei beni culturali sussistono, ed è legittimo il solo divieto di avvalimento sancito dall’art. 146, comma 3, del Codice. Così si è espressa di recente la Corte Costituzionale.
I contratti nel settore dei beni culturali sono da sempre oggetto di una specifica disciplina. Già il codice del 2006 ed il Regolamento d.P.R. 207/2010 avevano dettato delle norme particolari in materia di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori su beni di interesse culturale. Il regime giuridico dei contratti nel settore dei beni culturali conserva una disciplina autonoma e speciale anche nell’attuale codice, all’intero Capo III.
La ratio di un regime giuridico peculiare è da rivenire nella finalità di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione dei beni culturali. L’art. 145 del d.lgs. 50/2016 specifica che tale disciplina peculiare si applica sia ai contratti relativi a beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, sia all’esecuzione di scavi archeologici e subacquei.
Tra gli aspetti peculiari che connotano la disciplina dei contratti nel settore dei beni culturali, l’art. 146, comma 3, del Codice, impone il divieto di avvalimento di cui all’art. 89.
Con ordinanza n. 195/2020, il TAR Molise aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 105 e 146 del Codice dei contratti pubblici per contrasto con gli artt. 3 e 9 della Costituzione, nella parte in cui prevedono un trattamento differenziato per avvalimento e subappalto, in particolare non essendo sancito per il settore dei beni culturali anche il divieto di subappalto, nella peculiare figura del subappalto necessario.
Il caso
L’occasione trae origine da una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti di videosorveglianza, antiintrusione e controllo degli accessi di taluni istituti afferenti ad un polo museale regionale. Il disciplinare di gara prevedeva come categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, la OG2 (relativa al restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), pari al 22% dell’importo dell’appalto.
Nell’ambito del giudizio, la ricorrente terza classificata impugna gli atti della procedura sostenendo che non sarebbe stato possibile utilizzare il subappalto necessario nell’appalto in questione poiché era stato attivato in relazione ad una categoria SOA (la OG2) per la quale, in forza dell’art. 146, comma 3, non è ammesso l’istituto dell’avvalimento. La categoria OG2, essendo a qualificazione obbligatoria, avrebbe dovuto essere posseduta dal concorrente in proprio: il mancato possesso non era suscettibile di essere sanato mediante avvalimento, né, dunque, mediante subappalto qualificante, istituto invece adoperato dal concorrente.
Con ordinanza n. 195/2020, i giudici del TAR Molise hanno posto la questione di legittimità costituzionale avuto riguardo all’utilizzo del subappalto necessario nella peculiare categoria di contratti nel settore dei beni culturali e, più precisamente, nella parte in cui gli artt. 105 e 146 del Codice prevedono un trattamento differenziato per avvalimento e per il subappalto necessario.
Richiamando le analogie e le differenze dei due istituti, accomunati entrambi da finalità pro-concorrenziali, i giudici hanno precisato come l’avvalimento offrirebbe maggiori garanzie rispetto al subappalto: in particolare, ove questo è “confinato alla fase esecutiva dell’appalto e sottratto ai controlli amministrativi aventi sede nella procedura di gara: (i) si presta ad una possibile sostanziale elusione dei principi di aggiudicazione mediante gara e di incedibilità del contratto; (ii) costituisce un mezzo di possibile infiltrazione negli pubblici appalti della criminalità organizzata, la quale può sfruttare a suo vantaggio l’assenza di verifiche preliminari sull’identità dei subappaltatori proposti e sui requisiti di qualificazione generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016; (iii) conosce una prassi applicativa talora problematica, poiché la tendenza dell’appaltatore a ricavare il suo maggior lucro sulla parte del contratto affidata al subappaltatore (tendenzialmente estranea ad ingerenze della stazione appaltante) produce riflessi negativi sulla corretta esecuzione dell’appalto, sulla qualità delle prestazioni rese e sul rispetto della normativa imperativa in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro”.
Nella disciplina dei contratti nel settore dei beni culturali, una limitazione al subappalto sarebbe peraltro giustificata dal peculiare interesse pubblico a cui la disciplina di tali beni fa capo, restando consentita una simile estensione anche dalla stessa normativa europea che ammette meccanismi derogatori al libero mercato nei casi in cui si renda necessario proteggere il patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.
La decisione della Consulta
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il Collegio ritiene che la ratio del divieto di avvalimento per i beni culturali, previsto dall’art. 146, comma 3 del Codice, risiede nell’esigenza di affidare i lavori che riguardano i beni culturali a soggetti particolarmente affidabili e muniti di qualificazione specialistiche, proprio al fine di assicurare adeguata tutela a tali beni.
Ciò in ragione del fatto che l’avvalimento determina “un effetto giuridico, che, a seconda delle risorse offerte, può essere variamente conseguito attraverso il «i) mandato [...], ii) [...] [l'] appalto di servizi, nonché iii) [la] garanzia atipica» (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4 novembre 2016, n. 23) o altro contratto tipico o atipico”.
L'avvalimento, infatti, permetta temporaneamente di operare un'integrazione dell'aggiudicataria con i mezzi, i beni o le competenze professionali messi a disposizione dall'ausiliario, che sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara: per queste ragioni, il contratto deve indicare con precisione i requisiti prestati e deve essere accompagnato da una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, con cui essa attesta, oltre al possesso dei requisiti, anche il suo impegno, nei confronti non soltanto del concorrente, ma della stessa stazione appaltante, a fornire le risorse di cui il primo è carente.
Quanto alla fase esecutiva dell'appalto, invece, l’impresa ausiliaria non è tenuta ad eseguire le prestazioni riferite alle risorse offerte e, dunque a ad eseguire direttamente i lavori, ferma restando la facoltà dell'aggiudicatario di stipulare con l'ausiliaria anche un contratto di subappalto. L'art. 89, comma 8, del Codice dispone, infatti, che l'esecuzione spetta all'aggiudicatario, che deve integrare al proprio interno le risorse dell'ausiliario.
Pertanto, non essendo prevista alcuna garanzia che l’esecuzione dei lavori venga effettuata direttamente dall’ausiliaria, è ragionevole il divieto sancito all'art. 146, comma 3, del d.lgs. 50/2016 per il settore dei beni culturali.
Lo stesso non vale, invece per il subappalto.
Secondo il Collegio, infatti, “il subappalto, pur condividendo con l'avvalimento taluni caratteri e finalità, a partire dal favor partecipationis, si connota per una disciplina, che garantisce la tutela dei beni culturali, ove siano oggetto del contratto”. Due sono gli aspetti che li distinguono.
Il primo, attiene al fatto che il subappalto presuppone che l'impresa abbia i requisiti per partecipare alla gara. Nei contratti di lavori, infatti, opera il c.d. subappalto necessario (vigente ex art. 12, comma 2, l. 80/2014, tuttora vigente) in forza del quale l'impresa che non disponga di tutte le qualificazioni richieste per le singole lavorazioni oggetto dell'appalto, è tenuta a possedere almeno l'attestazione SOA relativa alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oggetto del contratto. Solo nel caso delle categorie a qualificazione non obbligatoria, infatti, l'aggiudicatario può eseguire anche in proprio le relative lavorazioni, sfruttando l'attestazione SOA posseduta nella categoria prevalente (art. 12, comma 2, lett. a), l. 80/2014). Per le categorie a qualificazione obbligatoria, infatti, l'ordinamento impone che l'esecutore dei lavori abbia tale specifica qualificazione. Di conseguenza, il concorrente, pur se dotato dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione alla gara - grazie all'attestazione SOA posseduta nella categoria prevalente -, non può eseguire in proprio le lavorazioni inerenti alle categorie a qualificazione obbligatoria, dovendo necessariamente ricorrere al subappalto. Al contrario, nel caso dell'avvalimento, il concorrente che da solo non dispone delle qualifiche per partecipare alla gara, può integrare le risorse e le competenze necessarie tramite l'avvalimento, eseguendo tuttavia in proprio le relative prestazioni.
Di conseguenza, il secondo aspetto che differenzia subappalto e avvalimento attiene al fatto che il subappalto – quale “subcontratto che si dirama dal modello dell'appalto” – ha ad oggetto un’obbligazione tipica sancita dall’art. 1655 c.c., ossia il compimento “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” di un'opera o di un servizio “verso un corrispettivo in denaro”. In sostanza, l'esecuzione dei lavori in proprio ad opera del subappaltatore rientra tra le obbligazioni tipiche del subappalto, cui, viceversa, risulta in toto estranea l'obbligazione a prestare unicamente requisiti.
Il subappalto, dunque, garantisce che l'esecuzione della prestazione sia effettuata in proprio e in via diretta dal subappaltatore.
Nel settore dei beni culturali, peraltro, l'art. 148, comma 4 del Codice – secondo cui “[i] soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 [riferito ai beni culturali e del paesaggio] devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo” -, assicura a maggior ragione che il subappaltatore esecutore dei lavori disponga delle necessarie qualificazioni specialistiche, per cui è il subappaltatore a rispondere della sua esecuzione nei confronti del subappaltante, a sua volta responsabile verso il committente.
In tal senso, muove anche l’ultima novella, il c.d. decreto semplificazioni bis (d.l. 77/2021) che ha oramai previsto anche una responsabilità solidale del subappaltatore e dell'appaltatore verso il committente, “segno di una tendenza a potenziare ulteriormente le garanzie offerte con il subappalto”.
In conclusione, dunque, secondo la Corte Costituzionale, è del tutto legittimo il divieto di ricorso all’avvalimento e non del subappalto proprio perché quest’ultimo garantisce che l'operatore che esegue i lavori è dotato in proprio di una qualificazione specialistica, e questo di per sé assicura una effettiva e adeguata tutela ai beni culturali. Al contrario, infatti, chiosa il Collegio, proprio un eventuale divieto di subappalto potrebbe tradursi in una compressione del principio della concorrenza irragionevole, oltre che dell'autonomia privata, non priva di criticità, specie alla luce delle note pronunce della Corte di Giustizia.
Corte Cost., 11/04/2022, n. 91
Bando Tipo n. 1. L'ANAC aggiorna con clausola revisione prezzi per servizi e forniture
 Bando Tipo n. 1 aggiornato al 2022. L’ANAC ha aggiornato il Bando di gara Tipo n. 1 per l’affidamento dei contratti pubblici sopra soglia di servizi e forniture introducendo, tra le varie novità, le clausole di revisione dei prezzi.
Bando Tipo n. 1 aggiornato al 2022. L’ANAC ha aggiornato il Bando di gara Tipo n. 1 per l’affidamento dei contratti pubblici sopra soglia di servizi e forniture introducendo, tra le varie novità, le clausole di revisione dei prezzi.
Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 4/2022 (conv. con mod. in L. 25/2022), fino al 31.12.2023 è obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara iniziali della clausola revisione prezzi prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.
La previsione, quindi, ha reso obbligatorio l’inserimento nei bandi di gara della clausola di revisione dei prezzi, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative dall’emergenza sanitaria globale, nonché dalla guerra ucraina.
In ossequio alla nuova normativa, con Delibera n. 154 del 16.3.2022, l’ANAC ha aggiornato il Bando Tipo n. 1 inserendo, al punto 3.3, la clausola revisione prezzi. Vediamone il contenuto.
In primo luogo, nella clausola è richiesta l’indicazione delle modalità di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione. A tal fine, l’ANAC suggerisce la possibilità, ad esempio, di fare riferimento ai prezzi standard rilevati dall’ANAC (di cui all’art. 9, comma 7, del decreto legge 66/2014), agli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure alla differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
Può altresì essere indicata la variazione percentuale di riferimento che permette di accedere alla revisione. In tal senso, appare logico desumere che nel caso in cui venga indicata una soglia percentuale, questa debba sommarsi alla c.d. alea contrattuale.
Vengono altresì inserite alcune previsioni facoltative, come la possibilità, nei contratti di durata superiore all’anno, di prevedere l’aggiornamento dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale, oppure la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario o, ancora, di richiederla una sola volta per ciascuna annualità.
Nella nota illustrativa di accompagnamento al Bando Tipo si evidenzia altresì che la disciplina di maggior dettaglio della clausola può essere inserita nel capitolato speciale d’appalto. In particolare, secondo l’Autorità, nel capitolato speciale dovranno essere indicate le modalità per la richiesta della revisione in aumento o per la comunicazione, da parte del RUP, della revisione in diminuzione, i documenti probatori da presentare per comprovare l’aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche), i termini della richiesta, le modalità dell’istruttoria, le modalità di calcolo da seguire per l’applicazione della revisione e, in particolare, dovranno essere indicati gli importi ai quali la percentuale di variazione si applica.
In conclusione, ricordiamo che nonostante il Bando in questione sia riferito a procedure aperte telematiche per i contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, lo stesso costituisce un valido spunto anche per gli altri bandi e avvisi.
L’art. 29, comma 1, lett. a) infatti prevede che la clausola revisione prezzi si applichi a tutti i contratti pubblici e, dunque, sia per lavori che servizi e forniture, a prescindere dal loro importo, restando irrilevante la circostanza che si tratti di contratti sopra-soglia o sotto-soglia UE.
In ogni caso, l’art. 29, comma 1, lett. a), rinviando al secondo e al terzo periodo dell’art. 106, comma 1, lett. a), prevede che la clausola revisione prezzi debba essere chiara, precisa e inequivocabile, e non deve essere tale da alterare la natura generale del contratto. Tali clausole devono in ogni caso fissare la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
Una clausola, pertanto, generica, ambigua o la cui attivazione comporterebbe delle modifiche sostanziali del contratto potrebbe essere illegittima e comportare l’impugnazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito.
Delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022
Revisione prezzi: istanza inammissibile prima della stipulazione del contratto
 Il tema della revisione prezzi negli appalti pubblici sta entrando sempre più a far parte della vita quotidiana degli operatori che continuano a subire gli effetti degli aumenti dei costi dei materiali.
Il tema della revisione prezzi negli appalti pubblici sta entrando sempre più a far parte della vita quotidiana degli operatori che continuano a subire gli effetti degli aumenti dei costi dei materiali.
Come fronteggiare l’aumento dei costi dell’appalto che si verifica nelle more della stipula del contratto? Cosa è possibile fare se la revisione prezzi non è prevista dal contratto?
Una parziale risposta ai quesiti ci giunge da una recentissima sentenza del TAR Lombardia.
Partiamo dal caso. Nel giugno del 2018 un Comune bandiva una procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di igiene urbana. Alla gara partecipavano due concorrenti. La seconda classificata, gestore uscente del servizio, aveva impugnato l’esito della procedura in quanto l’aggiudicataria difettava dei requisiti morali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR, il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello proposto dall’impresa che, dunque, era divenuta aggiudicataria dell’appalto. Il Comune aveva così disposto l’avvio del servizio a partire dal 1 ottobre 2020 e, nelle more, la proroga del servizio in capo alla medesima impresa, quale gestore uscente.
Sennonché nell’agosto 2020, la ricorrente si trovava costretta a chiedere all’amministrazione appaltante la revisione dei prezzi offerti in gara, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, al fine di rimediare all’aumento dei costi di smaltimento, e alla parallela diminuzione degli introiti, intervenuto nel periodo intercorrente tra l’indizione della gara (giugno 2018) e la successiva aggiudicazione alla richiedente (agosto 2020).
Secondo la ricorrente, i costi di smaltimento dei rifiuti avevano subito un incremento medio di oltre il 40% sui valori precedenti. Si trattava, secondo la ricorrente, di circostanze imprevedibili alla data di formulazione dell’offerta e tali da sconvolgere il piano economico di esecuzione contrattuale, implicando a carico del gestore una perdita economica, con conseguente indebito arricchimento dell’amministrazione comunale. Di qui la necessità di riequilibrare le condizioni economiche del contratto.
L’amministrazione appaltante respingeva la richiesta e invitava la società a stipulare il contratto, comunicando che in difetto avrebbe revocato l’aggiudicazione.
Avverso la determinazione dell’amministrazione, l’impresa ha promosso ricorso al TAR.
Secondo la ricorrente, dunque il provvedimento di diniego di revisione prezzi sarebbe errato perché:
- ha ricondotto l’istanza di revisione alla fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 106 comma 1, d.lgs. 50/2016, ossia alla revisione prezzi, mentre la ricorrente l’aveva formulata ai sensi della lett. c) della stessa norma, allegando cioè un deterioramento delle condizioni economiche dell’appalto derivante da “circostanze impreviste e imprevedibili”, quali l’aumento dei costi di smaltimento e la parallela diminuzione degli introiti intervenuti nel periodo intercorrente tra l’indizione della gara e la successiva aggiudicazione alla richiedente.
- ha ritenuto che l’art. 106 comma 1 lett. c) sarebbe utilizzabile soltanto in presenza di un contratto in corso, e non in presenza di un contratto non ancora stipulato, vigendo in tale fase il principio della modificabilità dell’offerta a tutela della par condicio dei concorrenti. La ricorrente, invece, dopo l’esclusione dell’unica altra concorrente per difetto dei requisiti di partecipazione, era rimasta l’unica legittimata all’aggiudicazione, per cui non vi sarebbe stata alcuna esigenza di tutela della par condicio.
- il rigetto era stato motivato sulla scorta dell’art. 46 comma 2 del capitolato speciale, che escludeva espressamente la revisione prezzi dell’appalto in caso di aumento dei costi unitari relativi allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti. Secondo la ricorrente, invece, il divieto di revisione prezzi previsto dall’art. 46 sarebbe ricollegabile esclusivamente alla lett. a) dell’art. 106 comma 1, e non alla lett. c) della stessa norma, invocata dalla ricorrente, basata sul sopravvenire in corso d’opera di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della formulazione dell’offerta.
- secondo l’amministrazione, l’aumento dei costi di smaltimento sarebbe stato del tutto prevedibile in sede di offerta.
Il TAR, tuttavia, ha respinto il ricorso in relazione a tutti i profili dedotti.
Innanzitutto, il TAR ha ritenuto infondata la pretesa della parte ricorrente di inquadrare la propria domanda nella lett. c) dell’art. 106 comma 1 d.lgs. 50/2016, che non disciplina la revisione dei prezzi, bensì le varianti in corso d’opera. La domanda della ricorrente, infatti, era da inquadrarsi, secondo il Collegio, nell’ambito della revisione prezzi prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a).
Peraltro, secondo i giudici, anche a voler qualificare la richiesta della ricorrente nell’ambito della lett. c) dell’art. 106, non era stata in ogni caso provata la sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili, in quanto la ricorrente si era limitata a documentare un aumento del costo generale del servizio e del servizio di spazzamento, non anche dello smaltimento e del trasporto dei rifiuti. Secondo i giudici, poi, che un simile aumento dei costi non fosse un evento imprevisto e imprevedibile alla data di indizione della gara in esame sarebbe dimostrato proprio dallo stesso art. 46 comma 1 del capitolato speciale di gara, che escludeva la revisione dei costi unitari afferenti allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti a carico dell’impresa aggiudicataria.
Inquadrando la richiesta della ricorrente nella revisione prezzi prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a), i giudici hanno precisato che sebbene la norma rimetta alla discrezionalità della stazione appaltante l’inserimento o meno di clausole revisione prezzi nei documenti di gara, in assenza di una simile clausola, l’impresa è comunque tutelata per i casi di aumento sproporzionato dei costi dell’appalto, potendo attivare l’art. 1467 c.c., ossia la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Nel caso di specie, era espressamente esclusa la clausola di revisione prezzi che, in ogni caso non poteva essere formulata dall’impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto.
In tale fase, infatti, i giudici hanno escluso la possibilità di ricorrere ad un simile rimedio. L’istituto della revisione prezzi, infatti, presuppone, per sua stessa natura, la presenza di un contratto già in corso e che includa una clausola revisione prezzi. A prescindere dalla presenza di una clausola revisione prezzi, nella fase tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, come quella in esame, una volta cessata la vincolatività dell’offerta - che a norma dell’art. 32, comma 4 del Codice è tale per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione -, l’impresa aggiudicataria può legittimamente svincolarsi dal contratto e rifiutarne la sottoscrizione.
Sulla scorta di tali considerazioni i giudici, dunque, hanno rigettato interamente il ricorso, con conseguente condanna alle spese interamente a carico della ricorrente.
Analizzando tuttavia il testo della sentenza, fermo restando la peculiarità del servizio in questione, diverse erano le soluzioni a disposizione dell’impresa per ovviare alla situazione di rincaro dei costi verificatasi nelle more della stipula del contratto.
Preliminarmente, è necessario precisare che l’applicabilità dell’art. 106, ossia delle modifiche contrattuali, alla delicata fase che interviene tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto è ampiamente discussa in giurisprudenza. Vi sono infatti sentenze che ammettono l’attivazione delle soluzioni promosse dalla norma anche in questa delicata fase, purché le modifiche attengano ad aspetti meramente esecutivi.
In questa delicata fase, tuttavia, come sottolineato anche dal giudice, l’impresa avrebbe potuto svincolarsi dal contratto e non sottoscriverlo, posto che la sua offerta non era più vincolante e, dunque, non sarebbe incorsa in alcuna sanzione. Peraltro, il rifiuto dell’impresa di sottoscrivere il contratto avrebbe determinato la riedizione della gara, non essendoci altri partecipanti in graduatoria (l’altro operatore concorrente, infatti, era stato escluso a seguito della sentenza del Consiglio di Stato per carenza dei requisiti ex art. 80 del Codice), per cui la ricorrente avrebbe potuto partecipare alla nuova gara con prezzi aggiornati, garantendosi in ogni caso una proroga del servizio, essendo il gestore uscente.
In secondo luogo, ove l’impresa avesse voluto comunque conseguire il contratto, avrebbe potuto procedere alla sottoscrizione dello stesso con riserva, manifestando di non accettare l’eventuale revisione dei prezzi non idonea al ristoro o comunque clausole inerenti all’importo totale dell’affidamento. L’istituto delle riserve, se ben utilizzato, rappresenta l’unico strumento in grado di tenere indenne l’impresa contraente dalle conseguenze derivanti dal rincaro dei prezzi.
Ad ogni modo, dopo la sottoscrizione del contratto con riserva, è possibile procedere con un’istanza di adeguamento dei prezzi prima della consegna del cantiere, dialogando con l’amministrazione, oppure proporre alla committenza la stipula di un atto aggiuntivo che modifichi in parte l’importo del contratto.
A tal proposito ricordiamo che il comma 1 dell’art. 29 del decreto Sostegni-ter prevede che per i bandi o gli avvisi pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.
Da ultimo, poi, l’impresa avrebbe potuto istaurare delle trattative con l’Amministrazione basate sull’imprevedibilità del crescente aumento dei prezzi dovute anche alla straordinaria ed eccezionale situazione pandemica, evidentemente imprevedibile per gli atti di gara anteriori al 2020. Fondamentale, dunque, è analizzare le singole situazioni e argomentare bene le istanze che vengono presentate alle amministrazioni.
Si tratta evidentemente di mere riflessioni, la cui percorribilità deve sempre essere vagliata in relazione al caso di specie.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 10/03/2022, n. 239
Colonnine di ricarica auto elettriche nelle stazioni di servizio di carburante: i Comuni possono imporre l’obbligo di istallazione, ma non a tappeto
 La sfida della mobilità sostenibile passa anche per una progressiva diffusione dei veicoli elettrici e per la crescita di colonnine di ricarica auto elettriche. I Comuni possono imporre l’obbligo di istallazione nelle stazioni di servizio di carburante?
La sfida della mobilità sostenibile passa anche per una progressiva diffusione dei veicoli elettrici e per la crescita di colonnine di ricarica auto elettriche. I Comuni possono imporre l’obbligo di istallazione nelle stazioni di servizio di carburante?
Il Regolamento per la Qualità dell’Aria adottato dal Comune di Milano impone una diffusa e generalizzata installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.
Proprio tale aspetto è stato di recente affrontato dal TAR Lombardia che, con la sentenza n. 2857/2021 ha annullato il Regolamento nella parte in cui obbligava ogni stazione di servizio di carburante della zona a installare anche le colonnine di ricarica per auto elettriche.
Il Regolamento in questione, infatti, imponeva, nel caso di realizzazione di nuove stazioni di servizio di carburante e di ristrutturazione totale degli impianti esistenti, “di installare infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW”.
Per le stazioni di servizio di carburante già esistenti, invece, imponeva la dotazione di infrastrutture di ricarica per auto elettriche il cui progetto deve essere presentato entro il 1 gennaio 2022, e da realizzarsi entro 12 mesi dalla presentazione, in linea con le specifiche contenute nel Disciplinare per le strutture di ricarica per auto elettriche del Comune di Milano.
Alcuni titolari di stazioni di servizio di carburante nel territorio del Comune di Milano e le associazioni di categoria hanno impugnato il Regolamento, censurando l’erroneità e la sproporzione delle relative previsioni ritenute troppo gravose sia in termini economici che con riferimento ai tempi per ottemperare all’obbligo, oltre che essere errate perché non tengono conto delle effettive dimensioni del mercato nazionale dei veicoli elettrici, essendo peraltro indimostrato l’impatto di tale misura sulla riduzione delle emissioni.
Accanto a ciò, hanno poi lamentato la violazione della fase di consultazione con gli stakeholders e le associazioni di categoria del progetto di piano, che sarebbe stata omessa dal Comune nella fase antecedente la pubblicazione, oltre ad una più generale incompetenza del Comune nell’adozione di imposizioni come quelle in esame.
Prima di affrontare le censure promosse, il TAR ricostruisce il campo genetico del Regolamento.
La normativa impugnata, infatti, si colloca nel più ampio contesto dell’intervento sistematico di cui al Piano Aria e Clima (PAC) del Comune di Milano (delibera n. 79 del 21.12.2020), che mira ad incidere su una serie di fattori ben individuati ritenuti responsabili del persistente superamento dei limiti massimi di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Lo scopo di tali atti, riconosciuto anche dai giudici, è quello di ottemperare ai vincoli nazionali e sovranazionali, migliorando l’ambiente cittadino e contrastando il cd. “inquinamento atmosferico di prossimità”, profondamente incidente sulla vivibilità del territorio da parte dei residenti.
Tra i mezzi individuati dal Comune di Milano per far fronte alla problematica vi sono una serie di misure volte a favorire il cd. “passaggio all’elettrico”, incidendo così sull’inquinamento generato dal traffico veicolare.
Possono i comuni imporre l’obbligo di installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche?
Passando poi all’analisi delle singole censure, il TAR ha in primo luogo riconosciuto la possibilità per il Comune di poter prescrivere degli oneri come quelli in esame. Più precisamente, l’art. 50, comma 7-ter del TUEL, modificato nel 2017, prevede che i comuni possono adottare regolamenti per fronteggiare a “situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”, non solo in situazioni di urgente necessità di intervento, ma anche nel caso in cui le problematiche necessitino “una gestione “strutturale” di lungo periodo”.
Alla base dell’esercizio di tale potere regolamentare, secondo i giudici, deve comunque esserci la necessità di gestire una situazione di disagio, di degrado o di scarsa vivibilità di rilievo locale, correlata al territorio di riferimento ed alla popolazione ivi stabilita.
Il Regolamento adottato dal Comune di Milano, dunque, si colloca nell’ambito di una serie di interventi volti a contenere l’inquinamento ambientale del territorio del comune, segnalato anche da alcune procedure di infrazione europea, e per cui le misure temporanee adottate sino ad ora con mere ordinanze sindacali non si sono rivelate sufficienti.
Tale situazione, in definitiva, ad avviso del Collegio, è riconducibile ad una situazione di degrado ambientale di cui all’art. 50, commi 5 e 7-ter d.lgs. 267/2000, per cui il Comune può, o meglio, deve intervenire.
È con riferimento al contenuto del Regolamento in esame che i giudici hanno invece accolto il ricorso.
Secondo il TAR, il Comune di Milano avrebbe imposto “un obbligo generalizzato, gravante su tutti i gestori di impianti di distribuzione ed a prescindere da qualsivoglia altro elemento oggettivo di selezione (ubicazione, dimensioni, volume di carburante erogato, superamento limiti normativi di inquinanti)”.
Rispetto alla normativa regionale, infatti, il Regolamento comunale avrebbe esteso ingiustificatamente il novero di soggetti tenuto all’istallazione delle colonnine di ricarica elettrica, con il risultato di “far ricadere sulla sola categoria dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti ed a prescindere dalla capacità economica del singolo, gran parte degli oneri (non solo economici, ma anche amministrativi e progettuali), della sostanziale transizione all’elettrico, sul piano infrastrutturale, del Comune di Milano”.
Di interesse sono senza dubbio le considerazioni che il TAR svolge in merito al fenomeno delle auto elettriche e dei relativi dispositivi di ricarica, che potrebbero trovare spazio anche in vicende analoghe.
Secondo i Giudici, infatti, le esigenze effettive dell’utenza non sono ancora univocamente rivolte verso il mercato dei veicoli elettrici: sebbene infatti, “la diffusione delle auto elettriche – a Milano come a livello nazionale - stia progressivamente aumentando e sia altresì innegabile che “il fenomeno della mobilità elettrica […] sia in crescita e che i numeri attuali siano destinati ad aumentare decisamente nel giro di pochi anni” è altresì non revocabile in dubbio che i veicoli elettrici rappresentano ancora una piccola parte del circolante”.
Nonostante il TAR riconosca come l’incremento numerico delle colonnine di ricarica per auto elettriche costituisca, per il futuro, “il passaggio obbligato” per incentivare l’abbandono dei veicoli inquinanti, ritiene comunque l’azione posta in essere dal Comune di Milano non condivisibile, perché priva di gradualità nell’adozione di obblighi, nonché priva di un adeguato supporto istruttorio e motivazionale.
In definitiva, il TAR suggerisce che per l’istallazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche si debba tener conto della loro ubicazione, quantità e distribuzione sul territorio, oltre ad essere valutata con riferimento a diversi fattori, come ad esempio la densità abitativa e/o veicolare, la tipologia di strada, le esigenze di circolazione e, dunque, in definitiva, avuto conto delle effettive esigenze della popolazione.
(TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21.12.2021, n. 2857)
Appalti pubblici: mancata stipula del contratto, sì al risarcimento del danno in favore della PA.
 Negli ultimi tempi, a fronte dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione che ha colpito anche il settore degli appalti pubblici, sempre più frequentemente molti operatori preferiscono non procedere alla stipula perché il contratto risulta essere non più remunerativo rispetto all’offerta che tempo addietro è stata presentata.
Negli ultimi tempi, a fronte dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione che ha colpito anche il settore degli appalti pubblici, sempre più frequentemente molti operatori preferiscono non procedere alla stipula perché il contratto risulta essere non più remunerativo rispetto all’offerta che tempo addietro è stata presentata.
Se siete tra quegli operatori che, al fine di evitare di subire delle perdite, stanno pensando di non stipulare il contratto per il quale sono risultati aggiudicatari, è bene fermarsi perché le conseguenze di una simile azione potrebbero essere particolarmente gravi.
Così facendo, infatti, in taluni casi il concorrente si espone non solo all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’ANAC (come accaduto nel caso finito innanzi al TAR Milano), ma anche all’azione di risarcimento danni avanzata dall’amministrazione.
Su quest’ultimo aspetto si è soffermato di recente il Consiglio di Stato nella sentenza del 27.10.2021.
Il caso vede protagonista una stazione appaltante che aveva proceduto all'annullamento dell'aggiudicazione del concorrente che non aveva completato la consegna della documentazione amministrativa necessaria per procedere alla stipula del contratto. A tale provvedimento faceva seguito l'aggiudicazione a favore del secondo classificato.
A fronte della mancata stipula, la SA proponeva azione per il risarcimento dei danni subiti.
I giudici di primo grado avevano ritenuto l’aggiudicatario colpevole del mancato rispetto del termine essenziale per la stipula del contratto. Il TAR Toscana (Sez. I, 1.6.2020, n. 664) aveva così riconosciuto come legittimo l’operato della stazione appaltante che aveva proceduto ad aggiudicare il contratto alla seconda classificata e a richiedere il risarcimento del danno, pur senza aver proceduto all’escussione della cauzione provvisoria.
In particolare, il giudice di primo grado aveva condannato la società a risarcire la stazione appaltante per una somma complessiva pari a euro 71.820,00, maggiorata di rivalutazione dal giorno dell’annullamento dell’aggiudicazione (avvenuta nel 2015) sino al giorno di deposito della sentenza e interessi legali.
Per la quantificazione del danno emergente, i giudici hanno considerato la circostanza che la stazione appaltante aveva dovuto aggiudicare la gara al secondo classificato, e quindi a un prezzo maggiore di quello formulato dall'aggiudicatario originario. Il danno è stato quantificato considerando la differenza tra l'offerta del primo classificato e quella del secondo classificato. Oltre a ciò, i giudici hanno altresì considerato il danno derivante dal minor contenuto tecnico della prestazione offerta dal secondo classificato, da liquidarsi in via equitativa con una maggiorazione del 40% dell'importo riconosciuto a titolo di danno emergente.
In sede di appello, la società appellante ha contestato la definizione sia del danno emergente, in quanto i costi della gara non sarebbero stati sopportati inutilmente dalla stazione appaltante, che ha comunque aggiudicato il contratto alla seconda classificata, sia del lucro cessante, in quanto la gara si è comunque conclusa con esito soddisfacente per l'ente appaltante, che non ha avuto necessità di bandire una nuova gara.
Il Consiglio di Stato ha respinto i motivi di appello e ha confermato la sentenza di primo grado.
Nell'articolata argomentazione, i giudici hanno ribadito che, in caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, la stazione appaltante può agire in giudizio per il risarcimento del danno eccedente l'importo della cauzione provvisoria.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la cauzione provvisoria o la garanzia fideiussoria si configura come caparra confirmatoria e non come clausola penale, per cui la sua escussione non esclude il diritto al risarcimento del maggior danno.
Quanto alla concreta quantificazione del danno, il Consiglio di Stato opera una distinzione a seconda che la relativa responsabilità sia imputabile all'ente appaltante o all'aggiudicatario.
Nel caso in cui la responsabilità per la mancata stipula derivi da un comportamento dell’amministrazione – riconducibile a un'ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale - il risarcimento si fonda sull’interesse negativo, ravvisabile nelle spese inutilmente sopportate dall'aggiudicatario per la partecipazione alla gara e nella perdita di occasioni di guadagno alternative.
Al contrario, nel caso in cui la responsabilità per la mancata stipula faccia capo all'aggiudicatario, non si può parlare di responsabilità precontrattuale e non è possibile, dunque, ravvisare una violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative precontrattuali, giacché il privato offerente, divenuto aggiudicatario, ha l’obbligo di stipulare il contratto.
È lo stesso Codice dei contratti pubblici a prevederlo: da un lato, infatti, dalla lettura dell’art. 93, comma 6, si evince che l’aggiudicatario rispondere per la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione” dovuta ad ogni fatto a lui riconducibile; dall’altro, l’art. 32, comma 6 specifica che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine a disposizione della stazione appaltante per addivenire alla stipula.
Nella fase che intercorre tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, l'ente appaltante gode di una tutela rafforzata rispetto all'aggiudicatario. In questa fase, sussiste l’interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura di affidamento per cui l’obbligo del privato di sottoscrivere il contratto non risiede nel contratto (non ancora stipulato), bensì nel fatto di essere aggiudicatario all’esito di una pubblica gara.
In sostanza, “quando l’obbligazione ex lege del privato di addivenire alla stipulazione del contratto rimanga inadempiuta per fatto dell’aggiudicatario, questi è soggetto all’escussione della garanzia prestata per la partecipazione alla gara e, se l’inadempimento sia a lui imputabile anche a titolo di colpa, è tenuto al risarcimento del danno in misura pari all’eccedenza rispetto alla già prestata cauzione”.
Di qui la risarcibilità non solo del c.d. interesse negativo, ma anche dell’interesse c.d. positivo dell’amministrazione, correlato alla già intervenuta individuazione del futuro contraente e la conferma delle voci di danno considerate dalla sentenza di primo grado.
In definitiva, il danno risarcibile è pari al pregiudizio sofferto dalla stazione appaltante per il maggior prezzo di aggiudicazione, a seguito di nuova gara (cui si aggiunge il rimborso delle spese di indizione di tale nuova gara) ovvero a seguito dello scorrimento della graduatoria. Poiché quest’ultimo comporta l’aggiudicazione al concorrente che segue l’aggiudicatario decaduto, alle condizioni dallo stesso proposte, il danno risarcibile è commisurabile non solo ai maggiori esborsi sopportati dalla stazione appaltante, ma anche al pregiudizio per l’eventuale inferiore qualità della prestazione.
Ad ogni azione, dunque, può corrisponderne una reazione uguale e contraria. Massima cautela deve essere apprestata alle scelte che vengono compiute dall’operatore tra l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, specie quando simili comportamenti si trasformano in fonte di responsabilità per l’operatore.
Cons. St., Sez. V, 27.10.2021, n. 7217
L’accesso all’offerta tecnica: la CGUE impone di motivare il diniego delle stazioni appaltanti
 Premessa
Premessa
L’accesso agli atti della procedura di gara e, segnatamente, alle offerte tecniche dei candidati, costituisce un aspetto fondamentale per comprendere e valutare la percorribilità di un ricorso avverso l’aggiudicazione.
Nel nostro ordinamento, l’art. 53, comma 5 del d.lgs. 50/2016 esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione delle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. Il successivo comma 6, invece, ammette l’accesso c.d. difensivo a tali informazioni, consentendo al concorrente, ai soli fini della difesa in giudizio, di prendere visione dei suddetti atti.
Il problema che spesso si pone con riferimento all’accesso attiene non solo all’opposizione che la società controinteressata – la cui offerta è soggetta a richiesta di visione – propone al fine di inibire l’accesso alla propria offerta, ma anche, e soprattutto, alla prassi delle stazioni appaltanti che tendono spesso a recepire acriticamente la suddetta dichiarazione, con il risultato di inibire qualsiasi tipo di conoscenza dell’altrui offerta e, dunque, la sua conoscibilità ai fini della presentazione di un ricorso.
Non mancano peraltro casi in cui le amministrazioni negano l’accesso sulla base dell’irrilevanza della documentazione ai fini del ricorso che l’interessato ha intenzione di proporre.
Nei fatti, il risultato di un simile modus operandi mina la posizione degli offerenti, che restano tutelati solo parzialmente, perché finiscono per disporre di una quantità minore di informazioni rispetto a quelle che potrebbero essere necessarie per agire a difesa dei propri interessi.
Ne deriva che la tutela effettiva della posizione degli operatori che hanno partecipato alla gara, ma che non sono risultati aggiudicatari rimane vincolata ad una decisione giudiziale sull’ostensione della documentazione tecnica che, se negativa, mina di per sé le chance di accoglimento del ricorso proposto contro l’aggiudicazione.
Una simile prassi è stata già correttamente stigmatizzata in alcune sentenze nazionali, nelle quali i giudici hanno avuto modo di precisare che le dichiarazioni presentate dalla controinteressata devono essere valutate dalla stazione appaltante, la quale dovrà rilevare la pertinenza e la validità delle ragioni prospettate a sostegno del diniego.
A rimarcarne l’irragionevolezza è intervenuta altresì una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Il caso
La questione oggetto di giudizio origina da una gara per l’affidamento di servizi di raccolta dei rifiuti urbani in un comune della Lituania.
La seconda graduata aveva richiesto alla stazione appaltante l’accesso all’offerta proposta dal raggruppamento risultato primo in graduatoria, ricevendo solo le informazioni dell’offerta non riservate.
A seguito del rigetto da parte del Comune della contestazione mossa avverso l’aggiudicazione, ritenuta dall’ente lacunosa e insufficiente, la società aveva promosso un giudizio innanzi al tribunale lituano per ottenere l’accesso all’offerta tecnica del raggruppamento, sostenendo l’esigenza di prendere visione della stessa ai fini della proposizione del giudizio avverso l’aggiudicazione.
Nel corso del giudizio di primo grado, l’amministrazione aveva affermato che il raggruppamento aggiudicatario aveva qualificato gran parte delle informazioni trasmesse come riservate ed aventi valore commerciale, precisando che la loro divulgazione ai concorrenti avrebbe potuto recargli pregiudizio. Il giudice aveva accolto la tesi dell’amministrazione, qualificando la documentazione richiesta come riservata e, dunque, non divulgabile, negando così l’accesso a tutta la documentazione richiesta dalla società ricorrente.
In sede di appello, invece, il giudice ha annullato sia il diniego d’accesso sostenuto dall’Amministrazione che la graduatoria finale, ordinando di procedere ad una nuova valutazione delle offerte.
Sulla base dell’appello promosso dal Comune, il giudice di Cassazione lituano ha formulato rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, chiedendo, in sostanza, alla Corte di chiarire quale sia il corretto bilanciamento tra la tutela delle informazioni riservate fornite da un offerente e l’effettività dei diritti della difesa degli altri offerenti.
L’obbligo dell’amministrazione di proteggere le informazioni riservate e l’obbligo di motivazione del diniego
In premessa la Corte di Giustizia ricorda che, in base a quanto previsto dal diritto dell’Unione e dalle direttive in materia di appalti, al fine di non falsare la concorrenza tra le imprese, è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici non divulghino informazioni che gli operatori economici considerano riservate, compresi i segreti tecnici o commerciali.
In linea di principio, dunque, a seguito di una richiesta di accesso alle informazioni riservate contenute nell’offerta dell’operatore aggiudicatario, l’amministrazione aggiudicatrice non deve divulgare tali informazioni, potendo imporre legittimamente agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che sono state rese disponibili ai fini della procedura di appalto. La Corte spiega infatti che “poiché le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici sono fondate su un rapporto di fiducia tra gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici, questi ultimi devono poter comunicare a tali amministrazioni aggiudicatici qualsiasi informazione utile nell’ambito della procedura di aggiudicazione, senza temere che esse rivelino a terzi elementi di informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori”.
A fronte di ciò, l’amministrazione aggiudicatrice non può tuttavia essere vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse sono riservate. Tale operatore deve infatti dimostrare la natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone, dimostrando, ad esempio, che esse contengono segreti tecnici o commerciali, che il loro contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza o che la loro divulgazione potrebbe essergli pregiudizievole.
Nel caso in cui l’amministrazione rifiuti di comunicare le informazioni riservate di un operatore economico ad uno dei concorrenti, questa è tenuta a sua volta rispettare l’obbligo di motivazione.
È infatti la motivazione del diniego che permette, secondo la Corte, il giusto bilanciamento tra il divieto di divulgare le informazioni riservate comunicate da operatori economici, il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del diritto di difesa delle parti.
Tale bilanciamento, infatti, non può non tenere conto del fatto che, in mancanza di informazioni sufficienti che consentono di verificare se la decisione dell’amministrazione relativa all’aggiudicazione dell’appalto sia viziata da eventuali errori o illegittimità, un offerente non ha la possibilità, in sostanza, di intraprendere un ricorso efficace avverso tale decisione.
In ragione di ciò, dunque, l’amministrazione aggiudicatrice deve indicare chiaramente i motivi per i quali ritiene che le informazioni alle quali è chiesto l’accesso o, quanto meno, alcune di esse, siano riservate.
Oltre a ciò, l’amministrazione aggiudicatrice deve altresì comunicare in una “forma neutra”, tale da preservare la natura riservata dei dati, il contenuto essenziale delle informazioni che sono state ritenute riservate all’offerente che li richiede e, più in particolare, il contenuto dei dati concernenti gli aspetti determinanti della sua decisione e dell’offerta selezionata. A tal fine, ad esempio, un’amministrazione può chiedere all’operatore la cui offerta è stata selezionata di fornirle una versione non riservata dei documenti contenenti informazioni riservate che può essere trasmessa agli altri offerenti che ne fanno richiesta.
Sottolinea la Corte che “l’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di proteggere le informazioni considerate riservate dell’operatore economico al quale è stato aggiudicato l’appalto pubblico non deve essere interpretato talmente estensivamente da privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza e da privare di effetto utile l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665 che enuncia, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di prevedere ricorsi efficaci. A tal fine, l’amministrazione aggiudicatrice può, in particolare e purché il diritto nazionale al quale è soggetta non vi si opponga, comunicare in forma sintetica taluni aspetti di una candidatura o di un’offerta nonché le loro caratteristiche tecniche, di modo che le informazioni riservate non possano essere identificate”.
Chiarisce poi la Corte che nell’ambito di un ricorso relativo ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al complesso delle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione fornite dai vari concorrenti.
Le amministrazioni, infatti, hanno l’obbligo di fornire all’offerente le informazioni sufficienti a salvaguardare il diritto a un ricorso efficace, tutelando comunque il diritto degli altri operatori alla tutela delle informazioni riservate e dei loro segreti commerciali.
In questo contesto, il ruolo del giudice nazionale è quello di verificare, tenendo conto sia della necessità di salvaguardare una concorrenza leale sia della necessità di tutelare le informazioni realmente riservate e in particolare i segreti commerciali dei partecipanti alla gara d’appalto, che l’amministrazione aggiudicatrice abbia correttamente ritenuto che le informazioni che ha rifiutato di comunicare siano riservate. A tal fine, il giudice nazionale deve procedere ad esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, prendendo visione delle informazioni riservate e dei i segreti commerciali. Alla luce di ciò il giudice deve valutare l’adeguatezza della motivazione: a seguito dell’istruttoria condotta, ove questa risulti insufficiente, deve annullare la decisione di rifiuto e, dunque, permettere l’ostensione degli atti al richiedente.
L’auspicio
La pronuncia esaminata segna un passo importante per tutti gli operatori economici ma anche per le stazioni appaltanti. L’onere di motivazione che viene imposto alle amministrazioni, infatti, permette agli operatori di conoscere, seppur in una “forma neutra” e sintetica, il contenuto delle offerte degli altri concorrenti e dell’aggiudicatario, anche ove queste siano riservate, potendo così ponderare in maniera più razionale la proposizione di un ricorso. Le stesse stazioni appaltanti, poi, non soggiacciono più alle opposizioni avanzate dalle società controinteressata, potendo (rectius: dovendo) assumere esse stesse una decisione circa il grado di riservatezza delle informazioni rese, garantendo, anche in questa fase, la par conditio tra tutti gli offerenti.
Corte di Giustizia UE, sent. 7/09/2021, in C-927/19
DGUE, certificati e integrazione poco chiara: il punto sulle recenti decisioni in tema di soccorso istruttorio.

Nell’ambito degli appalti pubblici, molto spesso stazioni appaltanti e operatori economici si confrontano con il soccorso istruttorio, in particolare per ciò che concerne DGUE, certificati e integrazione poco chiara.
La virtuosità di questo istituto, che abbiamo valorizzato in varie occasioni, nasconde delle insidie: cosa può essere integrato o regolarizzato mediante il soccorso istruttorio? Capirlo non è sempre facile.
Alcune recenti pronunce ci permettono di fare il punto in merito ad alcune tematiche che di frequente operatori economici e stazioni appaltanti ci sottopongono.
Le carenze del DGUE
Come noto, il DGUE è un'autodichiarazione dell'impresa circa la propria situazione finanziaria, le proprie capacità e la propria idoneità rispetto ad una procedura di appalto pubblico. È dunque un documento fondamentale per la partecipazione ad una gara.
In generale, l’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, prevede che possa essere attivato il soccorso istruttorio per i casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
Nella prassi, in sede di compilazione del DGUE, spesso gli operatori tendono a produrre dichiarazioni “standard” di contenuto minimo da integrare poi in sede di soccorso istruttorio.
Tale pratica è stigmatizzata sia dalla giurisprudenza che dall’ANAC come una violazione dei principi di par conditio tra i concorrenti.
In un recente caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità, un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) veniva escluso da una gara per aver omesso di dichiarare all’interno del DGUE, l’elenco dei servizi prestati nell’ultimo decennio per tutte le categorie richieste, e la mandataria non risultava in possesso, da sola, dei requisiti tecnico-professionali relativamente al alcune categorie. La mandataria inoltre non aveva specificato che i servizi dichiarati erano da considerare servizi “di punta”.
Secondo l’RTP, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio al fine di consentire di regolarizzare la domanda di partecipazione e acquisire le dichiarazioni mancanti, invece di procedere direttamente a disporre l’esclusione per carenza dei requisiti.
La stazione appaltante, invece, aveva proceduto all’esclusione poiché l’RTP aveva prodotto una domanda di partecipazione incompleta a tal punto da non poter procedere alla verifica dei requisiti. In particolare, la stazione appaltante aveva sostenuto che il concorrente aveva tenuto una condotta approssimativa nel redigere il DGUE: la concorrente aveva infatti omesso di dichiarare i requisiti richiesti, producendo invece alcune dichiarazioni non richieste.
Nel richiamare la giurisprudenza sul tema, l’ANAC ha ricordato che non basta una mera dichiarazione generica circa la disponibilità dei requisiti, ma occorre una dichiarazione, resa attraverso il DGUE, che sia esatta e specifica nell’indicare le esperienze idonee ad integrare i requisiti richiesti. L’invito all’integrazione di una documentazione del tutto incompleta e insufficiente a testimoniare i requisiti, infatti, costituisce una rimessione in termini per la presentazione delle offerte che non può essere consentita. Sicché, l’errore commesso dal concorrente, ossia la mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta, può legittimare un intervento correttivo purché la rettifica possa essere effettuata con ragionevole certezza, e comunque senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente.
Nel caso in esame, l’ANAC ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante. L’Autorità ha infatti escluso l’utilizzo del soccorso istruttorio a fronte di una radicale carenza del DGUE e delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara: secondo l’Autorità, “la totale mancanza di indicazione, all’interno del DGUE, dei servizi prestati nel decennio, integranti un requisito speciale di partecipazione espressamente richiesto dal bando, non può essere considerata mero errore materiale o refuso, bensì un errore del quale il concorrente deve sopportare le conseguenze per il generale principio di autoresponsabilità”.
La produzione dei certificati
Nella realtà quotidiana di chi lavora nel mondo degli appalti pubblici, può accadere di dover presentare in sede di gara dei certificati ai quali la Commissione attribuisce i relativi punteggi. Solitamente la lex specialis di gara impone ai concorrenti di allegare i certificati in copia conforme.
Cosa accade se l’operatore economico presenta i certificati in copia semplice?
In questo caso la risposta ci viene fornita dal TAR Marche.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici, la stazione appaltante non aveva attribuito il punteggio per due sub-criteri del disciplinare, poiché i relativi certificati non erano stati allegati in copia conforme, bensì in copia semplice.
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttivo e richiedere la presentazione dei certificati in copia conforme, attribuendo il relativo punteggio.
I giudici hanno ritenuto che la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente “costituisce una irregolarità relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la lex specialis richieda la produzione dell’originale o della copia autentica”.
Sebbene nel disciplinare era previsto che ai fini dell’attribuzione del punteggio il requisito doveva comprovato dai relativi certificati in copia conforme all’originale, i giudici hanno ritenuto che la finalità di tale clausola fosse quella di accertare il possesso sostanziale del requisito medesimo, sicché i certificati erano esclusivamente finalizzati alla sua dimostrazione.
Secondo i giudici, dunque, nel caso in esame, non veniva contestata la mancanza del requisito richiesto, bensì del “mezzo descrittivo”, per cui il soccorso istruttorio sarebbe stato possibile, trattandosi di una omissione che attiene a profili formali dell’offerta tecnica e non sostanziali. Di conseguenza, i giudici non hanno ravvisato alcun ostacolo all’attivazione del soccorso istruttorio per l’acquisizione dei certificati nella forma richiesta dalla legge di gara.
Richiesta di chiarimenti dopo il soccorso istruttorio
Infine, una delle questioni che anima il dibattito tra gli operatori del settore, attiene alla possibilità di attivare una sorta di doppio soccorso istruttorio: in altre parole, qualora la documentazione prodotta a seguito del primo soccorso non sia sufficientemente chiara, la stazione appaltante può richiedere ulteriori chiarimenti?
Una risposta a questo quesito ci arriva direttamente dall’ANAC.
L’Autorità ha precisato che la Stazione appaltante che non sia soddisfatta dei chiarimenti forniti dall’operatore economico in sede di soccorso istruttorio non può escluderlo, ma deve replicare chiedendo ulteriori delucidazioni e chiarimenti.
La risposta dell’ANAC è stata fornita nell’ambito di un parere di precontenzioso richiesto da un'impresa capogruppo di un RTI che è stata esclusa dall’amministrazione poiché aveva errato nell'indicare la cifra della fideiussione nel testo della polizza. In sede di verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante aveva infatti riscontrato la discordanza tra l’importo indicato, l’importo rettificato in appendice e quello ripetuto della stessa pagina dell’appendice e aveva pertanto attivato il soccorso istruttorio.
In sede di soccorso istruttorio, la Società aveva ribadito che “con la presente appendice che forma parte integrante della polizza suindicata si precisa quanto segue: a differenza di quanto erroneamente indicato in polizza la somma garantita è di euro 72.000,00” salvo poi indicare nuovamente nello stesso documento che la “attuale somma assicurata è pari a euro 52.000,00”.
L’Amministrazione ha escluso l’impresa perché ha ritenuto l’integrazione fornita non sufficiente a chiarire il dubbio, perdurando l’incertezza in merito all’importo assicurato.
Secondo l’ANAC, invece, la stazione appaltante non soddisfatta dai chiarimenti ricevuti, avrebbe dovuto “dar luogo ad un'interlocuzione con l'operatore economico finalizzata ad ulteriore precisazione e chiarificazione dei dubbi emersi dall'analisi della documentazione prodotta, giudicata non esaustiva o pienamente soddisfacente”.
(ANAC, 8/9/2021, Delibera n. 605)
(TAR Marche, Sez. I, 9/7/2021, n. 565)
(ANAC, 8/9/2021, Delibera n. 609)
Autorizzazione paesaggistica e silenzio-assenso tra P.A. ex art. 17-bis L. 241/90
 La possibile applicazione dell’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis della l. 241/1990 al procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 anima da sempre un grande dibattito giurisprudenziale.
La possibile applicazione dell’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis della l. 241/1990 al procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 anima da sempre un grande dibattito giurisprudenziale.
1.La disciplina del d.lgs. 42/2004
In base all’art. 146 del d.lgs. 42/2004, infatti, l’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata nell’ambito di un procedimento che vede coinvolte sia la Regione (o l’ente locale sub-delegato), sia il Ministero dei beni culturali e del paesaggio - oggi ribattezzato Ministero della Cultura, "MiC" - (con la competente Soprintendenza).
Più precisamente, i commi 7, 8 e 9 del citato art. 146 prevedono che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, effettuati gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, trasmette alla Soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato, una relazione tecnica illustrativa e una proposta di provvedimento. A seguito di ciò, la Soprintendenza rende il proprio parere vincolante entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. In caso di parere negativo, la Soprintenda comunica agli interessati il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Una volta ricevuto il parere, l’Amministrazione procedente è tenuta a provvedere in conformità entro venti giorni dalla ricezione.
2. Il silenzio assenso tra P.A. ex art. 17-bis L. 241/90.
L’art. 17-bis l. 241/90, invece, prevede che allorquando una pubblica amministrazione rivolga ad altra pubblica amministrazione richiesta di “assensi, concerti o nulla osta”, l’inutile decorso del termine di 30 giorni (ovvero il maggior termine ove previsto da norme speciali, come il caso dell’art. 146 d.lgs. 42/2004) determina la formazione di un silenzio-assenso.
Il dibattito giurisprudenziale ed il contrasto tra gli orientamenti dei TAR e quello del Consiglio di Stato destinato, almeno per ora, a non arrestarsi, ruota intorno alla possibilità di applicare il silenzio-assenso tra amministrazioni al caso in cui la Soprintendenza non renda il parere vincolante richiesto, ovvero lo renda oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 d.lgs. 42/2004.
Così, ad esempio, nella sentenza n. 2640/2021 il Consiglio di Stato ha chiarito che il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 17-bis non si applica alla fase istruttoria del procedimento amministrativo “che rimane regolata dalla pertinente disciplina positiva, influendo soltanto sulla fase decisoria, attraverso la formazione di un atto di assenso per silentium con la conseguenza che l’amministrazione procedente è, comunque, tenuta a condurre un’istruttoria completa e, all’esito, ad elaborare uno schema di provvedimento da sottoporre all’assenso dell’amministrazione co-decidente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 4559)”. Secondo il Consiglio di Stato, dunque, nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il mancato parere della Soprintendenza non rientra tra le ipotesi di cui all’art. 17-bis, in quanto questo istituto è applicabile esclusivamente “nei rapporti fra Amministrazione “procedente” e quelle tenute a rilasciare pareri, concerti e nulla osta, e non invece a quelle ipotesi in cui il parere è frutto di un “rapporto “interno” fra le amministrazioni chiamate a co-gestire l’istruttoria e la decisione in ordine al rilascio di tali assensi”.
In sostanza, secondo questo orientamento, a seguito del decorso del termine per l’espressione del parere vincolante conforme a quello della Regione, l’organo statale, ossia la Soprintendenza, conserva comunque la possibilità di rendere un parere; tuttavia il parere in tal modo espresso perderà il proprio valore vincolante e dovrà essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo.
3. La decisione del TAR Campania
Una recente sentenza del TAR Campania, Salerno n. 1542/2021, invece, segna un ulteriore punto a favore dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 17bis l. 241/90: il Collegio, pur dando atto della sussistenza di un orientamento contrastante, sposa la tesi dell’operatività dell’art. 17-bis l. 241/90 al parere di cui all’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004.
A tal fine, la decisione richiama quanto espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 1640/2016 che aveva avuto modo di esprimersi proprio in merito ai problemi applicativi dell'articolo 17-bis così come introdotto dalla l. 124/2015.
In tale parere, infatti, il Consiglio di Stato aveva avuto modo di precisare che l’art. 17-bis l. 241/90 opera “in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione)”, sicché “il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo”.
In base a tali considerazioni, il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni tutti quei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza codecisoria e, soprattutto, ai pareri vincolati di competenza di altra amministrazione.
Orbene, in base a tali considerazioni, secondo il TAR Salerno, il procedimento ex art. 146 d.lgs. 42/2004 rientra tra le procedure pluristrutturate (o meglio, per usare le parole della giurisprudenza, “di cogestione attiva del vincolo paesaggistico”) per cui l’amministrazione procedente è tenuta ex lege ad acquisire l’assenso vincolante di un’altra amministrazione. In questi casi, poiché il legislatore ha qualificato in termini provvedimentali il parere in questione (in caso di parere negativo si applica l’art. 10-bis l. 241/1990), trova applicazione il meccanismo di silenzio-assenso tra le amministrazioni.
In tale tipo di procedimento, infatti, l’ente preposto alla tutela paesaggistica non ha un ruolo meramente formale o servente, poiché è la legge stessa a disporre che sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronunci la Regione; peraltro, sottolinea il TAR, la Regione è l’unica titolare del potere di decidere in via esclusiva sugli aspetti urbanistico-edilizi, e dunque è tenuta ad esprimersi direttamente sugli aspetti paesaggistici.
Oltre a ciò, il Collegio ha ricordato che a favore dell’applicabilità dell’art. 17-bis al parere della Soprintendenza milita l’art. 11, comma 9 del d.P.R. 31/2017 in tema di autorizzazione paesaggistica semplificata il cui testo prevede espressamente l’applicazione dell’art. 17-bis, nonché le stesse direttive e pareri del MiC.
In forza di tali considerazioni, il TAR non solo ha annullato il diniego della domanda di autorizzazione paesaggistica emanato dal Comune a seguito della formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della l. 241/90, ma ha fatto altresì applicazione del nuovo art. 2, comma 8-bis l. 241/1990, introdotto dal noto decreto Semplificazioni (l. 120/2020) dichiarando l’inefficacia del parere tardivo della Soprintendenza.