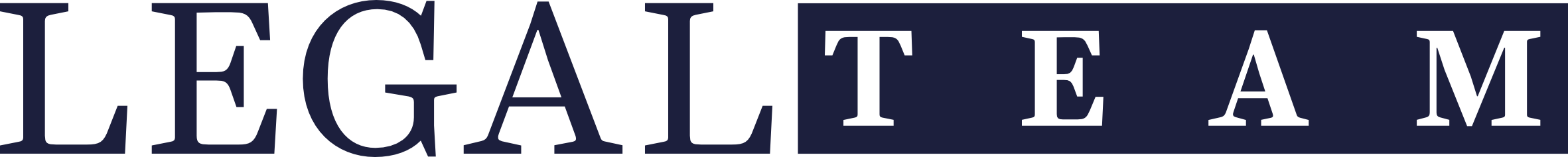La tutela del patrimonio paesaggistico-culturale non prevale automaticamente sulla tutela ambientale e sull’interesse ad utilizzare energie rinnovabili: la storica sentenza del Consiglio di Stato
 Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato si è interrogato sul corretto bilanciamento tra la tutela del patrimonio paesaggistico-culturale e la tutela ambientale, con particolare riguardo all’utilizzo di energie rinnovabili.
Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato si è interrogato sul corretto bilanciamento tra la tutela del patrimonio paesaggistico-culturale e la tutela ambientale, con particolare riguardo all’utilizzo di energie rinnovabili.
La motivazione dei giudici è degna di nota perché precisa che la tutela del patrimonio paesaggistico e culturale non può dirsi automaticamente prevalente su altri interessi di rango costituzionale, in particolare sulla tutela dell’ambiente e sull’interesse ad una transizione energetica ed ecologica verso fonti di energia rinnovabile.
IL FATTO
Una impresa aveva presentato alla Regione Molise due istanze di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 per la realizzazione di due pale eoliche.
Con riferimento al progetto della prima pala eolica, in sede di conferenza di servizi, la Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici regionale aveva espresso parere negativo alla relativa realizzazione dell’impianto, “a causa di interferenze visive della stessa con la presenza di beni culturali” quali un castello, il centro storico del paese, due boschi e talune croci votive situate nei pressi dell’area di intervento.
Ciononostante, in conferenza di servizi, la Regione, avendo rilevato che le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza avrebbero compromesso la fattibilità tecnica ed economica dell’opera (in quanto la pala, se ridotta di altezza come richiesto dalla Soprintendenza, sarebbe risultata improduttiva per assenza di vento), aveva rilasciato l’autorizzazione unica in favore dell’impresa.
Qualche tempo dopo il rilascio della predetta autorizzazione, la Soprintendenza aveva comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale (ex art. 13 del d.lgs. 42/2004) di un sistema di croci votive e viarie site lungo il crinale di confine fra le due località in cui sarebbero sorte le pale eoliche. Con decreto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise veniva così dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3, lett. a), e 13 del d.lgs. 42/2004, con conseguente assoggettamento a tutela indiretta delle aree limitrofe ai manufatti culturali.
Analoga situazione si era verificata nel procedimento di autorizzazione unica per la seconda pala eolica.
Dapprima, la Soprintendenza regionale aveva rilevato l’interferenza “visiva” dell’impianto e suggeriva una “riduzione significativa dell’altezza complessiva dell’impianto ovvero l’adozione di una tipologia ad asse verticale della pala”. Successivamente la Regione aveva rilasciato l’autorizzazione unica richiesta dalla società sulla base di un variante progettuale resasi necessaria per superare le criticità espresse Soprintendenza.
Sul dissenso espresso dalla Soprintendenza si era pronunciata anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nell’approvare definitivamente l’intervento, aveva rappresentato come “dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi ad area contermine e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di che trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti in conferenza di servizi e facendo proprie le relative motivazioni”.
Anche in tale seconda circostanza, la dichiarazione di interesse culturale del sistema delle croci votive decisa dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici finiva per inibire la realizzazione dell’impianto.
L’impresa richiedente aveva così impugnato i decreti della Direzione regionale che aveva dichiarato di interesse culturale le croci votive.
In sede di primo grado, il TAR Molise aveva accolto i ricorsi rilevando come i decreti con cui erano stati apposti i vincoli indiretti si sarebbero limitati ad affermare una rilevanza storico-artistica dei manufatti in questione senza esplicitare né gli elementi dai quali desumerne il valore culturale, né l’effettiva e qualificata rilevanza che i manufatti avrebbero concretamente assunto nella comunità di riferimento.
LA MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Avverso la sentenza del TAR Molise ha proposto appello il Ministero della Cultura, sostenendo che i decreti impugnati sarebbero assistiti da adeguata e congrua motivazione. Secondo il Ministero, peraltro, le valutazioni sottese alle dichiarazioni di interesse culturale sarebbero connotate da forte discrezionalità tecnica e, come tali, insindacabili dal giudice.
Avverso la sentenza hanno altresì promosso appello incidentale anche il Comune e la società ricorrente in primo grado, lamentando, in buona sostanza, l’incongruenza e l’irragionevolezza dell’apposizione del vincolo indiretto rispetto a dei manufatti visibili a pochi metri di distanza, considerando che la visione non sarebbe inficiata dall’eventuale realizzazione di altri manufatti a centinaia di metri di distanza.
Con sentenza del 23 settembre 2022 n. 8167, il Consiglio di Stato ha accolto entrambi gli appelli.
LA DISCREZIONALITÀ TECNICA DELL’INTERESSE CULTURALE
Con riferimento all’appello principale promosso dal Ministero, il Collegio ha in primo luogo precisato che “a differenza delle scelte politico-amministrative (cd. «discrezionalità amministrativa») – dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ragionevole ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme – le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (cd. «discrezionalità tecnica») vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro di attendibilità tecnico-scientifica”.
Di conseguenza, nei casi in cui il riferimento normativo che attribuisce il potere di decidere all’amministrazione non contiene il riferimento alle regole di giudizio che devono guidare la decisione da assumere, “il giudice non «deduce» ma «valuta» se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto”. Di conseguenza, il soggetto che mette in discussione la decisione dell’amministrazione deve contestarne l’attendibilità tecnico-scientifica.
Nei casi in cui l’attendibilità delle decisioni assunte sia incerta e vi siano posizioni divergenti, tutte plausibili, “il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato”.
Tale assunto, secondo il Collegio, non vale ad accordare all’amministrazione un “privilegio di insindacabilità” delle decisioni, ma rispecchia la volontà del legislatore di non disciplinare i conflitti di interessi che possono sorgere rispetto a certe posizioni e, dunque, la volontà del legislatore di disciplinare solo i modi e i procedimenti di soluzione di tali conflitti.
In virtù di tale ragionamento, dunque, l’appello proposto dal Ministero è stato ritenuto fondato.
Secondo il Consiglio, la dichiarazione di interesse culturale, pur dovendosi basare su di una solida e documentata motivazione, deve tenere conto delle considerazioni che si impongono caso per caso, ben potendo la situazione concreta richiedere la maggiore (o minore) considerazione di alcuni criteri a discapito di altri.
Nel caso di specie, il Consiglio ha rilevato che gli indicatori da utilizzare per effettuare la ricostruzione dell’interesse storico/culturale oggetto di tutela ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004 – di cui alla nota ministeriale n. 5085 del 3 marzo 2009 – devono ritenersi esemplificativi e non certo tassativi o cumulativi. Di conseguenza, mancando nel caso di specie alcuni degli elementi probatori richiesti dalla nota ministeriale n. 5085/2009 (e, in particolare, una folta bibliografia), era onere del Ministero condurre uno studio autonomo del bene culturale in questione.
Nella motivazione dei decreti impugnati, emergevano in modo chiaro le ragioni in base alle quali il sistema delle croci votive caratterizza storicamente l’ampio paesaggio naturale e agrario circostante.
Pertanto, conclude il Collegio, non è ravvisabile nel caso di specie alcun difetto di motivazione in merito all’interesse culturale del sistema di croci votive, non essendo stati addotti dalle controparti sufficienti elementi storici ed antropologici contrastanti con la decisione dell’Amministrazione.
LA TUTELA INDIRETTA DELL’INTERESSE CULTURALE
Anche l’appello incidentale promosso dal Comune e dalla società interessata alla costruzione dell’impianto è stato accolto dal Collegio, il quale ha ritenuto che i decreti con cui è stato dichiarato di interesse culturale il sistema di croci votive viarie risultavano carenti di motivazione rispetto all’assoggettamento a vincolo indiretto dell’area contermine al manufatto di interesse culturale.
I decreti impugnati infatti, imponevano: il divieto di trasformare, sia temporaneamente che permanentemente, l’aspetto esteriore dei luoghi ricompresi nell’ambito del vincolo indiretto; il divieto, nei medesimi luoghi, di apertura di cave, posa in opera di condotte per impianti industriali e civili, realizzazione di palificazioni; l’obbligo di mantenimento dell’uso agricolo attuale del suolo per i medesimi luoghi oggetto di vincolo indiretto.
Tali limitazioni erano state motivate dall’Amministrazione in ragione “dell’esigenza di evitare che siano alterate le condizioni di contesto ambientale e di decoro, nonché di prospettiva e visuale, delle croci votive e viarie sottoposte a tutela, oltre che di scongiurare rischi all’integrità di ciascuno dei manufatti”.
Per il Collegio giudicante una simile motivazione risulta inadeguata.
Secondo i giudici, infatti, le prescrizioni di tutela indiretta previste dall’art. 45 del d.lgs. 42/2004 hanno la funzione di completare la visione e la fruizione del bene principale gravato dal vincolo “diretto”. La norma, infatti, permette di imporre delle misure dirette a scongiurare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, che ne sia danneggiata la prospettiva, la luce o che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, permettendo così di vincolare anche l’area circostante.
Tuttavia, tali vincoli, “integrando un limite apposto al diritto di proprietà sulla base di apprezzamenti rimessi all’autorità amministrativa competente” devono essere adeguatamente valutati avuto riguardo a tutti gli interessi coinvolti. Segnatamente, in ragione del fatto che non risulta accordata una prevalenza assoluta alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale sugli altri interessi aventi comunque rango costituzionale.
Conseguentemente, “la primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell’ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione totalizzante come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto”.
Nel caso di specie, dunque, il Collegio ha ravvisato la violazione del principio di proporzionalità, ossia “il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all’interno di un quadro argomentativo razionale”, e il principio di integrazione delle tutele, che “costituisce la direttiva di metodo”.
Quanto al principio di proporzionalità, questo appare violato secondo il Collegio “non nella componente della idoneità (al raggiungimento dell’obiettivo prefissato) o della necessarietà (ravvisabile quando non sia disponibile nessun altro mezzo egualmente efficace, ma meno incidente nella sfera giuridica del destinatario), bensì della proporzionalità in senso stretto”.
Una misura limitativa adottata dai pubblici poteri non può mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell’interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile.
Dunque, precisano i giudici, paragonando l’obiettivo perseguito dalla Soprintendenza (la tutela delle croci votive) ed il mezzo utilizzato (lo svuotamento delle possibilità d’uso alternativo del territorio, specialmente ai fini della produzione di energia eolica) “appare evidente quanto sia sbilanciata la ponderazione effettuata”.
Ed infatti, “l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone”.
Ulteriormente, si legge in sentenza, la posizione “totalizzante” espressa dall’Amministrazione contrasta con l’indirizzo europeo e nazionale di cui al d.lgs. 387/2003 che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini della tutela dell’ambiente. L’art. 12 comma 7, d.lgs. 387/2003 prescrive infatti che l’ubicazione degli impianti eolici nelle zone agricole deve tenere conto “delle disposizioni in materia di sostegno agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.
Allo stesso tempo, la posizione assunta dall’Amministrazione nei decreti impugnati viola il principio di integrazione delle tutele (riconosciuto ex art. 3-quater del Codice dell’ambiente e dall’art. 11 TFUE), in virtù del quale le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Tale principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive, ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale: l’esigenza di tutelare il patrimonio culturale deve integrarsi con la necessità di preservare l’ambiente.
Il principio di integrazione assume così una veste procedimentale, anche in forza dell’art. 12 comma 10 del d.lgs. 387/2003, secondo cui le linee guida ministeriali che dettano le regole in fase di rilascio di autorizzazione unica per gli impianti eolici sono volte ad individuare il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio. Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per tali impianti, dunque, rappresenta la sede in cui devono avvenire le operazioni di comparazione, bilanciamento e gestione dei diversi interessi confliggenti.
Di qui la conclusione del Collegio, secondo cui “le prescrizioni di tutela indiretta apposte dall’Amministrazione dei beni culturali costituiscono un metodo, non solo incongruo (in quanto operata al di fuori della delicata operazione di valutazione e comparazione degli interessi), ma anche surrettizio – in tal senso è ravvisabile lo sviamento della funzione – per disapplicare gli esiti della conferenza di servizi cui aveva preso parte la stessa Soprintendenza … a danno dei soggetti che avevano già conseguito le autorizzazioni uniche da parte della Regione per la realizzazione degli impianti eolici”.
In accoglimento dell’appello incidentale, i giudici hanno confermato l’annullamento dei decreti impugnati relativamente alle prescrizioni di tutela indiretta, specificando che in sede di riedizione del potere, l’Amministrazione dovrà ricercare “non già il totale sacrificio dell’uso produttivo di energia pulita delle aree contigue alle croci votive, secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale”.
(Cons., St., Sez. VI, 23.9.2022, n. 8167)
Stato legittimo ex art. 9-bis, co. 1-bis DPR 380/01: la Corte costituzionale stoppa le "varianti regionali".
 All'indomani dell'entrata in vigore del decreto semplificazioni 2020 e, con esso, della introduzione della nozione di stato legittimo (art. 9-bis, co. 1-bis, D.P.R. 380/01), alcune Regioni si sono "lanciate" in "variazioni sul tema".
All'indomani dell'entrata in vigore del decreto semplificazioni 2020 e, con esso, della introduzione della nozione di stato legittimo (art. 9-bis, co. 1-bis, D.P.R. 380/01), alcune Regioni si sono "lanciate" in "variazioni sul tema".
Tra le prime Regioni ad essersi mosse in tal senso vi era stato il Veneto: tuttavia, con la sentenza della Corte costituzionale 21.10.2022 n. 217, scaturita dall'impugnativa del Governo, è stata dichiarata incostituzionale la scelta di tale Regione di allargare le maglie della nozione di stato legittimo.
Ricordiamo che la norma statale - il citato art. 9-bis, co. 1-bis del D.P.R. 380/01 - articola la definizione di stato legittimo su tre regole fondamentali:
- esso è costituito dalla "catena" dei titoli abilitanti, o sananti, il fabbricato/unità immobiliare;
- solo per i fabbricati edificati in epoca per la quale non vigeva l'obbligo di titolo abilitativo, è ammessa la prova tramite altra documentazione probante (in primis, il catastale di primo impianto);
- tale documentazione "alternativa" può essere adoperata anche in caso di irreperibilità del titolo abilitativo, di cui però vi sia ragionevole prova della esistenza.
La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di esaminare, più nel dettaglio, la disposizione.
I. La sentenza 217/2022 e l'illegittimità dello "stato legittimo" veneto.
Come detto, la Regione Veneto, con la L.R. 19/2021, aveva introdotto una versione allargata di "stato legittimo": in particolare, con l'art. 93-bis della L.R. 61/1985, era stato previsto due regole "speciali":
- per gli immobili ante 30.1.1977, oggetto di variazioni non essenziali, lo stato legittimo, nel caso in cui dette difformità siano state poste in essere da soggetti diversi dagli attuali proprietari, coincide con quanto risultante dal certificato di abilitabilità/agibilità, "fatta salva l’efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi";
- per gli immobili ante 67 in aree esterne ai centri abitati o alle zone di espansione, la legittimità "è attestata dall’assetto dell’edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l’eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente".
La norma è stata prontamente portata dal Governo all'attenzione della Consulta la quale ha - in modo netto - dichiarato la incostituzionalità dello "stato legittimo veneto" .
Infatti, la deadline del 1977 è ritenuta dalla Corte irragionevole, poiché già anteriormente alla L. 10/77 la disciplina statale imponeva l'obbligo di titolo edilizio, comminando sanzioni per interventi senza abilitazione:
"(...) la legge urbanistica n. 1150 del 1942, sia nel suo testo originario sia in quello innovato dalla legge n. 765 del 1967 – prevedeva che il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori (quest’ultimo a partire dalla disciplina introdotta nel 1967), nonché l’assuntore dei lavori fossero «responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione» (art. 31, terzo comma, della citata legge, che diviene comma 12 a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 765 del 1967). E a garanzia del rispetto di tale disciplina, il podestà, prima, e il sindaco, poi, avevano il compito di vigilare sull’attività edilizia e dovevano ordinare l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultassero necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino (art. 32, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942)."
In altri termini, il quadro normativo stratificatosi nel tempo - per come ricostruito dalla sentenza della Corte costituzionale - era tale sin da prima della L. 10/77 da rendere necessario il titolo edilizio per "variazioni non essenziali", così da impedire di ritenere dette "varianti non dichiarate" come "automaticamente legittime" ove, appunto, ante 77.
Il secondo tema affrontato dalla norma veneta è un tentativo di riproporre la teoria dell' ante 67 quale condizione legittimante "a priori" , ossia tale da sterilizzare la rilevanza di eventuali obblighi di titolo abilitativo previsti in strumenti urbanistici locali per aree diverse da quelle "urbane".
L'art. 9-bis D.P.R. 380/01 è sul punto "vago", non prendendo alcuna posizione espressa, esso si riferisce infatti a "gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio”.
E' in tale indeterminatezza del Legislatore statale che il Legislatore veneto ha tentato di inserirsi sposando una tesi giurisprudenziale minore, secondo la quale per quanto riguarda gli interventi edilizi compiuti prima del 1967 (entrata in vigore della L. 765/1967), fosse da escludere radicalmente la stessa possibilità di contestare l’assenza di titolo edilizio per opere realizzate all’in fuori del “centro abitato”, pur laddove questo fosse prescritto dalla disciplina urbanistica comunale vigente al tempo dell’intervento.
Ma la giurisprudenza amministrativa prevalente è di diverso avviso (sia con riferimento all'ante 67 sia con riferimento all'ante 1942).
La Corte costituzionale risolve il punto così:
pure al di fuori dei centri abitati e delle zone di espansione, nonché prima della legge n. 1150 del 1942, la necessità di un titolo abilitativo edilizio veniva, a ben vedere, disposta anche da altre fonti.
Anzitutto, per gli immobili realizzati in comuni ricadenti in zone sismiche, l’obbligo era sancito a livello di fonte primaria dal regio decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640 (Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti) e dal regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105 (Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti), il cui Allegato comprendeva alcune province della Regione Veneto.
Inoltre, l’obbligo di previa autorizzazione alla costruzione poteva essere disposto dal regolamento edilizio comunale, emanato in esecuzione della potestà regolamentare attribuita ai comuni nella materia edilizia dai testi unici della legge comunale e provinciale susseguitisi nel tempo: regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale), regio decreto 21 maggio 1908, n. 269 (Che approva l’annesso testo unico della legge comunale e provinciale), regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (È approvato l’annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale).
Se ne desume, dunque, che, prima della data indicata nel comma 2 della disposizione regionale impugnata, vi erano comuni nei quali era obbligatorio munirsi di un titolo abilitativo edilizio, sia sulla base di fonti primarie riferite a territori sismici, sia sulla base di fonti non primarie, che però attingevano la loro legittimazione dalla fonte primaria attributiva del potere regolamentare.
Dunque, le due disposizioni recate dall'art. 93-bis della L.R. Veneto 61/85 - considerata la portata di principio fondamentale dell'ordinamento della nozione statale di stato legittimo, di cui appunto all'art. 9-bis, co 1-bis, D.P.R. 380/01 - vengono dichiarate incostituzionali.
II. La analoga questione pendente sulla L.R. Piemonte 7/2022
Di analogo segno il tentativo della Regione Piemonte che ha di recente modificato la L.R. 16/2018, disponendo all'art. 2, co. 1, lett. d), che:
per immobili realizzati in un’epoca nella quale la legge non imponeva, per l’attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l’acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali.
La disposizione, che adotta la medesima impostazione della legge del Veneto (appena dichiarata incostituzionale), è stata impugnata dal Governo (delibera del C.d.M. del 28.7.2022), per le medesime ragioni ed argomenti che, come visto, hanno condotto la Corte costituzionale ha dichiarate illegittimo il co. 2 dell'art. 93-bis della L.R. Veneto 61/1985.
Scontato quindi l'esito di incostituzionalità anche di tale disposizione regionale.
III. Lo stato legittimo in Emilia-Romagna
In questo esame (a campione e non esaustivo) della legislazione regionale circa lo stato legittimo si segnala la soluzione della Regione Emilia Romagna.
Qui il Legislatore è intervenuto con l'art. 10-bis, L.R. 15/2013 (introdotto ex L.R. nn. 14/2020 e 5/2021).
"lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all' articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell' articolo 21, comma 01, della medesima legge regionale n. 23 del 2004"
Apparentemente la norma in esame sembrerebbe in linea con l'art. 9-bis nazionale.
Tuttavia, ad un più attento esame, si scopre che tramite il rinvio alle "tolleranze" di cui all'art. 19-bis L.R. 23/2004, la Regione Emilia Romagna è riuscita (per ora senza incidenti di costituzionalità) a far passare quell'allargamento delle maglie non riuscito altrove.
Infatti, il co. 1-ter dell'art. 19-bis di tale legge prevede che:
Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste
Ebbene, la norma sulle "tolleranze" a cui rinvia la disposizione sullo "stato legittimo emiliano-romagnolo" è chiara nel dare piena rilevanza ad una condizione (il legittimo affidamento derivante da attestazioni di agibilità o altre forme di controllo) che la giurisprudenza amministrativa, invece, ritiene da tempo del tutto irrilevante.
*
In conclusione, ancora una volta l'assetto concorrente Stato - Regioni in materia di governo del territorio finisce per generare un quadro caotico che finisce per vanificare anche norme, come quella sulle semplificazioni, votate ad un tentativo di "semplificazione".
Sullo sfondo restano ineludibili e ormai non più differibili esigenze di complessiva revisione della disciplina urbanistica, auspicabilmente, appunto, nel quadro di un riassetto più "ordinato" dei rapporti tra legislazione statale e regionale.
Attività ricettive (alberghiere ed extra) e destinazioni urbanistiche a Roma: tra P.R.G. e regolamenti regionali 8/2015 e 17/2008
 Il settore hospitality, in particolare a Roma, risulta essere in grande fermento.
Il settore hospitality, in particolare a Roma, risulta essere in grande fermento.
Con questo breve contributo cercheremo, quindi, di esaminare alcune questioni relative ai rapporti - talvolta tesi o quantomeno "non chiarissimi" - tra la disciplina di PRG (le NTA del 2008) e la regolamentazione recata dai Regolamenti regionali nn. 17/2008 (strutture alberghiere) e 8/2015 (strutture extra-alberghiere).
I. Ricettività e destinazione urbanistica nel PRG di Roma
L'art. 6 NTA considera espressamente nella categoria di cui al co. 1, lett d) - destinazione d'uso "turistico-ricettive" le seguenti funzioni: "strutture ricettive alberghiere - (fino a 60 posti letto: CU/b; oltre 60 posti letto e motel: CU/m); strutture ricettive extra-alberghiere - (fino a 60 posti letto e ostelli: CU/b; oltre 60 posti letto: CU/m); strutture ricettive all’aria aperta - (CU/m)".
Le singole norme di tessuto, poi, recano previsioni di dettaglio, atte a regolare e circoscrivere "zona per zona" le attività turistico-ricettive insediabili.
Fra tali disposizioni, ad esempio, si segnala per la "Città Storica", l'art. 24, co. 14-15 NTA il quale, da un lato, ammette le “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, con esclusione dei “motel” e, dall'altro, puntualizza che "il cambio di destinazione d’uso da funzioni abitative ad altre funzioni è ammesso solo per i piani seminterrati, piani terra e mezzanini; è ammesso altresì negli altri piani, al solo fine di consentire l’ampliamento delle destinazioni a “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che occupino, prima dell’ampliamento, almeno il 70% della SUL dell’Unità edilizia”.
Il tutto con l'ulteriore previsione, ex art. 26 NTA (relativa al tessuto T-1), che le “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, (...) , sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”.
Uno spaccato, quello della disciplina urbanistica in Città Storica (preso quale esempio), che rende chiaro come esistano nel PRG numerosi "paletti" per il cambio d'uso ad alberghiero che, in tale zona della Città, è a dir poco complesso.
II. I Regolamenti regionali
Il R.R. 17/2008 prevede che le strutture alberghiere(alberghi/hotel, residenze turistico alberghiere/residence):
a) devono possedere la destinazione turistico-ricettiva, sia al livello urbanistico sia al livello catastale (cfr. art. 2, co. 5)
b) con la (apparente, e vedremo al riguardo il pensiero del TAR Lazio) eccezione, a determinate condizioni, della sola ipotesi delle “dipendenze” di esistenti strutture alberghiere (cfr. art. 6, co. 4-bis), ipotesi di problematico coordinamento con le NTA PRG).
Circa le strutture extra-alberghiere il quadro è ben più articolato, prevendo il R.R. 8/2015 che per alberghi, ostelli per la gioventù, ostelli/hostel è necessaria la destinazione turistico-ricettiva (essendo irrilevante che il Regolamento individui una destinazione catastale "non alberghiera"): in tal senso, peraltro, si registrano (i) la Circolare Regione Lazio prot. n. 47778 del 29.1.2018 inviata a Roma Capitale con ove si afferma che per utilizzare un immobile come hostel è necessaria la destinazione urbanistica “turistico-ricettiva” (ii) un decreto cautelare del TAR Lazio, n. 4507/2018; (iii) l'ordinanza TAR Lazio n. 2290/2019, confermata da Cons. Stato n. 4177/2018.
Invece, per "guest house/affittacamere" e "case e appartamenti per vacanze" il Regolamento esclude la necessità di cambio di destinazione d'uso.
III. "Attriti" tra Regolamenti regionali e NTA PRG: i casi di affittacamere/case vacanza nonché delle "dependance" alberghiere.
1. Partendo dall'ultimo punto accennato (la non necessità di cambio d'uso da residenziale a turistico-ricettivo per le categorie affittacamere e case vacanza) si deve registrare, in effetti, un latente contrasto tra NTA PRG e Regolamentazione regionale.
Il PRG, infatti, da un lato non contempla espressamente le due categorie in esame e, dall'altro, riconduce l'intero segmento della ricettività extra-alberghiera nella destinazione urbansitica turistico-ricettiva.
La questione è stata affrontata da TAR Lazio n. 7480/2015.
Qui il Giudice Amministrativo, chiamato a valutare la legittimità del provvedimento di Roma Capitale che aveva inibito una SCIA presentata per una attività extra-alberghiera di affittacamere, ha osservato come la disciplina “contenuta nel Regolamento regionale e nella pianificazione locale … non osti alla utilizzazione degli appartamenti … (a destinazione civile abitazione) per attività di affittacamere (…)” e ciò avuto anche riguardo al fatto che, sempre secondo il TAR, l’art. 6 NTA PRG non contempla espressamente la specifica funzione “affittacamere” all’interno dell’art. 6, co. 1, lett. d) (pur riferita, genericamente, alle attività ricettive, anche extra-alberghiere).
Da sottolineare come Roma Capitale non abbia appellato tale decisione.
D'altronde, si aggiunge, la conclusione del TAR appare condivisibile anche alla luce dell’art. 6, co. 2, NTA PRG a mente del quale “per le destinazioni d’uso non comprese o non direttamente riconducibili alla classificazione del comma 1 [ossia l’elenco delle varie funzioni e relative specifiche], si procede per analogia funzionale e di carico urbanistico (…)”.
2. La seconda ipotesi che esaminiamo - sempre "a campione" - è la questione della destinazione d'uso occorrente per l'insediamento delle "dipendenze" degli alberghi.
L’art. 6, co. 4-bis, del Regolamento regionale n. 15/2008 (“disciplina delle strutture ricettive alberghiere”) dispone che le dipendenze (ossia “locali per l’alloggio dei clienti, situati in stabili, o parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette”) di una struttura alberghiera che devono trovarsi entro 300 metri dall’immobile principale (o “casa madre”), a condizione del mantenimento della “unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi”, “non sono soggette a cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici e rispettano i requisiti previsti per le abitazioni e la normativa vigente in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti”.
Tale disposizione pare porre una deroga alla necessità della destinazione turistico-ricettiva in ipotesi di dependance alberghiera.
La questione, in particolare, si è posta in relazione alla norma (esaminata in precedenza) che, per gli immobili a destinazione residenziale in Città Storica consente il cambio d'uso (di piani superiori al mezzanino) soltanto al fine di "consentire l’ampliamento delle destinazioni a “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che occupino, prima dell’ampliamento, almeno il 70% della SUL dell’Unità edilizia”.
2.1 Sul punto si registra una presa di posizione del DPAU che, con nota prot. 134995 del 19.11.2020, ha rilevato che “le norme regolamentari che discendono da quelle delle NTA del PRG vigente (…) non possono essere disapplicate” e ciò anche in quanto “un’applicazione generalizzata e liberalizzata del Regolamento Regionale potrebbe configgere con uno dei principi informatori della normativa urbanistica della Città Storica che è quella di preservare la destinazione residenziale prevalente”.
2.2 Inoltre, sulla portata della speciale norma ex art. 6, co. 4-bis del R.R. 15/2008 si è di recente espresso anche il TAR Lazio, con la sentenza n. 8167/2022.
Anche in questo caso veniva in rilievo l'art. 24 NTA nella parte in cui vieta il cambio d'uso da abitativo ad altre funzioni.
La ricorrente - richiamando la norma regionale - aveva evidenziato che questa consentirebbe l’esercizio di attività turistico-ricettiva di dipendenza alberghiera in locali aventi destinazione residenziale, purché nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, così ammettendo l’esercizio dell’attività di tipo turistico-ricettivo presso locali con destinazione d’uso residenziale.
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo [con un percorso motivazionale piuttosto singolare, che collega inspiegabilmente il R.R. 15/2008 alla L.R. 7/2017 sulla rigenerazione urbana (?) ] che l'art. 6, co. 4-bis del Regolamento regionale non sarebbe idoneo a derogare le norme di Piano Regolatore, stante, tra l'altro, l'art. 2 del Regolamento stesso secondo il quale “le unità immobiliari adibite a strutture recettive alberghiere possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali”.
2.3 A parere nostro, tanto la posizione del DPAU quanto la sentenza del TAR non sono condivisibili (quest'ultima per certi versi incomprensibile, nei riferimenti normativi): infatti la superiorità gerarchica del Regolamento regionale, la natura speciale ed eccezionale dell'art. 6, co. 4-bis nonché la posteriorità della disposizione regionale rispetto al PRG di Roma depongono chiaramente nel senso di ritenere le norme di PRG recessive rispetto alla disposizione regionale. Si auspica, quindi, che la questione possa essere riesaminata dal Consiglio di Stato.
IV. Sullo sfondo: il permesso di costruire in deroga quale "via di fuga".
Esaminati - "a campione" - tali aspetti, deve solo ricordarsi come una (possibile) soluzione alle rigidità del Piano Regolatore può essere costituita dal ricorso al Permesso di costruire in deroga ex art. 14 del D.P.R. 380/2001.
Tale disposizione, che consente di derogare (esclusivamente) il P.R.G. in punto di "limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d’uso ammissibili", previa valutazione di sussistenza di ragioni di "interesse pubblico" da parte del Consiglio comunale, è infatti dalla giurisprudenza amministrativa ritenuta pienamente applicabile ad interventi edilizi concernenti le strutture alberghiere.
Ad esempio ha di recente statuito Cons. Stato 346/2020, che "la costruzione e l’ampliamento di strutture alberghiere rientra infatti tra gli impianti di interesse pubblico per i quali è consentito il rilascio di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14, comma 1, T.U. Edilizia. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che le strutture alberghiere rientrino tra gli impianti a interesse pubblico per i quali è consentito il rilascio di (...) permesso di costruire, ai sensi d(...) dell’art. 14 T.U. Edilizia (cf...). Secondo questo Consiglio non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell’edificio o al suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso".
Chiaramente, si tratta di strumento peculiare e applicabile in presenza di un effettiva valutazione - al livello di Consiglio comunale - di un pubblico interesse, tuttavia, come indicato dalla casistica giurisprudenziale, esso può rappresentare una speciale soluzione in diverse fattispecie.
Stato legittimo, fabbricati condonati e distanze ex art. 2-bis D.P.R. 380/01
 Parlando di demolizione e ricostruzione ("demoricostruzione" o sostituzione edilizia) un profilo particolare è quello del corretto inquadramento della disciplina applicabile ai fabbricati condonati ai fini della disciplina delle distanze legittimamente preesistenti ex art. 2-bis D.P.R. 380/01, quale risultante dalle modifiche ex L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni).
Parlando di demolizione e ricostruzione ("demoricostruzione" o sostituzione edilizia) un profilo particolare è quello del corretto inquadramento della disciplina applicabile ai fabbricati condonati ai fini della disciplina delle distanze legittimamente preesistenti ex art. 2-bis D.P.R. 380/01, quale risultante dalle modifiche ex L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni).
I. L'art. 2-bis, co. 1-ter D.P.R. 380/2001 e i fabbricati condonati
Ai fini del presente esame, dobbiamo innanzi tutto ricordare (ne avevamo parlato a caldo, commentando il Decreto Semplificazioni 2020) quale è la speciale disciplina delle distanze in ipotesi di demolizione e ricostruzione, quale risultante dalle modifiche apportate all'art. 2-bis D.P.R. 380/01 dalla L. 120/2020.
In particolare la disposizione che viene in rilievo è il co. 1-ter (primo e secondo periodo, occupandosi l'ultimo periodo delle particolari regole per le zone A e "simili").
Esso dispone che:
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
I temi che la norma, finalizzata a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana, pone sono molteplici.
Qui approfondiremo cosa debba intendersi, specie in caso di fabbricati condonati, per "distanze legittimamente preesistenti" le quali, sempre per il disposto della norma in esame, costituiscono il "limite" da osservarsi sia in caso di demolizione e ricostruzione "semplice" (che questa sia da qualificarsi come ristrutturazione edilizia o, invece, nuova costruzione è dato non rilevante ai fini della norma in esame, come chiarito anche dalla Circolare MIT - Funzione Pubblica del dicembre 2020).
Oggi - come è noto - quando parliamo di "legittimità" la stella polare è senz'altro l'art. 9-bis del D.P.R. 380/01.
Come è noto, l’art. 9-bis, co. 1-bis D.P.R. 380/2001 sancisce - a seguito delle modifiche ex L. 120/2020 - che il pieno e perfetto “stato legittimo” dell’immobile si determina (anche) in virtù del titolo che ha “legittimato” la costruzione.
In tal senso, oltre a registrarsi una giurisprudenza anteriore alla novella del 2020, si segnala infatti la prima giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sull’art. 9-bis, co. 1-bis, D.P.R. 380/2001 (si veda TAR Liguria, 22.4.2021, n. 361).
E, a conforto di detta interpretazione, si segnala che la Regione Emilia-Romagna, proprio sulla scorta della nozione di stato legittimo introdotta al livello statale dalla L. 120/2020, ha disposto all’art. 10-ter della L.R. 15/2013 che ai fini delle distanze legittimamente preesistenti da osservarsi in sede di demoricostruzione rileva lo stato legittimo come definito dall’art. 9-bis D.P.R. 380/2001 (norma recepita in Emilia-Romagna con l’art. 10-bis della L.R. 23/2004).
Quanto sopra trova, poi, conferma sia in un recente parere della Regione Lazio (prot. 778697 del 30.9.2021) sia nella già citata Circolare interministeriale MIT- Funzione Pubblica del 1.12.2020.
Il parere regionale (chiesto proprio in ordine alle modalità di applicazione dell’art. 2-bis, co. 1-ter in caso di demoricostruzione ex art. 6 L.R. Lazio 7/2017 sulla rigenerazione urbana) chiarisce come ai fini della nozione di distanza “legittimamente preesistente” debba farsi riferimento allo stato legittimo ex art. 9-bis, co. 1-bis, D.P.R. 380/2001 cosicché “l’edificio preesistente è da considerare legittimo alle condizioni di cui all’art. 9bis del d.P.R. 380/2001, soddisfatte le quali la legittimità riguarda anche le distanze (…); non è quindi corretto ritenere che solo le distanze che risultino conformi alla normativa integrino gli estremi di una preesistenza legittima”.
La Circolare interministeriale depone nel medesimo senso laddove, al § 3, chiarisce che “al fine di verificare la legittima realizzazione dell’immobile preesistente, soccorre la previsione dell’articolo 9-bis del Testo unico (…)”.
II. Quali distanze sono legittimate?
Una volta chiarito che per "distanze legittimamente preesistenti" devono intendersi anche quelle relative ad un fabbricato condonato, una ulteriore riflessione può svolgersi circa le distanze che si ha diritto di "mantenere".
Al riguardo, occorre notare che laddove la norma si riferisce alle distanze minime (“dai fabbricati e dai confini”) essa è destinata ad operare in deroga non solo al D.M. 1444/1968 (ossia alla regola dei 10 metri tra pareti finestrate) ma con riferimento ad ogni norma relativa alle distanze: non a caso, infatti, la disposizione non solo non è circoscritta alle distanze di cui al citato D.M. 1444/1968 ma espressamente menziona anche le distanze dai confini (profilo che, come noto, non costituisce oggetto di disciplina del D.M.).
Tale interpretazione è peraltro sposata anche dalla Circolare MIT - Ministero P.A. del 1.12.2020 (avente ad oggetto: “Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Chiarimenti interpretativi”) laddove, al paragrafo 3 viene chiarito che “(…) le previsioni contenute nel comma 1-ter dell’articolo 2-bis del testo unico vanno lette nel contesto della disposizione in questione, che è specificamente intesa a disciplinare i casi in cui siano oggetto di demolizione e ricostruzione edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi comprese quelle contenute nel d.m. n. 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita l’edificazione ex novo. In questi casi, il primo periodo del comma in esame ha chiarito che la ricostruzione è possibile – in sostanza – in deroga alle norme in questione, e quindi col mantenimento delle distanze preesistenti (…)”.
Dunque le disposizioni sulle distanze oggetto di deroga non sono solo, ma anche, quelle di cui al D.M. 1444/1968, di talché la norma ha portata derogatoria di ogni disposizione sulle distanze “dalle costruzioni e dai confini”.
A tale ultimo riguardo, infatti, la medesima Circolare interministeriale sottolinea che “l ’articolo 2-bis (a …) è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgano problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell’articolo 9del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa)”.
III. La possibilità di ricostruire nonché ampliare "nei limiti" delle distanze legittimamente preesistenti.
La norma di cui all’art. 2-bis d.P.R. 380/2001, nella versione oggi applicabile (ossia quella frutto della novella ex L. 120/2020) sancisce il diritto di ricostruire il fabbricato oggetto di demolizione nonché di collocare la cubatura frutto di incentivi volumetrici “con ampliamenti fuori sagoma e con superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito” e ciò “nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
Come osservato dalla prima giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su tale disposizione, la nuova versione dell’art. 2-bis, co. 1-ter d.P.R. 380/2001 reca una disciplina sotto questo punto di vista del tutto differente rispetto alla previgente versione (si veda, sul punto, TAR Piemonte, Sez. II, 18.8.2021, n. 827).
Valga notare che mentre il previgente testo dell’art. 2-bis, co. 1-ter in esame prescriveva (senza alcuna deroga nemmeno per l’atterraggio delle premialità) in sede di ricostruzione il “rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo” oggi la norma - oltre a prevedere una deroga ad hoc per i citati aumenti di cubatura - adopera, significativamente, l’espressione “nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
Ciò implica che l’intervento - lungi dal dover essere fedele quanto alle preesistenti distanze (ossia, detto in termini più concreti, “perfettamente sovrapponibile” quanto al sedime/sagoma, circostanza d’altronde logicamente non conciliabile né con la nuova nozione di ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva ex art. 3, co. 1, lett. d), né con la citata possibilità di ampliamenti in altezza/adiacenza) – potrà determinare anche un diverso “allineamento” purché non peggiorativo della situazione legittimamente preesistente (appunto: entro i “limiti delle distanze legittimamente preesistenti”) ancorché il nuovo allineamento possa, ancora, risultare violativo delle vigenti disposizioni sulle distanze.
Peraltro, il senso dell’estensione della deroga anche alle volumetrie premiali sempre “nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti” è quello – ai fini appunto della rigenerazione urbana – di consentire eventuali soprelevazioni/ampliamenti fuori sagoma sempre entro la “proiezione virtuale” delle distanze delimitate dalla precedente sagoma di ingombro del fabbricato oggetto di demo-ricostruzione.
Dunque, come già condivisibilmente osservato da altri commentatori "atteso che plus semper in se continet quod est minus" (ossia: “nel più è compreso il meno”) - è senz’altro ammesso un intervento di ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione in arretramento, anche parziale, rispetto all’esistente, pur senza rispettare le normative vigenti sulle distanze.
Demolizione e ricostruzione in "area vincolata": dalla conversione del D.L. 17/2022 ("Energia") una prima apertura.

Del "nodo" della ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione (anche detta "demoricostruzione" o "sostituzione edilizia") in area interessata da vincolo (o tutela) paesaggistico areale abbiamo spesso parlato, in termini critici.
Di recente, con un contributo su Lavoripubblici.it si è avuto modo di commentare una interessante apertura della giurisprudenza, così come in precedenza avevamo evocato un intervento del legislatore, vista la sostanziale irragionevolezza dell'art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/01 laddove, in area interessata da tutela paesaggistica, impone che la demolizione e ricostruzione per rimanere ristrutturazione edilizia deve essere "fedelissima".
Ebbene, è notizia di queste ore, che in sede di conversione del D.L. 17/2022 "misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"), in particolare nel testo attualmente al voto di fiducia della Camera , è stata inserita una modifica che va (timidamente) nella direzione da noi (e da molti) auspicata. Esaminiamo, quindi, questa prima apertura.
L'art. 28, co. 5-bis del Decreto Legge 17/2022
In particolare, all'art. 28 del D.L. è stato introdotto il comma 5-bis che modificherà (grassetto sottolineato nel testo sotto riportato) la "seconda parte" dell'art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/01 come segue:
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
La modifica incide inoltre anche sull'art. 10, co. 1, lett. c) del D.P.R. 380/01 (quindi sul regime abilitativo) prevedendo che sono soggetti a permesso di costruire o SCIA alternativa anche "gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria”.
Una prima valutazione a caldo della modifica in itinere.
L'intervento normativo va nella direzione - che abbiamo spesso auspicato - di superare i limiti stringenti che impediscono di qualificare come ristrutturazione edilizia qualsivoglia demolizione e ricostruzione in area tutelata paesaggisticamente in presenza di modifiche dei parametri edilizi (sagoma, prospetti, sedime, volume e caratteristiche tipologiche).
Tale apprezzabile ratio ispiratrice è, tuttavia, perseguita con un rinvio ai soli edifici ricadenti nelle aree tutelate ex art. 142 del d.lgs. 42/2004, ossia alle "aree tutelate per legge" (fasce costiere, lacuali, fluviali, aree montane, zone di interesse archeologico, etc.).
La scelta selettiva del Legislatore, per converso, conferma (a questo punto tramite una disposizione espressa, sia pur "per sottrazione") che per gli edifici ricadenti nelle aree interessate da vincoli provvedimentali ex art. 136 d.lgs. 42/2004 la demoricostruzione sarà qualificabile come ristrutturazione edilizia esclusivamente laddove sia "fedelissima".
A nostro avviso, il risultato, è una scelta che mantiene un certo tasso di irragionevolezza e che, comunque, finisce per rallentare i processi di rigenerazione urbana, riqualificazione e cleaning del territorio in presenza di vincoli che, spesso, sono prettamente "areali", che, cioé non hanno di mira espressamente la tutela dei fabbricati che ricadono nel territorio tutelato.
Infatti, i vincoli provvedimentali ex art. 136 del d.lgs. 42/2004 spesso hanno ad oggetto aree senza che con essi l'Ente impositore del vincolo abbia inteso proteggere i fabbricati ivi ricadenti. Fabbricati che, anzi, spesso sono stati condonati in quelle aree o prima dell'apposizione del vincolo o nonostante la presenza del vincolo (specie con il primo condono edilizio).
A nostro avviso, allora, meglio sarebbe stato o superare direttamente e in ogni caso l'obbligo di ricostruzione fedelissima o, proprio volendo mantenere un riferimento all'art. 136 del d.lgs. 42/2004, circoscrivere l'ambito di operatività di tale limite adoperando la medesima soluzione individuata dal D.P.R. 31/2017 (ossia rinviando all'art. "136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici (...)").
Ed infatti, se ragioniamo sul banale esempio di un'area interessata da vincolo ex art. 136, co. 1, lett. d), d.lgs. 42/2004 ("bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze") quale senso ha imporre che, nel contesto del "panorama da tutelare", sia possibile demolire un fabbricato chiaramente incongruo solo riedificandolo "tale e quale"?
Sullo sfondo, torniamo a dirlo, il Legislatore "dell'edilizia" sembra scordare che il Legislatore "dei beni culturali e paesaggistici" sottoponga, comunque, questi interventi al giudizio di compatibilità della Soprintendenza ex art. 146 del d.lgs. 42/2004.
In definitiva, pur accogliendo con favore l'intervento legislativo in itinere, non può non osservarsi come lo stesso reiteri (sia pur circoscrivendolo) un vizio ed un equivoco di fondo (e, a nostro avviso, un possibile vizio di costituzionalità).
Insomma, come spesso accade, può chiosarsi rilevando che "tanto tuonò che piovve".
Art. 45, co. 6, NTA PRG Roma: verso la riscrittura?
 Il 17.3.2022 l'Assemblea Capitolina ha votato all'unanimità una mozione che impegna il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica
Il 17.3.2022 l'Assemblea Capitolina ha votato all'unanimità una mozione che impegna il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica
"ad una iniziativa che produca una Deliberazione dell’Assemblea Capitolina, preceduta da una fase di ascolto e confronto coinvolgendo la Commissione Consiliare, innanzitutto il suo Presidente e i suoi Vice Presidenti, che comporti una prima modifica delle Norme Tecniche di Attuazione in alcuni punti, in primis l’art. 45, a partire dall’adeguamento delle nuove norme che si sono susseguite, citando a titolo esemplificativo l’approvazione della Legge Regionale n. 7/2017, al recepimento della sentenza richiamata nelle premesse e tenendo conto di precedenti proposte di modifica avanzate nelle passate Consiliature in particolare riferite agli artt. 52 e 53";
Della questione abbiamo parlato varie volte, anche (ma non solo) con specifico riferimento ai rapporti che tale norma di PRG ha con la disciplina ex art. 6 L.R. 7/2017 sulla rigenerazione urbana e in particolare qui:
La mozione dell'Assemblea Capitolina (approvata all'unanimità) pare quindi "dare il La", finalmente, alla revisione di una norma di più che discussa applicazione, foriera di un significativo contenzioso e che probabilmente non ha raggiunto gli obiettivi che (al momento della sua introduzione) si ipotizzava di poter cogliere.
Degno di nota anche l'invito a Sindaco ed Assessore "affinché venga predisposta in un tempo più lungo una ulteriore proposta di deliberazione che preveda un riesame complessivo delle Norme Tecniche di Attuazione", che pare preludere ad una rivisitazione più complessiva dell'impianto normativo del PRG di Roma.
Avremo modo di tornare sulla questione.
Come si suol dire, "se son rose, fioriranno".
Incostituzionale l'art. 2-bis D.P.R. 380/01 sugli standard urbanistici? I dubbi del Consiglio di stato sulla "delega in bianco" alle Regioni.
 Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza collegiale 17.3.2022, n. 1949, sottopone alla Corte costituzionale un dubbio "esistenziale" sulla legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/01 nella parte in cui consente alle Regioni di derogare gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 (la questione, quindi, come precisa l'ordinanza non riguarda in questo caso il diverso tema delle distanze).
Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza collegiale 17.3.2022, n. 1949, sottopone alla Corte costituzionale un dubbio "esistenziale" sulla legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/01 nella parte in cui consente alle Regioni di derogare gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 (la questione, quindi, come precisa l'ordinanza non riguarda in questo caso il diverso tema delle distanze).
Vediamo - in estrema sintesi - la questione sollevata dal Consiglio di Stato.
I. Il quadro normativo di riferimento
Come è noto la L. 1150/1942, così come modificata dalla L. 765/1967, demanda, tramite l'art. 41-quinquies, ad un Decreto Ministeriale la individuazione, tra l'altro, dei "rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti". Si tratta appunto dei cosiddetti standard urbanistici inderogabili.
Questi sono poi stati individuati dal D.M. 1444/1968, in particolare agli artt. 3, 4 e 5.
A valle di una lunga e faticosa elaborazione giurisprudenziale (prima del giudice amministrativo e, poi, della Corte costituzionale) il Legislatore ha introdotto (e più volte modificato) l'art. 2-bis del D.P.R. 380/01, a mente del quale (nella versione oggi vigente del comma 1) si prevede che:
"Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali".
Tale disposizione costituisce quindi la fonte della potestà (legislativa e regolamentare) delle Regioni (nonché delle province autonome) in punto di deroga agli standard di cui al D.M. 1444/68.
II. Cenni essenziali sulla vicenda contenziosa che ha condotto all'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
Il giudizio da cui ha preso le mosse l'ordinanza del Consiglio di Stato vede l'impugnativa di uno strumento urbanistico da parte di un operatore economico, in ragione del notevole sovradimensionamento delle aree a standard.
Trovandoci, nella fattispecie, nel territorio della Regione Lombardia, veniva in rilievo l'art. 103, co. 1-bis, L.R. 12/2005 in base al quale "Ai fini dell’adeguamento, (...), degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (...)".
In particolare ed in sintesi, il meccanismo normativo operante in Lombardia sul punto vede, da un lato tale norma di "disapplicazione" del D.M. 1444/68 e, dall'altro, la fissazione di uno standard minimo per le aree residenziali, con rinvio, per le altre destinazioni, alla pianificazione comunale.
III. Il dubbio circa la legittimità costituzionale dell'art. 2-bis D.P.R. 380/01
Nello scrutinare la complessa vicenda il Consiglio di Stato ha evidenziato la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis il quale - ad attento ed approfondito esame - finisce per conferire alle Regioni (come nel caso dell'art. 103, co. 1-bis L.R. Lombardia 12/2005) una sorta di "delega in bianco" come tale, sempre ad avviso del Consiglio di Stato, illegittima perché:
a) neutralizza la portata cogente dell'art. 41-quinquies L. Urbanistica (e, quindi, del D.M. 1444/68):
b) produce una sostanziale liberalizzazione (e deregulation), con un vuoto di disciplina "quadro" da parte dello Stato (il Governo del territorio è materia di competenza concorrente, allo stato competono i principi fondamentali);
c) deregulation che, in ultima istanza, produrrebbe una interferenza con la competenza statale ex art. 117, co. 1, lett. m) ed s) Costituzione che affida allo Stato in esclusiva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sull'intero territorio nazionale nonché in punto di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
d) la cui mancata (cogente) previsione della quota minima di infrastrutture e aree per servizi - di cui al D.M. 1444/68 - costituisce un "livello essenziale" delle prestazioni, in violazione anche dell'art. 3 Costituzione.
Come conseguenza della (eventuale) illegittimità dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/01 si avrebbe, ovviamente, la "caduta" anche della disposizione della L.R. Lombardia, la quale, infatti, trova fondamento nel potere derogatorio "illimitato" . Ove venisse meno la norma attributiva del potere legislativo derogatorio, ne conseguirebbe l'illegittimità della norma regionale.
IV. Osservazioni "a caldo" e prospettive future.
Così riassunta e "semplificata" la questione, è chiaro che dall'esito del giudizio di legittimità costituzionale rimesso dal Consiglio di Stato alla Consulta discenderanno conseguenze non solo per la Regione Lombardia (potrebbe, infatti, venir meno un rilevante segmento della pianificazione territoriale) ma anche per tutte le altre Regioni che, avvalendosi della "delega" ex art. 2-bis D.P.R. 380/01, abbiano posto in essere discipline derogatorie che vedrebbero cadere il necessario presupposto di legalità costituzionale.
Sullo sfondo resta il tema della complessiva riforma della Legislazione urbanistica, allo stato rimesso alla Commissione nominata dal MIMS con il decreto 441/2021 dove, infatti, si legge che occorre porre in essere "una riforma organica dei principi della normativa in materia di pianificazione del territorio e standard urbanistici, nonché di riordino e modifica delle disposizioni del Testo unico dell’edilizia, mediante l’elaborazione di uno o più schemi di provvedimento sui quali aprire un dibattito pubblico e raccogliere contributi di riflessione e proposte in vista del riordino complessivo del settore".
Demoricostruzione con accorpamenti o "frazionamenti": ristrutturazione edilizia o no?

Come noto, il D.L. 76/2020 ("decreto semplificazioni") ha fortemente innovato l'art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/01.
Del tema ci siamo più volte occupati in relazione a vari profili (tra cui il tema, spinoso, delle criticità per interventi su immobili vincolati).
Uno specifico aspetto che merita alcune riflessioni è quello del possibile (ulteriore) allargamento (nell'ambito anche del fenomeno degli incentivi alla rigenerazione urbana) dei confini della ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione, alle peculiari ipotesi di demolizione di un fabbricato e realizzazione di più edifici e, viceversa, della demolizione di più fabbricati con accorpamento in una unica struttura. Insomma: "demolizioni e ricostruzione" e "demolizione e ricostruzioni".
I. L'art. 3, co. 1, lett. d), come innovato dal D.L. 76/2020.
Punto di partenza è, ovviamente, la "nuova" ed amplia nozione di ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva oggi dettata dal D.P.R. 380/01 in base alla quale si prevede, tra l'altro, che:
"Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche (...)".
Anteriormente alla modifica del 2020, si disponeva che:
"Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente"
E' da subito parso chiaro come la nuova versione della norma, improntata ad incentivare processi di sostituzione edilizia e rigenerazione urbana, avesse ampliato significativamente la portata della ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione (con riferimento alla possibilità di variare tutti i parametri edilizi possibili, ivi incluso quello della cubatura, a determinate condizioni), inquadrando, di fatto, inquadrandovi, di fatto, la c.d. sostituzione edilizia.
II. Accorpamenti e frazionamenti di edifici?
Ma ciò su cui in questo contributo vogliamo riflettere è un "confine estremo" della categoria della ristrutturazione edilizia tramite demoricostruzione: è, cioè, possibile intervenire con una sostituzione edilizia che dia luogo da un edificio preesistente a più edifici o, viceversa, da più edifici ad un unico fabbricato?
Astrattamente tale ipotesi pare riconducibile - nel nuovo testo dell'art. 3, co. 1, lett. d) - alla circostanza che la norma si riferisce alla possibilità di variare sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche degli edifici preesistenti.
Infatti, stando al significato proprio delle parole oggi adoperate nella norma di legge tra le caratteristiche planivolumetriche ben possiamo ricomprendere anche le due ipotesi di "frazionamento" e "accorpamento" di cubature preesistenti (e ciò anche combinandovi i parametri del sedime e delle caratteristiche tipologiche).
La redistribuzione della cubatura sul lotto non sembra quindi a priori determinare uno sconfinamento dalla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, ferma restando, in tali ipotesi la necessità di verificare la disciplina relativa alle distanze, anche avuto riguardo all'art. 2-bis, co. 1-ter del medesimo D.P.R. 380/2001 (tema sul quale, in questa sede, non ci soffermeremo).
La fattispecie in esame, tuttavia, "confina" con l'intervento di cui all'art. 3, co. 1, lett. f), D.P.R. 380/2001, ossia la "ristrutturazione urbanistica": ossia gli interventi "volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".
III. Primi pronunciamenti "amministrativi"
Allo stato non consta alcuna pronuncia giurisdizionale sul punto.
Tuttavia due recenti pareri della Regione Emilia-Romagna confermano la possibilità di sostenere l'interpretazione sopra riferita.
In particolare, il parere 29.12.2021 del Servizio giuridico del Territorio rileva - anche, ma non solo, facendo leva su una espressa norma della L.R. Emilia Romagna 15/2013 - che si ricada in ristrutturazione edilizia "ogniqualvolta sia prevista la completa demolizione di uno o più edifici esistenti nello stesso lotto, con successiva ricostruzione sul medesimo lotto o di un unico edificio (nel caso di accorpamento) o di più edifici (nel caso di frazionamento)", intervento quindi assoggettato a SCIA ex artt. 3, co. 1, lett. d) e 22, co. 1, lett. c) D.P.R. 380/01.
Fa accezione a tale ipotesi il caso in cui l'intervento "sconfini" nella fattispecie della "ristrutturazione urbanistica", ossia quando esso "comporti effetti che esulino dal campo meramente edilizio della demolizione e ricostruzione di uno o più edifici (sia pure con le innovazioni introdotte dal D.L. n. 76/2020) e, dunque, un diverso assetto del territorio dovuto, ad esempio, al frazionamento del lotto originario di intervento, alla definizione di differenti indici di edificabilità per ciascun lotto, alla realizzazione o rifacimento di dotazioni territoriali, di tratti di infrastrutture per la mobilità, di parcheggi, di reti e servizi pubblici, ecc.", così come il caso di interventi edilizi (di frazionamento/accorpamento cubature) che determinino un "trasferimento di volumetrie da un lotto ad un altro" con conseguente " "creazione di un diverso assetto territoriale".
Ad una diversa conclusione perviene un parere del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica relativo ad un intervento di demoricostruzione di un complesso edilizio commerciale, con accorpamento di cinque preesistenti edifici.
Secondo tale Ufficio un intervento del genere (demoricostruzione con accorpamento di cubature) costituirebbe in ogni caso una nuova costruzione ex art. 3, co. 1, lett. e), D.P.R. 380/01.
La posizione espressa nel parere in questione appare poco convincente, per varie ragioni.
In primo luogo, decisivo rilievo nel ragionamento ha un precedente (Cass. Penale 10.1.2020, n. 23010) antecedente al decreto semplificazioni 2020 (basti considerare che la sentenza si appunta, tra l'altro, sul divieto di modifica dell'area di sedime nonché sui principi, oggi superati, indicati da Corte Costituzionale 70/2020, resa a partire dal quadro normativo di cui allo "sblocca cantieri" del 2019).
In secondo luogo il DPAU travisa la portata dell'art. 2-bis, co. 1-ter del D.P.R. 380/2001 così come innovato sempre dal decreto semplificazioni 2020: diversamente da quanto sembra sostenersi nel parere in esame, la disposizione (l'ultimo periodo), nel riconoscere spazio alla pianificazione urbanistica in determinate zone di PRG, si riferisce esclusivamente alla tematica delle "deroghe" alle distanze in sede di demolizione e ricostruzione (e ciò trova conferma anche nella Circolare interministeriale del dicembre 2020, che abbiamo qui esaminato). Il che priva - a nostro avviso - di fondamento i ragionamenti svolti nel parere che valorizzano, a titolo esemplificativo, talune norme del PRG di Roma che, laddove incidono sulla "definizione degli interventi", sono chiaramente cedevoli rispetto a quanto disposto dal D.P.R. 380/01 (ricordiamo, infatti, che ex art. 3, co. 2, TUEd, dette definizioni "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi").
Peraltro, quest'ultima riflessione circa la prevalenza delle definizioni del D.P.R. 380/01 rispetto a quelle recate dai P.R.G. ci offre la misura di come l'adesione alla ipotesi interpretativa qui sostenuta abbia una notevole potenzialità di "trasformazione a freddo" delle scelte pianificatorie degli Enti Locali. Un tema, questo, quantomai delicato ove si consideri che interventi del genere, fino ad oggi, erano sempre stati considerati come nuova costruzione e, quindi, da escludersi laddove lo strumento urbanistico ammetta "solo" la ristrutturazione edilizia.
IV. Conclusioni
A nostro avviso, dunque, il "nuovo" testo dell'art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/01 offre sufficienti argomenti per poter sostenere - sempre laddove non si sconfini nella fattispecie della ristrutturazione urbanistica (secondo le coordinate in concreto ben delineate dal parere della Regione Emilia-Romagna) - che all'interno della ristrutturazione edilizia sia oggi possibile collocare anche interventi "complessi" di complessiva ridistribuzione della esistente cubatura, riconducibili, in estrema sintesi alla facoltà di ricostruzione con soluzioni planivolumetriche completamente innovative rispetto alla preesistenza edilizia.
Cohousing e senior living: la parola al Giudice Amministrativo.
 Tra gli asset class più in ascesa nel settore immobiliare, il senior living difetta di una disciplina univoca, tanto al livello contrattuale, quanto al livello di definizione urbanistico-edilizia (oltre che in ordine al regime amministrativo circa lo svolgimento della "attività").
Tra gli asset class più in ascesa nel settore immobiliare, il senior living difetta di una disciplina univoca, tanto al livello contrattuale, quanto al livello di definizione urbanistico-edilizia (oltre che in ordine al regime amministrativo circa lo svolgimento della "attività").
Come noto, si tratta di immobili destinati al cohousing per la terza età, costituito da sistema appartamenti indipendenti, organizzati in maniera tale da poter fruire alcuni servizi comuni aggiuntivi nonché idonei a determinare forme di socialità.
Al livello normativo, tanto sul piano contrattuale, quanto sul piano urbanistico ed autorizzatorio, difetta una disciplina di riferimento.
Una recente sentenza del TAR Lazio , in tale quadro incerto, ha affrontato una peculiare fattispecie nella quale è pervenuta alla conclusione di dover escludere che si fosse al cospetto - come sostenuto da parte ricorrente - di un cohousing destinato a persone anziane (meglio detto senior living, appunto) ravvisando, invece, una ipotesi di elusione della disciplina regionale regolante la "autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali".
In particolare, un Comune ha disposto la chiusura di una struttura nella quale, a fronte di un contratto di "locazione" gli abitanti (anziani, appunto) fruivano non solo delle unità immobiliari, ma anche di spazi comuni (salone e cucina) e servizi di tipo assistenziale-sanitario, prestati da un professionista qualificato.
A fronte di tale peculiare organizzazione e rapporto contrattuale, la PA ha quindi ritenuto che si fosse al cospetto di una struttura socio assistenziale, non esercitabile senza la prescritta autorizzazione (ex L.R. Lazio 41/2003).
Nel rigettare il ricorso proposto dai residenti della struttura, il TAR ha ritenuto che - sebbene non possa escludersi cittadinanza giuridica e legittimità al cohousing - occorre nondimeno individuare tratti distintivi tra tale ipotesi e le residenze sanitarie assistenziali ("RSA").
Il modello del cohousing (rispetto al quale il senior living può essere considerato una species) viene così descritto dal Giudice:
"Detto modello coabitativo segue essenzialmente le direttrici dell’incoraggiamento della socialità, dell’aiuto reciproco, dei rapporti di buon vicinato, della riduzione della complessità della vita, della sua migliore organizzazione con conseguente diminuzione dello stress, della riduzione dei costi di gestione delle attività quotidiane. L’esperienza è caratterizzata da un alto livello di condivisione delle scelte, da legami di collaborazione e socialità, dalla condivisione di molti spazi e servizi".
Data tale essenziale definizione il TAR ha affermato il "principio" per cui:
"Deve quindi escludersi la ricorrenza del “cohousing” quando la residenza delle persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti a tutela degli utenti, nel caso di specie, dalla L.R. Lazio n. 41 del 2003) da parte di terzi, dai quali dipenda (anche solo parzialmente) l’organizzazione dell’ambiente"
Nel caso di specie, peraltro, la sentenza valorizza anche taluni elementi quali:
- le condizioni di salute dei residenti (od ospiti, nella prospettiva della ipotizzata elusione della disciplina sulle RSA), "solo parzialmente autosufficienti";
- la presenza di un servizio di attività assistenziale continuativa di un operatore qualificato;
- la sproporzione tra il canone di locazione versato dagli utenti ed il valore "immobiliare" intrinseco, tale da rivelare la centralità dei "servizi" prestati nel sinallagma contrattuale;
- l'attività di intermediazione svolta, nell'intera operazione, dal medesimo soggetto che poi avrebbe prestato l'attività di "assistenza sanitaria".
A fronte di simile quadro fattuale il TAR Lazio ha quindi ritenuto legittima la qualificazione operata dalla PA (secondo cui non si sarebbe trattato di un cohousing ma di una, abusiva, RSA) rigettando il ricorso dei residenti (facendo salva, però, la possibilità di ristabilire condizioni abitative "depurate" dagli elementi assistenziali illegittimamente esercitati nella "struttura").
La decisione risulta di sicuro interesse, giacché porta all'attenzione degli Operatori (ma anche del Legislatore) la necessità di una disciplina atta a regolare con maggiore certezza un settore in forte espansione che, giocoforza, viene a trovarsi in una zona grigia tra mera funzione residenziale e servizi/sanità.
Ciò, chiaramente, con ulteriori connessi profili laddove il tema sia indagato anche sul versante strettamente urbanistico, oltre che su quello contrattuale.